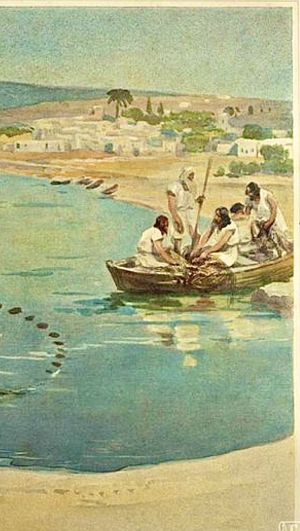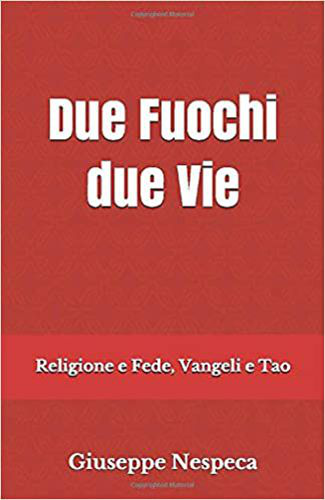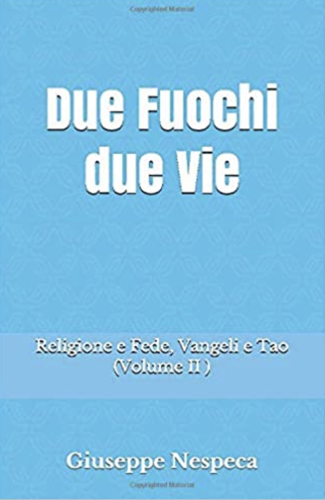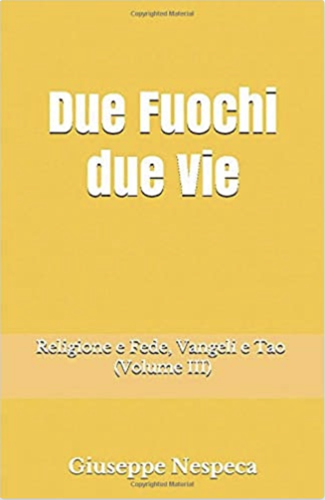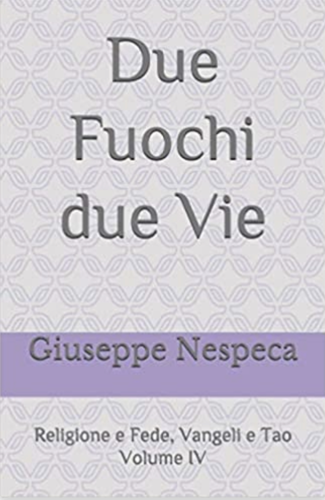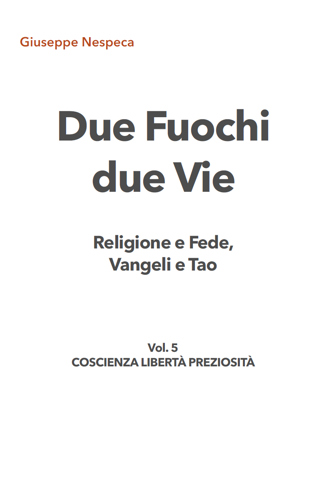don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Il male non è una forza anonima. Limite delle liberazioni umane
Dobbiamo essere ben coscienti che il male non è una forza anonima che agisce nel mondo in modo impersonale o deterministico. Il male, il demonio, passa attraverso la libertà umana, attraverso l’uso della nostra libertà. Cerca un alleato, l’uomo. Il male ha bisogno di lui per diffondersi. È così che, avendo offeso il primo comandamento, l’amore di Dio, viene a pervertire il secondo, l’amore del prossimo. Con lui, l’amore del prossimo sparisce a vantaggio della menzogna e dell’invidia, dell’odio e della morte. Ma è possibile non lasciarsi vincere dal male e vincere il male con il bene (cfr Rm 12, 21). È a questa conversione del cuore che siamo chiamati. Senza di essa, le «liberazioni» umane tanto desiderate deludono, perché si muovono nello spazio ridotto concesso dalla ristrettezza di spirito dell’uomo, dalla sua durezza, dalle sue intolleranze, dai suoi favoritismi, dai suoi desideri di rivincita e dalle sue pulsioni di morte. La trasformazione in profondità dello spirito e del cuore è necessaria per ritrovare una certa chiaroveggenza e una certa imparzialità, il senso profondo della giustizia e quello del bene comune. Uno sguardo nuovo e più libero renderà capaci di analizzare e di mettere in discussione sistemi umani che conducono a vicoli ciechi, per andare avanti tenendo conto del passato, per non ripeterlo più con i suoi effetti devastanti. Questa conversione richiesta è esaltante perché apre delle possibilità facendo appello alle innumerevoli risorse che abitano il cuore di tanti uomini e donne desiderosi di vivere in pace e pronti ad impegnarsi per la pace. Ora essa è particolarmente esigente: si tratta di dire no alla vendetta, di riconoscere i propri torti, di accettare le scuse senza cercarle, e infine di perdonare. Perché solo il perdono dato e ricevuto pone le fondamenta durevoli della riconciliazione e della pace per tutti (cfr Rm 12,16b.18).
[Papa Benedetto, Discorso all’Incontro in Baabda Libano 15 settembre 2012]
La bestemmia non consiste nell’offendere con le parole lo Spirito Santo
E quando predice ai suoi discepoli che li attende la persecuzione, con imprigionamenti e interrogatori, aggiunge: “Non preoccupatevi di ciò che dovrete dire, ma dite ciò che in quell’ora vi sarà dato: poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo” (Mc 13, 11). “Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire” (Lc 12, 12).
5. I Vangeli sinottici riportano un’altra affermazione di Gesù nelle sue istruzioni ai discepoli, che non può non impressionare. Riguarda la “bestemmia contro lo Spirito Santo”. Egli dice: “Chiunque parlerà contro il Figlio dell’uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato” (Lc 12, 10; cf. Mt 12, 32; Mc 3, 29). Queste parole creano un problema di vastità teologica ed etica maggiore di quanto si possa pensare, stando alla superficie del testo. “La “bestemmia” (di cui si tratta) non consiste propriamente nell’offendere con le parole lo Spirito Santo; consiste, invece, nel rifiuto di accettare la salvezza che Dio offre all’uomo mediante lo Spirito Santo, e che opera in virtù del sacrificio della croce . . . Se la bestemmia contro lo Spirito Santo non può essere rimessa né in questa vita né in quella futura, è perché questa “non-remissione” è legata, come a sua causa, alla “non-penitenza”, cioè al radicale rifiuto di convertirsi . . . Ora la bestemmia contro lo Spirito Santo è il peccato commesso dall’uomo, che rivendica un suo presunto “diritto” di perseverare nel male - in qualsiasi peccato - e rifiuta così la redenzione . . . (Esso) non permette all’uomo di uscire dalla sua autoprigionia e di aprirsi alle fonti divine della purificazione delle coscienze e della remissione dei peccati” (Dominum et vivificantem, 46). È l’esatto rovesciamento della condizione di docilità e di comunione col Padre, in cui vive Gesù orante e operante, e che egli insegna e raccomanda all’uomo come atteggiamento interiore e come principio di azione.
6. Nell’insieme della predicazione e dell’azione di Gesù Cristo, che scaturisce dalla sua unione con lo Spirito Santo-Amore, è contenuta un’immensa ricchezza del cuore: “Imparate da me, che sono mite e umile di cuore - egli esorta - e troverete ristoro per le vostre anime” (Mt 11, 29), ma è presente, nello stesso tempo, tutta la fermezza della verità sul regno di Dio, e quindi l’insistente invito ad aprire il cuore, sotto l’azione dello Spirito Santo, per esservi ammessi e non esserne esclusi.
In tutto ciò si rivela la “potenza dello Spirito Santo” e anzi si manifesta lo Spirito Santo stesso con la sua presenza e la sua azione di Paraclito, confortatore dell’uomo, confermatore della verità divina, debellatore del “padrone di questo mondo”.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 25 luglio 1990]
Chiusura alla misericordia
Gesù reagisce con parole forti e chiare, non tollera questo, perché quegli scribi, forse senza accorgersene, stanno cadendo nel peccato più grave: negare e bestemmiare l’Amore di Dio che è presente e opera in Gesù. E la bestemmia, il peccato contro lo Spirito Santo, è l’unico peccato imperdonabile – così dice Gesù –, perché parte da una chiusura del cuore alla misericordia di Dio che agisce in Gesù.
[Papa Francesco, Angelus 10 giugno 2018]
Traversata ardua, Felicità non scadente
La Chiamata dei pescatori
(Mt 4,12-23)
Non è la chiamata del capo, ma l’invito dell’Amico, che vive in prima persona ciò che predica, esponendosi.
Ad Abramo Dio dice «Va’ nella terra che ti indicherò». Gesù non dice «Andate», bensì «Venite»: è Lui che rischia e precede avanti, porgendosi come Agnello.
Abramo è solo un inviato; il discepolo di Cristo in cammino ripropone una Persona in relazione e tutta la sua vicenda.
«Pescatori di uomini»: il senso dell’espressione è più chiaro in Lc 5,10 [testo greco]: la nostra missione è sollevare alla vita coloro che non respirano più, soffocano, avvolti da onde impetuose, da forze di negatività.
Tirarli fuori da gorghi inquinati dove si vive in modo disumanizzante. Collocare tutti in un’acqua trasparente, con valori che non sono più quelli della società ripiegata e corrotta degli astuti.
Il Figlio di Dio chiama per invitarci a tagliar via ciò che degrada l’esperienza della pienezza personale. Egli promuove in ciascuno il dna del Dio che non crea competizione, bensì comunione.
Fondamentale è abbandonare le «reti»: ciò che avviluppa e impedisce, blocca. Anche la «barca», ossia il modo di gestire il lavoro.
Persino il «padre», che in famiglia trasmetteva la tradizione, le consuetudini (che rischiavano di offuscare la Luce nuova).
Tutte maglie da spezzare. Significa: un nuovo approccio, anche se si continua a svolgere la vita precedente.
I valori non sono più statici e banali [ricerca del consenso, sistemarsi...]: sfavillii fatui, che inculcano idoli esteriori, regolanti e uniformanti.
Per dare questi nuovi impulsi Gesù sorvola i palazzi di corte, dai quali non sarebbe nato nulla.
Neppure designa qualcuno col titolo che spetta a Lui solo: «Pastore».
Abbiamo bisogno di attenzione, non di direttori e capi che giudicano, o binari che non ci riguardano; né di modelli mentali inutili.
La donna e l’uomo d’ogni tempo hanno necessità solo di sostegno sapiente; compagni di viaggio che aiutano a scoprire i propri lati nascosti, incogniti, segreti, che possono fiorire.
La dimensione Persona è essenziale.
Certo, bisogna distrarre la mente dal conosciuto, e intraprendere la Via del “più in là”: nessuna scorciatoia priva d’incognite.
Strada percorsa a piedi, che cambia la propria e altrui atmosfera mentale; che sorvola il modo usato, qualunquista, esterno, di vedere le cose.
Qui, stando nella nostra Chiamata e naturalezza, saremo noi stessi a tutto tondo. E ci sorprenderemo.
Ciò nell’azzardo dell’Amore imprevedibile: solo così in grado di contattare i propri stati profondi, conoscersi; quindi realizzare sogni inattesi di vita aperta e completa, attivare energie sopite.
E come Gesù, in grado di mettere in azione chiunque s’incontra - recuperando i lati opposti e le eccentricità, per un ideale totale.
Tratto speciale: volgersi a tutta la terra, persino i nemici. Senza presunzione, senza preclusione alcuna.
In Cristo, non c’è più imperfezione, sbaglio o condizione malferma che possa tenerci distanti.
Ciascuno è indispensabile e prezioso. Tutti sono legittimati. Nessuno deve espiare.
Apertura, non sforzo.
[3.a Domenica T.O. (anno A) 25 gennaio 2026]
Conversione, Chiamata, Regno Vicino
(Mt 4,12-23)
Conversione e Regno Vicino
Accogliere e non trasferire valutazioni
(Mt 4,12-17)
Il Regno è vicino se grazie al nostro coinvolgimento Dio viene sulla terra e la felicità bussa alla porta, convertendoci a qualcosa di profondamente nuovo: scelte di luce in vece del giudizio, del possesso, dell’esercizio del potere, dello sfoggio di gloria.
Il Vangelo di Mt è stato scritto per sostenere le comunità di Galilea e Siria, composte di giudei convertiti, i quali soffrivano le accuse d’aver tradito le promesse del Patto e accolto i pagani.
Scopo del testo è far emergere la figura di Gesù Messia [non più il figlio di Davide] che reca salvezza, dispiegata oltre i perimetri: non solo al popolo eletto e agli osservanti dei suoi cliché normativi.
Egli non esclude nessuno, e tutti devono sentirsi adeguati.
Già nella genealogia iniziale, Mt preannuncia l’ecclesiologia universale del nuovo Rabbi qual fonte di benedizione ampia, anche fuori d’Israele e le osservanze.
Realtà non ambiziosa, alternativa all’Impero o alla vita di culture ristrette - assolutamente non allestita né retta da noi.
Per incoraggiare i suoi fedeli a non temere di essere esclusi, e riconoscersi nel Maestro, l’evangelista ribadisce appunto il criterio di redenzione senza confini.
Lo fa nel testo dei Magi e in quello in oggetto: una salvezza proposta come in viaggio, e senza troppo battagliare contro.
La triste situazione dei tempi antichi (vv.14-16) è alle spalle.
Persino nel Discorso de «il Monte» - al quale Mt 4 prepara l’uditorio - l’autore evangelista sottolinea lo specifico della vocazione delle fraternità cristiane.
Loro tratto speciale: volgersi a tutta la terra, persino i nemici. Senza presunzione, senza preclusione alcuna.
In Cristo, non c’è più imperfezione, sbaglio o condizione malferma che possa tenerci distanti.
Ciascuno è indispensabile e prezioso. Tutti sono legittimati. Nessuno deve espiare.
In tal guisa, la Chiamata a non sentirsi emarginati, la Vocazione a non trascurarsi e non trascurare, viene ribadita in modo diffuso in tutto il libro.
L’Araldo autentico e divino non alza il tono né il ritmo, non spezza la canna incrinata (Mt 12,2-3), supera le frontiere di purità e razza.
Tale la base della buona formazione degli intimi; nessun gap culturale, etnico, né di bagaglio religioso.
Il giovane Annunciatore poi invia i discepoli a tutti i popoli - nello stile dell’aprirsi senza remore, e non fare gli schizzinosi.
L’idea compiuta di ciò che oggi chiameremmo “cultura dell’incontro”, nasceva già nel confronto con la realtà interna della scuola del Battista.
Il figlio di Zaccaria ed Elisabetta pretendeva essere in grado di ben preparare la Venuta del Regno. Viceversa, esso permaneva imprevedibile.
Un ambiente - quello di Giovanni - in cui l’Annuncio non era unicamente positivo, né sempre pieno di vita e solo di gioia e accoglienza: spesso di giudizio e taglio netto.
Il Battezzatore non legittimava pienamente la spontaneità, i modi propri di ciascuno. Non spegneva i timori; né le paure di ogni anima perplessa, di poter essere “sbagliata”.
Invece, se il Regno dalle sfaccettature inattese è qui, non c’è che da viverlo appieno e con stupore.
Al seguito del Battista [e allievo, insieme ai suoi primi discepoli] il nuovo Maestro aveva colto in modo definitivo la differenza tra dinamiche ascetiche riduzioniste e il progetto di salvezza del Padre.
Stimolo verso un’umanizzazione a tutto tondo - fondata sullo scambio di doni, la libertà creativa dell’amore, e uno spirito di larga comprensione.
La missione luminosa e di carattere universale del Figlio di Dio non viene capita se non da pochissimi - tutta gente fragile e di poco conto - e tardava ad affermarsi.
È la condizione dei fedeli cui si rivolge Mt.
Gli amici del Signore non devono lasciarsi andare, se non riescono a convincere tutti, immediatamente.
Troppo difficile far credere ai religiosi veterani e alle loro realtà consolidate che nessuno ha l’esclusiva.
Anche i forti e sicuri di sé devono solo accettare la Vita che viene - figuriamoci deboli ed erranti.
Ma sino a quando lo stesso Precursore non viene imprigionato e messo a tacere, anche il Messia autentico vive quasi all’ombra dell’ultimo dei Profeti antichi (cf. Gv 3,22-23).
Poi si vede costretto a fuggire persino dal suo piccolo villaggio, tradizionalista e nazionalista (Mt 4,12-13.25).
Nessuno riusciva a credere ad un Regno senza grandi proclami e ardue condizioni.
Sembrava impossibile che l’Eterno potesse condividere la sua vita a maglie larghe; già fra noi, così ordinaria e niente di eccezionale.
Come fosse un Padre che trascende ma ci accosta tutti, senza previe condizioni di purità.
Sembrava improbabile passare dall’idea d’imminenza dell’impero di potenza annunciato, a una sua presenza quotidiana e non clamorosa.
A maggior ragione - tutto ciò, nella Persona del Messia servitore; non giustiziere, né capo, o vendicatore autosufficiente.
Vicinanza tanto dimessa, nulla di clamoroso, proprio al pari dei suoi amici, convertiti appunto dal giudaismo popolare e dal paganesimo.
Per animare le chiese in un momento critico, Mt fa emergere nella stessa vicenda del Signore il vissuto caratteristico e i medesimi picchi di discriminazione patiti dai poveri membri delle sue minuscole fraternità.
Al pari di Gesù, essi non dovevano lasciarsi prendere da spavento, condanne, grettezza d’idee separatiste e distintive, né dal sentirsi minoranza - o da timori per i rischi di persecuzione.
Infatti, i rinati da tale Spirito largo non dovevano soffocare più le loro tendenze, inclinazioni innate, percependo la mente e le capacità naturali come conflitto da aggiustare secondo modelli.
Non siamo chiamati a una piccola e stagnante delega, bensì a essere Luce e Presenza - in movimento - verso noi stessi e le moltitudini che riconosciamo dentro e fuori di noi (vv.23-25).
Anche con Fede silenziosa e non forsennata.
Il Carattere sapienziale innato trasmesso da Dio creatore a ciascuno può affiorare ovunque, nell’autenticità dell’Evangelo.
La Parola valica i sacri confini: in specie quando essa si fa eco non artificioso della nostra essenza, e richiamo dell’istinto bonario.
È una Voce nuova: che ricompone l’intima energia di tutti, e dispiega la sua Guida superiore.
Appello radicale che in ogni donna e uomo indirizza e compie persino i disturbi - un mondo che ci appartiene, solo apparentemente inferiore.
E va oltre l’assoluto pio dei piani esclusivi o delle mortificazioni.
Una realtà che non trasferisce valutazioni al di là della persona - ma la sa attendere e non detta procedure, misure, cadenze altrui; elettive.
Nessun primo piano, neppure religiosamente “corretto”.
Apertura, non sforzo.
Commentando il Tao Tê Ching (i) il maestro Ho-shang Kung afferma: «Mistero è il Cielo. Dice che tanto l’uomo che ha desideri quanto quello che non ne ha, ricevono parimenti il ch’ì dal Cielo».
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Come puoi evitare le chiusure culturali, dottrinali o di carisma (già tutto progettato-regolato), e vivere l’universalità della nuova umanizzazione?
Qual è il metro di valutazione con cui la tua realtà ecclesiale approccia i diversi?
Significato di “Vangeli”, e Guarigione integrale
Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del Regno di Dio e nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in mezzo a noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva preannunciato che quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro glorioso: il popolo immerso nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). Il termine "vangelo", ai tempi di Gesù, era usato dagli imperatori romani per i loro proclami. Indipendentemente dal contenuto, essi erano definiti "buone novelle", cioè annunci di salvezza, perché l'imperatore era considerato come il signore del mondo ed ogni suo editto come foriero di bene. Applicare questa parola alla predicazione di Gesù ebbe dunque un senso fortemente critico, come dire: Dio, non l'imperatore, è il Signore del mondo, e il vero Vangelo è quello di Gesù Cristo.
La "buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è vicino" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato nello spazio e nel tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante il suo Figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.
Preghiamo Maria Santissima, affinché ottenga sempre alla Chiesa la stessa passione per il Regno di Dio che animò la missione di Gesù Cristo: passione per Dio, per la sua signoria d'amore e di vita; passione per l'uomo, incontrato in verità col desiderio di donargli il tesoro più prezioso: l'amore di Dio, suo Creatore e Padre.
[Papa Benedetto, Angelus 27 gennaio 2008]
Traversata ardua, Felicità non scadente
La Chiamata dei pescatori
(Mt 4,18-23)
Non è la chiamata del capo, ma l’invito dell’Amico, che vive in prima persona ciò che annuncia, esponendosi.
È lui che rischia e precede, porgendosi come Agnello. Non si mette seduto a fare lezione e insegnare dottrine.
La sua «Lieta Notizia» [Mc 1,15] rivela un volto divino opposto a quello predicato dalle guide ufficiali: il Padre non assorbe le nostre energie, ma le dona in pienezza e gratis.
«Convertitevi perché si è fatto vicino il Regno dei cieli» (v.17) è celebre il parallelo di Mc: «Convertitevi e credete nel Vangelo».
Entrambe le espressioni, di fatto, endiadi: ad es. i due termini coordinati «convertitevi e credete» esprimono un medesimo significato.
Ma non in senso separatista o dottrinale.
In breve:
Il Regno è vicino se grazie al nostro coinvolgimento Dio viene sulla terra per sostituire il tran-tran, e la felicità bussa alla porta.
Trasformazione che giunge; mutamento che irrompe. Non lo si progetta addirittura nei minimi dettagli; non lo si edifica come fosse una impalcatura.
Esso ci volge a qualcosa di profondamente nuovo: scelte di luce in vece del giudizio, del possesso, dell’esercizio del potere, dello sfoggio di gloria.
Il Battista pretendeva preparare la Venuta del Messia; Gesù proclama il Regno già accanto e profondamente conforme agli uomini - presente, quindi semplicemente da accogliere, per vivere appieno.
Al seguito di Giovanni [allievo, insieme ai suoi primi discepoli] il nuovo Maestro aveva colto in modo definitivo la differenza tra dinamiche ascetiche - riduzioniste - e il progetto di salvezza del Padre.
Stimolo verso un’umanizzazione a tutto tondo fondata sullo scambio di doni, la libertà creativa dell’amore, e uno spirito di larga comprensione.
La missione luminosa e di carattere universale del Figlio non viene capita se non da pochissimi - tutta gente fragile e di poco conto - e tarda ad affermarsi.
Troppo difficile far credere ai religiosi giudaizzanti di lungo corso e alle loro realtà consolidate che nessuno ha l’esclusiva: tutti devono solo accettare le nuove Promesse del Patto.
Sino a quando Giovanni [ancora più celebre del Cristo persino durante la sua vita pubblica] non viene imprigionato e messo a tacere, il Figlio di Dio vive quasi all’ombra del Precursore (cf. Gv 3,22-23).
Poi si vede costretto a fuggire anche dal suo piccolo villaggio, tradizionalista e nazionalista (Mt 4,12-13).
Nessuno poteva credere a una realtà divina senza grandi proclami e ardue condizioni.
Nessuno avrebbe immaginato una Gerusalemme diffusa, già fra noi, così spontanea, ordinaria e a maglie larghe - che trascende ma ci accosta tutti.
Troppo difficile passare dall’idea d’imminenza dell’impero di potenza, a una sua Presenza unitiva, non clamorosa - nella Persona d’un Messia servitore, non giustiziere autosufficiente.
Vicinanza tanto dimessa, niente di eccezionale, al pari dei suoi fedeli - “convertiti” sia dalla religione dei padri che dal paganesimo, perciò emarginati.
Nel Primo Testamento la Galilea compare solo di sfuggita, perché i Giudei osservanti non ne apprezzavano la contaminazione di credenze.
Eppure, quella regione di persone sospette diventa la terra del cambiamento di rotta.
In concreto, l’inatteso invito alla Conversione sul suolo di Galilea (v.18) significa: «Girate la scala di valori!».
C’è infatti una libertà da riconquistare, ma la scena è rapida, perché il giovane Maestro insegna non come fanno i saccenti: con la vita.
Ad Abramo Dio dice «Va’ nella terra che ti indicherò». Gesù non dice «Andate», bensì «Venite».
Abramo è solo un inviato; il discepolo di Cristo in cammino ripropone una Persona, tutta la sua vicenda.
Si interessa alla vita reale: non propugna il ritorno al Tempio, alla religione antica, al culto che avrebbe dovuto rabberciarne la pratica già riconosciuta.
In tal guisa, ecco i primi chiamati: da «pescatori» a «pescatori di uomini» (vv.18-19). Il senso dell’espressione è più chiaro in Lc 5,10 [testo greco].
La nostra missione è sollevare alla vita coloro che non respirano più, e soffocano, avvolti da onde impetuose (le forze della negatività).
Vero compito dell’Apostolo è tirar fuori ciascuno dall’ambito inquinato, dove si vive in modo disumanizzante.
E collocare tutti in un’acqua trasparente, con valori che non sono più quelli della società ripiegata e corrotta - habitat di blocchi ossessivi, utile solo a forti, svelti e astuti.
Il Figlio di Dio chiama per invitarci a tagliar via ciò che degrada l’esperienza della pienezza personale.
Egli promuove in ciascuno il dna del Dio comunionale. Trasmesso interiormente e senza condizioni.
[Commentando il passo del Tao Tê Ching (LXV), il maestro Ho-shang Kung sottolinea:
«L’uomo che possiede la misteriosa virtù è contrapposto e diverso dalle creature: queste vogliono accrescere se stesse, la misteriosa virtù conferisce agli altri»].
Fondamentale è abbandonare le «reti» (v.20): ciò che avviluppa, impedisce, arresta. Anche la «barca» (v.22), ossia il modo di gestire il lavoro.
Persino il «padre» (v.22): la tradizione imposta, che offusca la Luce nuova.
Tutte maglie da spezzare.
Infatti il Signore deve iniziare ben lontano dalla regione osservante e dalla città santa - Giudea, Gerusalemme capitale.
Significa un nuovo approccio, anche se in esso si può continuare a svolgere la vita precedente.
Ma i valori non sono più statici e banali: ricerca del consenso, sistemarsi, trattenere per sé; così via.
Sfavillii fatui, che inculcano idoli esteriori.
Troppo “regolari” e normali, uniformanti; senza unicità né picchi decisivi. Essi pongono mille ostacoli alla libera espressione che ci spetta.
Per dare questi inauditi impulsi Gesù non sceglie ambienti sacrali e persone forse devote che non saprebbero rigenerare nessuno.
Sorvola i palazzi di corte, dai quali non sarebbe nato nulla (cf. Gv. 4,1-4).
Neppure designa qualcuno col titolo che spetta a Lui solo: «Pastore».
E ancora oggi non si capisce perché tutte le tradizioni denominazionali si sono (poi immediatamente) riempite di “pastori”, ossia guide, insegnanti, direttori del “gregge”.
Abbiamo bisogno di attenzione, non di dirigisti che giudicano e pongono sentenze d’inadeguatezza. Né desideriamo binari che non ci riguardano, modelli mentali inutili.
La donna e l’uomo d’ogni tempo hanno necessità solo di sostegno sapiente; di compagni di viaggio che aiutano a scoprire i lati nascosti, incogniti, segreti, che possono fiorire.
Maestri che ci lascino completare, consentendo alla personalità di sposare gli aspetti ancora in ombra.
Tale alleanza interiore sarà sorgente di realizzazione, senso di fiducia e pienezza di vita.
Ma a tale scopo bisogna che qualcuno ci insegni a distrarre la mente dal conosciuto, e così intraprendere la Via del “più in là”.
Certo, un pericolo per coloro che amano interpretare le cose con senso di permanenza: insomma, nessuna scorciatoia priva d’incognite.
Strada che cambia la propria e altrui atmosfera mentale; sorvola il modo usato, qualunquista, epidermico, di vedere le cose.
Qui, stando nella nostra Chiamata e naturalezza, saremo noi stessi a tutto tondo. E ci sorprenderemo.
Eccoci nell’azzardo del Dono accolto: solo così in grado di contattare i nostri stati profondi; conoscersi, quindi realizzare sogni inattesi di esperienza aperta e completa.
Appunto, attivando energie sopite.
Come Gesù, in grado di mettere in azione chiunque s’incontra; recuperando i lati opposti e le eccentricità, per un ideale umanizzante, totale.
Dice la Sapienza naturale, nel Tao Tê Ching (LXV):
«In antico chi ben praticava il Tao [la Via], con essa non rendeva perspicace il popolo, ma con essa si sforzava di renderlo ottuso».
La tematica - dal punto di vista biblico evangelico - è appunto in chiave di Esodo: chiara l’allusione al «mare» [v.16; in realtà un lago].
Pertanto, la «Conversione» in avanti che il nuovo Rabbi propone non è un movimento ad U - come spesso si dice.
«Conversione» non riguarda il ritorno devoto al culto e al Tempio, ma un cambio di mentalità e orientamento.
E «Regno di Dio» non allude a un mondo “nei” Cieli: non si parla di aldilà, ma di ambiti in cui si vivono le Beatitudini.
«Conversione»? Autentica, senza i castighi della religione che mortifica. Né - come poi purtroppo avverrà - la sottomissione delle coscienze.
Ovvio, neppure soggezione alcuna al giro dei profitti senza condivisione.
L’ottusità del potere antico, andante, insulso, provinciale - anche di venatura ecclesiastica - è credere che a una voce di denuncia non possa subentrare un Araldo più incisivo.
Invece sì (vv.11-12).
In Cristo lanceremo cambiamenti radicali, facendo emergere e attivando nella gente consapevolezze che valgono e durano nel tempo.
Non più quell’insistere nella ricerca di sicurezze finte, patinate, glamour o di carta pesta, ma un saper trasmettere vita, prendendosi tutti i rischi dell’amore.
La Fede si staglierà ovunque sulla devozione omologante, buona per tutte le stagioni. Per il fatto che non progetta una stasi ulteriore, bensì un Cammino senza posa.
Via, patria, e modo di vedere il mondo, disancorati dalle certezze di scarso peso specifico: infine producono situazioni tanto rassicuranti quanto scadenti.
Allora saremo noi stessi a tutto tondo nella potenza dello Spirito [cf. passo parallelo Lc 4,14] ossia nell’incognita dell’Amore imprevedibile.
E nel rischio della contaminazione: solo così in grado di realizzare anche gli altrui sogni di vita aperta e completa, che va oltre (Lc 4,15).
Come Gesù, e in Lui, per i fratelli. Col suo nuovo modo di attivarsi e marciare.
Non: tenute all’indietro, onde “predisporre” assicurazioni e quel mettere a punto secondo cliché di maniera.
Rotta in avanti senza più i retroscena: ogni traiettoria è personale.
Orientamento che ci trascina in esplorazione e azione, verso un ideale totale.
Apertura, non sforzo.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Tieni alle assicurazioni? Quali certezze devi ancora lasciare alle spalle?
Coltivi aperture vitali?
Nella Chiesa senti vicinanza e vita in avanti?
O prevalgono i retroscena, i giudizi fatti, le catalogazioni, l’anonimato, lo sfoggio, il distacco?
Se incontrassi Gesù che cammina, percorre, va oltre: come e secondo quali inclinazioni pensi che la tua sterilità potrebbe diventare feconda?
Futuro “glorioso”, che reca vita
Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto questo anno liturgico, presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del Regno di Dio e nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in mezzo a noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva preannunciato che quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro glorioso: il popolo immerso nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). Il termine "vangelo", ai tempi di Gesù, era usato dagli imperatori romani per i loro proclami. Indipendentemente dal contenuto, essi erano definiti "buone novelle", cioè annunci di salvezza, perché l'imperatore era considerato come il signore del mondo ed ogni suo editto come foriero di bene. Applicare questa parola alla predicazione di Gesù ebbe dunque un senso fortemente critico, come dire: Dio, non l'imperatore, è il Signore del mondo, e il vero Vangelo è quello di Gesù Cristo.
La "buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è vicino" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato nello spazio e nel tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante il suo Figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.
Preghiamo Maria Santissima, affinché ottenga sempre alla Chiesa la stessa passione per il Regno di Dio che animò la missione di Gesù Cristo: passione per Dio, per la sua signoria d'amore e di vita; passione per l'uomo, incontrato in verità col desiderio di donargli il tesoro più prezioso: l'amore di Dio, suo Creatore e Padre.
[Papa Benedetto, Angelus 27 gennaio 2008]
Chiamata: nuova Creazione e lavoro dedicato, si integrano
Cari fratelli e sorelle.
1. […] Carissimi, il trovarci qui, nell’Abbazia di Pomposa, dove - fin dal secolo IX - numerose persone vissero insieme, per porsi alla sequela esclusiva di Cristo, mi offre l’occasione per ricordare che ogni cristiano, e anche ognuno di voi, è chiamato a ripercorrere le tracce del Figlio di Dio.
Il lavoro ascetico e quello materiale dei monaci fu, infatti, sempre in funzione della crescita religiosa e umana anche delle popolazioni di questa zona. E la bellezza artistica dell’Abbazia esprime la verità, la libertà e la dignità dell’uomo che lavora cristianamente.
Qui ci è dato di constatare con chiarezza che il “lavoro non deve essere una pura necessità, ma deve essere considerato come autentica vocazione, una chiamata di Dio a costruire un mondo nuovo, nel quale coabitano la giustizia, la fratellanza, anticipo del regno di Dio, nel quale non vi saranno né carenze né limitazioni” (Discorso agli operai, 30 gennaio 1979).
2. Alcuni fra voi potrebbero chiedersi come sia possibile rendersi conto del dono sublime che è la vocazione a figli del Signore onnipotente. Molte sono le difficoltà, che l’uomo incontra nel riconoscere il disegno di Dio nella propria vita. Oltre l’amor proprio, che lo spinge a rinchiudersi in se stesso, fanno spesso da ostacolo le condizioni della vita sociale, frequentemente concepita e strutturata prescindendo da Dio, il quale - purtroppo - viene considerato da tanti come estraneo agli interessi autenticamente umani.
Eppure Cristo, che ha chiamato il santo abate Guido, san Pier Damiani, Guido d’Arezzo e i molti altri monaci, il nome dei quali non è a noi noto, rivolge ugualmente a voi il suo invito, perché nel vostro contesto di vita quotidiana e lavorativa possiate accogliere il suo invito a seguirlo.
Ci si potrebbe allora domandare: “Quale forma deve prendere la vocazione del fedele laico, che vive e opera nel mondo?”. Configurato a Cristo mediante il Battesimo, ogni credente è testimone della misericordia divina, che, come ha rigenerato noi, mediante noi ricrea ogni cosa, associandoci al disegno di “ricapitolare in Gesù tutte le cose” (Ef 1, 10).
In questa “nuova creazione” il cristiano è chiamato a lavorare con “il Verbo della vita” (1 Gv 1, 1). Nella condizione laicale che gli è propria, egli si pone con tenacia al proprio posto di lavoro, in terra o per mare, consapevole che, quanto sta compiendo, non è solamente cooperazione, ma unione con Cristo nella sua opera redentiva (cf. Gaudium et spes, 67).
3. La fede è dono e il credente, riconoscendo Dio come Padre, raggiunge la pienezza della propria umanità: egli, allora, sa vivere e morire, sa sperare, sa amare, diffondendo attorno a sé la serenità e la pace. Contribuisce, così, alla costruzione della nuova terra e dei nuovi cieli (1 Pt 3, 13).
Vi esorto, fratelli e sorelle carissimi, a non porre resistenze a Cristo, a non rifiutare il Verbo che si è fatto carne. Accoglietelo piuttosto senza riserve, perché attorno a lui tutta l’esistenza umana e il mondo intero sono chiamati a raccogliersi in unità e a rinnovarsi.
L’Abbazia, nella quale ci troviamo, mostra, nella sua storia, come questo sia possibile. Il monaco, infatti - ben sapendo che la dipendenza religiosa da Dio non porta alla morte, ma realizza la vita nella sua pienezza - a lui si consacra in modo esclusivo. Nel ritmo scandito dall’“Ora et labora”, egli loda il Signore e indica al mondo verso Chi ciascuno di noi deve volgere costantemente lo sguardo e la mente. Segue il Cristo nella povertà, nell’obbedienza e nella consacrazione verginale; a lui si offre in modo totale e definitivo. Anche il fedele laico vive di Cristo se con lui si intrattiene nella preghiera, se lo incontra nei sacramenti e se gli manifesta il proprio amore con l’osservanza dei comandamenti.
L’orazione, personale e liturgica, e l’impegno morale sono intimamente connessi all’amicizia con il Redentore e al compito apostolico, missionario che ne consegue.
Cari fratelli, sentitevi sempre in profonda comunione con quanti nei monasteri incessantemente lodano il Signore e, sostenuti anche dalla loro preghiera, portate frutti di santità con una condotta di vita irreprensibile in ogni momento della vostra esistenza.
4. Questa solidarietà spirituale dimostra che il lavoro e il tempo dedicato esclusivamente a Dio non si contrappongono, ma si integrano, come possiamo ben vedere già nell’“Ora et labora” dei monaci di san Benedetto. La devozione a Dio (l’“ora”) fonda la dedizione autentica (il “labora”) agli uomini e alla terra, che è loro dimora.
In qualsiasi settore si svolge la vostra attività, voi siete chiamati sempre ad essere testimoni ed evangelizzatori, vale a dire a rendere visibile il Cristo, che “è stato rappresentato al vivo dinanzi a voi” (cf. Gal 3, 1). Il lavoro sgorga dalla preghiera, come la carità fluisce dalla fede. L’aderire a Cristo e l’abbandonarsi fiducioso nelle sue mani generano una totale disponibilità alla volontà divina.
Inoltre il lavoro, pur faticoso, quando è compiuto in stretta unione con Cristo, fa amare la vita non più vista come sorgente di inquietudini, ma come palestra di virtù che forma alla serenità e alla pace.
5. Fratelli e sorelle, vi invito, infine, a offrire il vostro generoso apporto alla nuova evangelizzazione, di cui tanto ha bisogno la società contemporanea e a operare attivamente per la diffusione del Vangelo nei vostri ambienti di lavoro. Portate a tutti quella speranza e quella solidarietà cui ogni uomo incessantemente anela e che solo in Cristo è possibile trovare. Nutritevi, sempre, di Dio e di un amore concreto che parli di lui a quanti incontrate. Affido ciascuno alla Vergine Maria perché sappiate come lei ascoltare, accogliere e custodire il Verbo fatto carne.
La consapevolezza della materna presenza della Madre di Dio, sia per voi e per le vostre famiglie quotidiano conforto e stimolo a ben operare.
Ancora una volta vi ringrazio per questo invito, per questo incontro molto suggestivo. Qui sono sempre presenti con la loro ispirazione i monaci benedettini che ci hanno lasciato il santuario. Ma qui, nello stesso tempo, durante i secoli, ha vissuto e vive una popolazione che, di generazione in generazione, si distingue soprattutto per il lavoro agricolo e per la pesca. Tutto ciò costituisce una sintesi speciale, direi evangelica. Sappiamo bene come nel Vangelo siano presenti coloro che lavorano la terra così come i pescatori, persone predilette da Gesù, trasformate in apostoli.
Oggi il Papa, il successore di Pietro, che era uno di questi pescatori, viene per dire a voi pescatori e a voi lavoratori della terra: siete chiamati a essere apostoli, non cambiando la vostra professione e le condizioni della vostra vita, ma seguendo Cristo, secondo le parole semplici e profetiche dell’Abbazia benedettina, di san Benedetto: “Ora et labora”. Ecco il vostro metodo nell’apostolato, il più semplice e il più efficace. Vi auguro che questo “Ora et labora” diventi per voi programma quotidiano e, nonostante tutte le difficoltà della vita agricola e di quella del mare, vi renda anche sereni, felici e portatori del bene verso gli altri.
[Papa Giovanni Paolo II, discorso a Pomposa, 22 settembre 1990]
Inizio della missione pubblica. Apertura, non sforzo
Il Vangelo di oggi (cfr Mt 4,12-23) ci presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Questo avvenne in Galilea, una terra di periferia rispetto a Gerusalemme, e guardata con sospetto per la mescolanza con i pagani. Da quella regione non ci si aspettava nulla di buono e di nuovo; invece, proprio lì Gesù, che era cresciuto a Nazaret di Galilea, incomincia la sua predicazione.
Egli proclama il nucleo centrale del suo insegnamento sintetizzato nell’appello: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questo annuncio è come un potente fascio di luce che attraversa le tenebre e fende la nebbia, ed evoca la profezia di Isaia che si legge nella notte di Natale: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che camminavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (9,1). Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato all’umanità la sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là dei nostri meriti. La vicinanza di Dio e l’amicizia di Dio non sono un merito nostro: sono un dono gratuito di Dio. Noi dobbiamo custodire questo dono.
L’appello alla conversione, che Gesù rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, si comprende in pienezza proprio alla luce dell’evento della manifestazione del Figlio di Dio, su cui abbiamo meditato nelle scorse domeniche. Tante volte risulta impossibile cambiare vita, abbandonare la strada dell’egoismo, del male, abbandonare la strada del peccato perché si incentra l’impegno di conversione solo su sé stessi e sulle proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito. Ma la nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, no. Credere questo anche sarebbe un peccato di superbia. La nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, deve invece esprimersi in un’apertura fiduciosa del cuore e della mente per accogliere la Buona Notizia di Gesù. È questa – la Parola di Gesù, la Buona Notizia di Gesù, il Vangelo – che cambia il mondo e i cuori! Siamo chiamati, pertanto, a fidarci della parola di Cristo, ad aprirci alla misericordia del Padre e lasciarci trasformare dalla grazia dello Spirto Santo.
È da qui che comincia il vero percorso di conversione. Proprio come è capitato ai primi discepoli: l’incontro con il Maestro divino, col suo sguardo, con la sua parola ha dato loro la spinta a seguirlo, a cambiare vita mettendosi concretamente al servizio del Regno di Dio.
L’incontro sorprendente e decisivo con Gesù ha dato inizio al cammino dei discepoli, trasformandoli in annunciatori e testimoni dell’amore di Dio verso il suo popolo. Ad imitazione di questi primi araldi e messaggeri della Parola di Dio, ciascuno di noi possa muovere i passi sulle orme del Salvatore, per offrire speranza a quanti ne sono assetati.
La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo in questa preghiera dell’Angelus, sostenga questi propositi e li avvalori con la sua materna intercessione.
[Papa Francesco, Angelus 26 gennaio 2020]
Crisi, Buona Novella e aspetto sociale
Superlavoro Missione Famiglia, da squilibrati
(Mc 3,20-21)
Il breve Vangelo di oggi può essere interpretato secondo diversi piani di lettura: iniziamo con un approccio vocazionale.
La famiglia nucleo della società dovrebbe configurarsi anche come un trampolino di lancio verso l’avventura di Fede che sollecita altri legami.
I consanguinei possono rimanere costernati dal nostro desiderio di darsi interamente a Dio nei fratelli.
E a volte gli affetti e i vincoli naturali possono impedire l’adempimento della Missione cui siamo chiamati.
Talora, anche importanti impegni nell’azione della Chiesa rimangono a metà o del tutto frustrati - causa un “debole” e impedimenti che non riusciamo a ‘tagliare’.
Veniamo al livello storico.
Gesù ha avuto bei problemi anche in casa sua, ma il brano di Vangelo si riferisce alla Chiesa nascente nella dimora di Pietro a Cafarnao, vicinissima alla Sinagoga.
Nel tempo, le due realtà quasi adiacenti si sono trovate a fronteggiarsi aspramente.
Eppure nella Dimora di Pietro a un certo punto esplode il numero dei provenienti dal giudaismo, nonché pagani, che si convertivano alla proposta del Signore.
Il Popolo stesso e la cultura religiosa che hanno generato Cristo [la sua «Famiglia»] faceva fatica a interrogarsi. E la prima reazione è stata di rifiuto.
Quella nuova porzione della stirpe giudaica che riconosceva Gesù Messia sembrava volesse fare sempre più di testa sua.
Aspetto sociale:
Effettivamente il focolare e il clan propri si erano allarmati, perché Gesù adulto non seguiva un comportamento da sottomesso.
Così i parenti decidono di riportarlo a forza (cf. vv.31-35) considerandolo uno squilibrato che logorava i loro rapporti interni e le relazioni con autorità sul territorio.
Ma le convinzioni ormai cristallizzate nella Sinagoga - nonché il portato teologico e ‘cordiale’ di tutta la sua realtà di compromesso - non sembravano più vitali. Perché?
Il sistema imperiale impiantato in Galilea aveva debilitato il senso di condivisione e fraternità. Chiusure rafforzate dalla religiosità dell’epoca.
L’osservanza sempre più accentuata delle norme di purezza era un fattore di grave emarginazione sociale e culturale.
Intere fasce di popolazione erano escluse dal rapporto con Dio: proprio quelle più bisognose di speranza, e di un ‘volto’.
Invece che promuovere accoglienza e partecipazione, le norme devote addirittura favorivano separazioni ed esclusioni.
Struttura politica, economica e sociale, e ideologia sacra, cospiravano a favore dell’indebolimento dei valori centrali dello spirito di comunione.
Nel passo di Vangelo di oggi si nota appunto come i limiti stretti della famiglia andassero a confliggere con la proposta del nuovo Rabbi, di recuperare l’afflato solidale.
Era insomma nella Casa di Pietro che la piccola famiglia acquisiva respiro, aprendosi non solo alla Nazione, bensì alla più ampia Famiglia umana.
Assemblea integrale, anche di donne e malfermi, o incerti e lontani.
Realtà assolutamente nuova; non più radunata per il culto ma incapace di fare ‘convivenza’.
[Sabato 2.a sett. T.O. 24 gennaio 2026]
Crisi e aspetto sociale
Superlavoro Missione Famiglia, da squilibrati
(Mc 3,20-21)
«E viene in Casa; e di nuovo si riunisce la folla, così che essi non potevano neppure mangiare Pane. E avendo udito, i suoi [i presso di lui] uscirono per prenderlo, perché dicevano: È fuori di sé».
Il breve Vangelo di oggi può essere interpretato secondo diversi piani di lettura: iniziamo con un approccio vocazionale.
La famiglia è nucleo della società di tutti i tempi, ma Cristo e il credente sanno che essa non deve costituire una gabbia.
Piuttosto dovrebbe configurarsi quale trampolino di lancio verso l’avventura della Fede, che sollecita altri legami.
La vita nello Spirito ci attiva per la costruzione del Centuplo, nella grande famiglia ecclesiale e umana.
I consanguinei possono rimanere costernati dal nostro desiderio di darsi interamente a Dio nei fratelli.
Di fronte all'attività estenuante si mettono in apprensione, perché procediamo sempre controcorrente… quindi i parenti stretti si preoccupano della nostra salute, o dell’onore di casa.
A volte, affetti e vincoli naturali possono impedire l’adempimento della Missione cui siamo chiamati.
Certo, quando a non capire sono proprio coloro da cui ci si aspetta più aiuto, la sofferenza si fa grande.
Talora, anche importanti impegni nell’azione della Chiesa rimangono a metà o del tutto frustrati - causa affetti e impedimenti che non riusciamo a tagliare.
Veniamo al livello storico.
Gesù ha avuto bei problemi anche in casa sua, ma il brano di Vangelo si riferisce alla Chiesa nascente nella dimora di Pietro a Cafarnao.
Realtà più istintiva e meno “qualificata”, però vicinissima alla tradizionale casa di preghiera [sinagoga] del luogo, collocata sulla medesima stradina perpendicolare al lago, appena poco più in alto.
Nel tempo, le due realtà quasi adiacenti si sono trovate a fronteggiarsi aspramente nella teologia - sino a competere perfino sul piano architettonico, come ben sanno gli archeologi.
La più “nobile” e antica delle due accusava l’altra di essere una sradicata - quindi inaccettabile, eccentrica per le sacre consuetudini identitarie del popolo eletto.
Eppure nella Dimora di Pietro a un certo punto esplode il numero dei provenienti dal giudaismo, nonché pagani che si convertono alla proposta del Signore.
Così la prima comunità dei credenti nel Signore inizia a essere forse più più corposa dell’assemblea in Sinagoga, a pochi passi.
Il Popolo stesso e la cultura religiosa che hanno generato Cristo [la sua «Famiglia»] faceva fatica a interrogarsi. E la prima reazione è di rifiuto.
Quella porzione della stirpe giudaica che riconosceva Gesù Messia sembrava volesse fare sempre più di testa sua.
Aspetto sociale:
Effettivamente il focolare e il clan propri si erano allarmati, perché Gesù adulto non seguiva un comportamento da sottomesso.
Comprometteva il nome del suo casato, spendeva energie per gli altri - sino a sfinire… assurdamente in favore di estranei, forse “nemici” della nazione giudaica.
Così i parenti decisero di riportarlo a forza (vv.31-35) considerandolo uno squilibrato che logorava i rapporti interni e le relazioni dell’intera dinastia con le autorità sul territorio.
Ma sappiamo che allargando il legame di “sangue” a coloro che ascoltano, Gesù non permise che fossero valutazioni esterne ad allontanarlo dal suo compito.
Vediamo quale era la situazione.
Nell’antico Israele il senso di comunità e il clan costituivano la base della convivenza. L’obbiettivo della Legge era: «Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi» (Dt 15,4).
E come i grandi profeti, Cristo e i suoi intimi hanno tentato di rafforzare il senso di condivisione, tornando allo spirito profondo di ciò che un tempo erano articolazioni della coesistenza.
Appunto: clan, focolare, comunità - espressioni dell’amore di Dio che si manifesta.
La “grande Famiglia” assicurava protezione alle famiglie particolari e alle persone meno abbienti.
Essa era garanzia di proprietà della terra; quindi dava senso di libertà - e si faceva veicolo della possibilità di aderire alla propria tradizione.
Oltre che difesa di carattere culturale, era nella vita comunitaria che la gente di quell’epoca esprimeva lo spirito di solidarietà concreta.
Anche per Cristo, difendere il clan, il suo bagaglio spirituale, la sua azione fraterna... era difendere la stessa Alleanza.
Ma la Casa di Pietro [la Chiesa nascente] iniziava a sopravanzare tutta la realtà antica.
Le convinzioni ormai cristallizzate nella Sinagoga, nonché il portato teologico e benevolo di tutta la sua verità di compromesso - non sembravano più vitali. Perché?
Il sistema imperiale impiantato in Galilea aveva debilitato il senso di comunione larga e minuta, appunto di clan e focolare.
Erode il Grande - morto a Gerico nel 4 a.C. - e suo figlio Erode Antipa (37a.C.-39d.C.) avevano portato le famiglie a un livello di crisi tale da dover badare a se stesse e chiudersi nelle necessità più impellenti.
Le imposte da pagare al governo e al tempio erano sempre più esose, il che accentuava l’indebitamento.
Qua e là la mentalità ellenista s’insinuava con tratti d’individualismo prima sconosciuti alla mentalità semitica.
Il dovere imposto di accogliere le soldatesche e dare loro ospitalità in casa dove facevano quello che volevano anche sulle donne, e le frequenti minacce di repressione violenta, obbligavano la gente a dover badare a problemi di sopravvivenza.
Tutto ciò induceva alla chiusura, al ripiegamento sulle proprie necessità immediate.
Si praticava sempre meno l'ospitalità, la condivisione dei beni, quella della mensa, e l’asilo dei marginali. Espressioni di fraternità e cura in cui già i primi cristiani erano campioni.
In tal guisa, le chiusure erano rafforzate dalla religiosità dell’epoca.
L’osservanza sempre più accentuata delle norme di purezza costituiva un fattore di grave emarginazione sociale e culturale.
Intere fasce di popolazione venivano escluse dal rapporto con Dio: proprio quelle più bisognose di speranza, e di un volto.
Invece che promuovere accoglienza e compartecipazione, le norme devote addirittura favorivano separazioni ed esclusioni [in particolare: tutte le donne, i bambini, stranieri, malati o impediti...].
Struttura politica, economica e sociale, e ideologia sacra, cospiravano a favore dell’indebolimento dei valori centrali dello spirito, e la pratica di mettere in comune.
Nel passo di Vangelo di oggi si nota appunto come i limiti stretti della famiglia nucleare andassero a confliggere con la proposta del nuovo Rabbi: di recuperare l’afflato unitivo, sia in senso largo che di dettaglio.
Era insomma nella Casa di Pietro che la piccola famiglia acquisiva respiro, aprendosi non solo alla Nazione, bensì alla più ampia Famiglia della Comunità umana.
Assemblea integrale, anche di donne e malfermi, o incerti e lontani.
Realtà assolutamente nuova, non più radunata per il culto ma incapace di fare convivenza.
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.