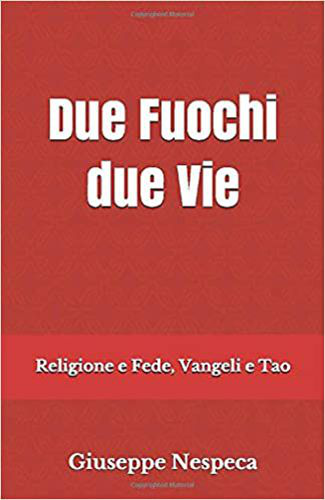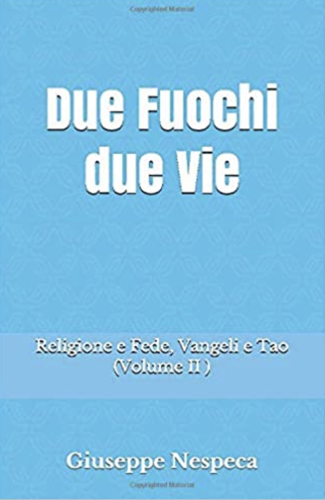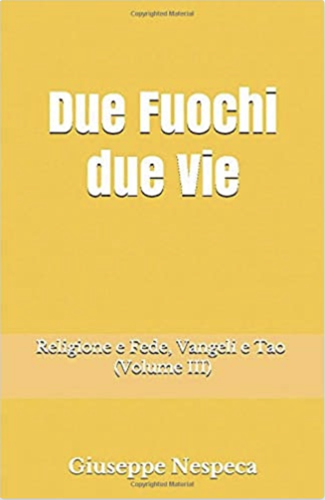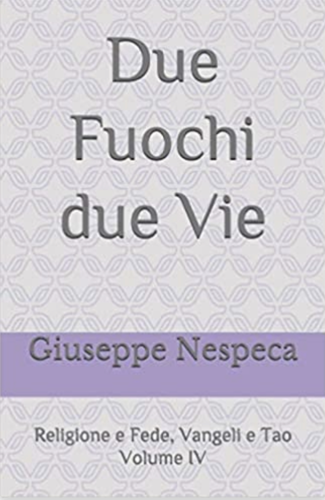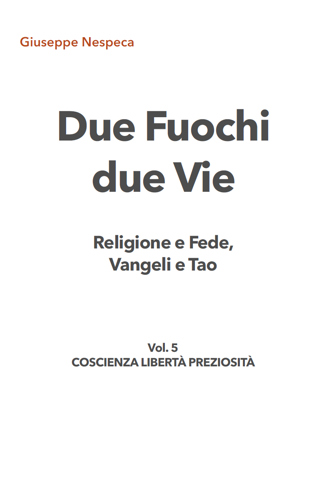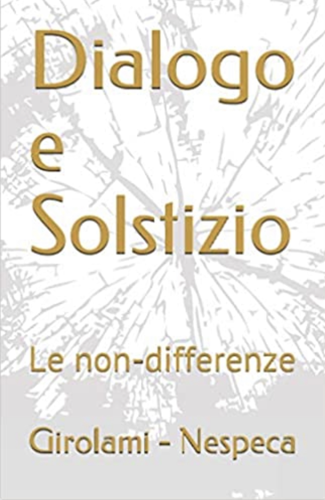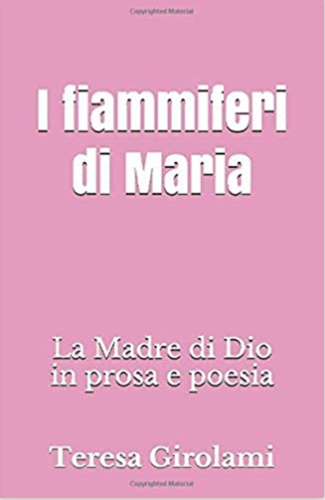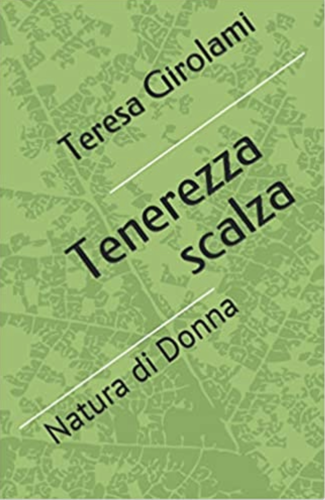don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Manifestato in modo impensabile
Al centro del Vangelo di oggi (Gv 1,29-34) c’è questa parola di Giovanni il Battista: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!» (v. 29). Una parola accompagnata dallo sguardo e dal gesto della mano che indicano Lui, Gesù.
Immaginiamo la scena. Siamo sulla riva del fiume Giordano. Giovanni sta battezzando; c’è tanta gente, uomini e donne di varie età, venuti lì, al fiume, per ricevere il battesimo dalle mani di quell’uomo che a molti ricordava Elia, il grande profeta che nove secoli prima aveva purificato gli israeliti dall’idolatria e li aveva ricondotti alla vera fede nel Dio dell’alleanza, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.
Giovanni predica che il regno dei cieli è vicino, che il Messia sta per manifestarsi e bisogna prepararsi, convertirsi e comportarsi con giustizia; e si mette a battezzare nel Giordano per dare al popolo un mezzo concreto di penitenza (cfr Mt 3,1-6). Questa gente veniva per pentirsi dei propri peccati, per fare penitenza, per ricominciare la vita. Lui sa, Giovanni sa che il Messia, il Consacrato del Signore è ormai vicino, e il segno per riconoscerlo sarà che su di Lui si poserà lo Spirito Santo; infatti Lui porterà il vero battesimo, il battesimo nello Spirito Santo (cfr Gv 1,33).
Ed ecco il momento arriva: Gesù si presenta sulla riva del fiume, in mezzo alla gente, ai peccatori – come tutti noi –. E’ il suo primo atto pubblico, la prima cosa che fa quando lascia la casa di Nazaret, a trent’anni: scende in Giudea, va al Giordano e si fa battezzare da Giovanni. Sappiamo che cosa succede – lo abbiamo celebrato domenica scorsa –: su Gesù scende lo Spirito Santo in forma come di colomba e la voce del Padre lo proclama Figlio prediletto (cfr Mt 3,16-17). E’ il segno che Giovanni aspettava. E’ Lui! Gesù è il Messia. Giovanni è sconcertato, perché si è manifestato in un modo impensabile: in mezzo ai peccatori, battezzato come loro, anzi, per loro. Ma lo Spirito illumina Giovanni e gli fa capire che così si compie la giustizia di Dio, si compie il suo disegno di salvezza: Gesù è il Messia, il Re d’Israele, ma non con la potenza di questo mondo, bensì come Agnello di Dio, che prende su di sé e toglie il peccato del mondo.
Così Giovanni lo indica alla gente e ai suoi discepoli. Perché Giovanni aveva una numerosa cerchia di discepoli, che lo avevano scelto come guida spirituale, e proprio alcuni di loro diventeranno i primi discepoli di Gesù. Conosciamo bene i loro nomi: Simone, detto poi Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo e suo fratello Giovanni. Tutti pescatori; tutti galilei, come Gesù.
Cari fratelli e sorelle, perché ci siamo soffermati a lungo su questa scena? Perché è decisiva! Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa. La Chiesa, in ogni tempo, è chiamata a fare quello che fece Giovanni il Battista, indicare Gesù alla gente dicendo: «Ecco l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo!». Lui è l’unico Salvatore! Lui è il Signore, umile, in mezzo ai peccatori, ma è Lui, Lui: non è un altro, potente, che viene; no, no, è Lui!
E queste sono le parole che noi sacerdoti ripetiamo ogni giorno, durante la Messa, quando presentiamo al popolo il pane e il vino diventati il Corpo e il Sangue di Cristo. Questo gesto liturgico rappresenta tutta la missione della Chiesa, la quale non annuncia sé stessa. Guai, guai quando la Chiesa annuncia se stessa; perde la bussola, non sa dove va! La Chiesa annuncia Cristo; non porta sé stessa, porta Cristo. Perché è Lui e solo Lui che salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida alla terra della vera libertà.
La Vergine Maria, Madre dell’Agnello di Dio, ci aiuti a credere in Lui e a seguirlo.
[Papa Francesco, Angelus 15 gennaio 2017]
Dietro di me: preparare o accogliere
Nessun senso unico
(Gv 1,19-28)
«Dietro di me» [v.27 testo greco] è la posizione del discepolo rispetto a quella che assumeva il maestro.
Gesù in ricerca ha scelto la scuola di Giovanni, di cui è diventato allievo, poi se ne è scostato - strappandogli anche alcuni ammiratori.
A un certo punto del suo percorso si è accorto che il nostro cammino spirituale non poggia su facili esclusioni: moraliste, unilaterali, astratte - stabilite da nomenclature disinfettanti (istituzionali o espulse).
Il cuore del Padre è oltre le attese divisive e puriste, che anche il Battezzatore riteneva indiscutibili e inculcava ai suoi allievi.
Dio opera solo in favore della vita: le sue azioni sono tutte positive - umanizzanti, di recupero, di consapevolezza e integrazione dell’essere personale - non di rigetto.
Alla sua scuola si cresce facendo tesoro di sé, delle relazioni, delle cose così come sono e dove sono; in modo integrale. Nessuno dovrebbe essere a ristagno, o in competizione con l'altro.
Principio non negoziabile: Dio e i suoi figli si fanno in mezzo, non davanti.
Nessuno è chiamato a stare dietro e seguire: tutti devono esprimersi. Su base vocazionale, ciascuno è già perfetto!
Per questo motivo Gesù inviterà i suoi discepoli anche un pochino sconclusionati a farsi pescatori di uomini.
In ogni tempo i suoi intimi sono chiamati a trasmettere respiro, traendo i fratelli da gorghi di morte - non a diventare guide, direttori e dirigisti, ovvero “pastori”.
Nessuno è destinato a stare buono e mortificato in qualche gregge, condotto da chi la sa lunga. La ricchezza non è fuori di noi.
Unico condottiero e modello è lo Spirito divino, che senza posa stupisce.
Vento impetuoso: non sai da dove viene né dove va (Gv 3,8), ma trasmette esclusivamente vita - anche da forme e vicende di morte.
L’essere si accentua e rallegra solo quando le risorse di ciascuno sono scoperte, non “riparate”. E accolte, valorizzate, messe in gioco, amplificate, scambiate, dinamizzate in rapporto di reciprocità.
Dio non è un sequestrato, e ha poliedrici linguaggi particolari; per ciascuno dei suoi figli, un suo percorso irripetibile.
L’Eterno sogna in favore d’ognuno di noi una Via e una realizzazione missionaria eccezionale, unica, non omologabile.
Le religioni tradizionali ad es. esorcizzano le emozioni negative, l’imperfezione.
Esse aborriscono il limite, rinnegano le avversità; non stanno bene qualsiasi cosa accada. Infatti vogliono rapporti, evidenze, e anime sempre sistemate.
Troppe forme di devozione predicano la guerra interiore, perfino in modo palese.
Così purtroppo faceva anche Giovanni, mettendo donne e uomini contro se stessi o il loro carattere, e le movenze spontanee.
Guise che fanno diventare esterni.
Viceversa, il Padre vuole far vivere e sbocciare; perciò non è sempre pieno di pareri.
Il Signore trae meraviglie che faranno scalpore, proprio dai lati oscuri; trasformati in sorgenti di nuove magie.
Ai primi cristiani, i discepoli del Battista chiedevano spiegazioni sul Cristo:
“Voi che ritenete Gesù Messia, non ricordate che è stato il nostro maestro a battezzarlo, aggregandolo alla sua scuola? Come può l’Unto farsi discepolo di altri, e dover imparare qualcosa?”.
I piccoli figli di Dio erano però già passati dalla mentalità piramidale e apodittica delle religioni d’un tempo [dove i modelli cascano come fulmini e istigano tribunali: vv.19-25] all’idea concreta d’Incarnazione.
[La vera teologia dell’Incarnazione si completa in fieri, e nel frattempo dovrebbe spazzar via tutte le gabbie mentali, anche nell’età apparentemente trasandata della crisi e dell’emergenza critica globale].
Ancora oggi, l’aggancio con la storia e la sua nuova energia stanno mandando al tappeto tutti i luoghi comuni, persino del credere.
Ma l’ansia che ci genera è per la nascita di una nuova Vita, più in grado di percepire: attenta e autentica.
Gesù ha conosciuto la penuria esistenziale di tutti: i bisogni, l’ignoranza, la crescita; come ogni uomo. Ed ha vissuto in sé e compreso il valore naturale-sovrannaturale dell’esplorazione.
Invece che farsi “ritoccare”, riformare e castrare a monte, il nuovo Rabbi ha compiuto egli stesso un Esodo addirittura variegato e non conformista, che lo ha arricchito.
Anch’Egli ha dovuto correggere il percorso iniziale [da discepolo di Giovanni (v.27a) insieme a quelli che sono poi diventati i primi Apostoli] e ricredersi: valore aggiunto, non impurità.
Ha fatto tutto come noi, senza la malattia del dottrinarismo a senso unico; per questo ci riconosciamo davvero in Cristo, nella sua Parola, e nella sua amabilissima vicenda.
E riconoscerlo Sposo dell’anima (v.27b).
È pienamente umano procedere per tentativi ed errori, aggiustando il tiro man mano che ci si rende conto - guarendo l’ottica di approccio, sia all’intuizione del divino, che al senso creaturale.
Evitando in tal guisa di diventare nevrotici per adattamento, perché nel frattempo che si procede ogni anima fa tesoro delle esperienze e si prepara a porgere una sintesi personale.
È tale dignità unitiva che coinvolge nell’Amore. Non siamo chiamati ad essere forzuti a prescindere.
I finti-sicuri poi seminano le più strampalate incertezze, e combinano i peggiori guai, per tutti.
Creando ambienti che sembrano cimiteri frequentati da zombie [direbbe Papa Francesco] spersonalizzati. E astuti che dirigono.
Nella sua Ricerca tutta umana, Gesù ha via via compreso che la stessa Vita intima del Padre viene offerta come Dono: una Sorpresa a nostro favore.
Impossibile coniarla su misura dei pregiudizi antichi.
Inverosimile - dunque - allestire una qualche manifestazione del Messia a partire dalle nostre precomprensioni, o conversioni eticiste a U, forbite di ritorni, allestimenti, eventi, iniziative.
L’Altissimo ci spiazza di continuo, e non ricalca assolutamente opinioni consolidate, o manierismi.
La Felicità è fuori da meccanismi sterili che progettano i minimi dettagli. È piuttosto Alleanza con il lato ombra, che tuttavia ci appartiene.
Sacro Patto che trasmette completezza di essere: percezione-soglia della Gioia.
Insomma, siamo immersi in un Mistero di Gratuità e stupore vitale che travalica la crescita normalizzata, tutta sotto condizioni.
Scrive il Tao Tê Ching (LI):«Nessuno comanda il Tao, ma viene ognor spontaneo». E il maestro Ho-shang Kung commenta: «Il Tao non soltanto fa venire alla vita le creature, ma per di più le fa crescere, le nutre, le completa, le matura, le ripara, le sviluppa, le mantiene integre nella vita».
Il Padre fa risorgere nello Spirito, senza una trafila di progressioni a tappe e scalate.
Procedure altrui, le quali invece di rigenerare l’esistenza ci sbattono sempre in faccia il sospetto di essere inadeguati, impantanati, incapaci di perfezione, e vecchiotti.
Cassiano e infine anche Tommaso d’Aquino le avrebbero forse classificate col titolo di “vizi spirituali”, quali espressioni derivate da «fornicatio mentis» [et corporis].
Mentre il Battista e tutta la tradizione seriosa immaginava di dover tanto preparare l’avvento del Regno, Gesù ha invece proposto di accoglierlo: unica possibilità di Perfezione e Giovinezza feconde.
Non esistiamo più in funzione di Dio - come nelle religioni che stanno sempre a disporre tutto - ma viviamo di Lui, con stupore e in modo irripetibile.
Sottolinea ancora il maestro Ho-shang Kung: «Il Tao fa vivere le creature, ma non le tiene come sue: ciò che esse prendono è a loro beneficio».
È la fine dei modelli per scolari “trattenuti” - non naturali, né intuitivi. Paradigmi i quali hanno sottoposto le civiltà a prove estenuanti: non sono nostre.
Tuttora, molte iperboli, e sforzi anche “religiosi”, non sono in favore di percorsi vocazionali in prima persona.
Le strade conformiste e già confezionate [glamour o vetuste] appaiono eteree, o rinunciatarie, puritane, volontariste, atletiche; nonché fantasiose, ma tutte schematiche, e disincarnate.
Esse montano impalcature sempre lontanissime dalla realtà che Viene, e dalle genuine cose del Cielo.
Per noi incerti, inadeguati, incapaci di miracolo - e che non amiamo le ideologie cerebrali o il separatismo degli eroi tutti d’un pezzo - Bella questa rassicurazione affatto puntigliosa e caparbia!
La ricchezza non è fuori di noi.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Chi è il Soggetto della tua vita spirituale? Dove abita?
Preparare o accogliere: nessun senso unico
(Gv 1,19-28)
Il cuore del Padre è oltre le attese divisive e puriste, che anche il Battezzatore riteneva indiscutibili e inculcava ai suoi allievi.
Dio opera solo in favore della vita: le sue azioni sono tutte positive - umanizzanti, di recupero - non di rigetto.
L’«essere» si accentua e rallegra solo quando le risorse di ciascuno sono scoperte, accolte, valorizzate; non “riparate”.
Le religioni tradizionali esorcizzano le emozioni negative, l’imperfezione; aborriscono il limite. Vogliono rapporti, cose e anime sempre sistemate.
Il Padre invece desidera far vivere e sbocciare; perciò non è sempre pieno di pareri.
Egli trae meraviglie che faranno scalpore, proprio dai lati oscuri; trasformati in sorgenti di nuove magie.
Gesù ha conosciuto la penuria esistenziale di tutti: i bisogni, la crescita; come ogni uomo. Ed ha vissuto in sé e compreso il valore dell’esplorazione.
Invece che farsi “ritoccare” e riformare, il nuovo Rabbi ha compiuto egli stesso un Esodo non conformista, che lo ha arricchito.
Anch’Egli ha dovuto correggere il percorso iniziale [da discepolo di Giovanni (v.27a) insieme a quelli che sono poi diventati i primi Apostoli] e ricredersi: valore aggiunto, non impurità.
Ha fatto tutto come noi, senza atteggiamenti unilaterali; per questo possiamo riconoscerci davvero in Cristo, nella sua Parola, e nella sua amabilissima vicenda.
E riconoscerlo Sposo dell’anima (v.27b).
È tale dignità unitiva che coinvolge nell’Amore. Non siamo chiamati ad essere forzuti a prescindere.
Nella sua Ricerca tutta umana, Gesù ha via via compreso che la stessa Vita intima del Padre viene offerta come Dono - una Sorpresa a nostro favore: impossibile coniarla su misura dei pregiudizi [antichi, o che seguono l’ultima moda].
L’Altissimo ci spiazza di continuo, e non ricalca assolutamente opinioni consolidate, o manierismi.
La Felicità è fuori da meccanismi sterili che progettano i minimi dettagli. È piuttosto Alleanza con il lato ombra, che tuttavia ci appartiene.
Sacro Patto che trasmette completezza di essere: percezione-soglia della Gioia.
Insomma, siamo immersi in un Mistero di Gratuità e stupore vitale che travalica la crescita normalizzata, tutta sotto condizioni.
Procedure altrui. Cassiano e infine anche Tommaso d’Aquino le avrebbero forse classificate col titolo di ‘vizi spirituali’, quali espressioni derivate da «fornicatio mentis» [et corporis].
Mentre il Battista e tutta la tradizione seriosa immaginava di dover tanto ‘preparare’ l’avvento del Regno, Gesù ha invece proposto di ‘accoglierlo’: unica possibilità di Perfezione e Giovinezza feconde.
Non esistiamo più in funzione di Dio - come nelle religioni che stanno sempre a disporre tutto - ma viviamo di Lui, con stupore e in modo irripetibile.
È la fine dei modelli per scolari “trattenuti”, non naturali.
Per noi incerti, inadeguati, incapaci di miracolo - Bella questa rassicurazione!
La ricchezza non è fuori di noi.
[Ss. Basilio e Gregorio, 2 gennaio]
Voce che prepara la strada
Questo periodo dell’anno liturgico mette in risalto le due figure che hanno avuto un ruolo preminente nella preparazione della venuta storica del Signore Gesù: la Vergine Maria e san Giovanni Battista. Proprio su quest’ultimo si concentra il testo odierno del Vangelo di Marco. Descrive infatti la personalità e la missione del Precursore di Cristo (cfr Mc 1,2-8). Incominciando dall’aspetto esterno, Giovanni viene presentato come una figura molto ascetica: vestito di pelle di cammello, si nutre di cavallette e miele selvatico, che trova nel deserto della Giudea (cfr Mc 1,6). Gesù stesso, una volta, lo contrappose a coloro che “stanno nei palazzi dei re” e che “vestono con abiti di lusso” (Mt 11,8). Lo stile di Giovanni Battista dovrebbe richiamare tutti i cristiani a scegliere la sobrietà come stile di vita, specialmente in preparazione alla festa del Natale, in cui il Signore – come direbbe san Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà” (2 Cor 8,9).
Per quanto riguarda la missione di Giovanni, essa fu un appello straordinario alla conversione: il suo battesimo “è legato a un ardente invito a un nuovo modo di pensare e di agire, è legato soprattutto all’annuncio del giudizio di Dio” (Gesù di Nazaret, I, Milano 2007, p. 34) e della imminente comparsa del Messia, definito come “colui che è più forte di me” e che “battezzerà in Spirito Santo” (Mc 1,7.8). L’appello di Giovanni va dunque oltre e più in profondità rispetto alla sobrietà dello stile di vita: chiama ad un cambiamento interiore, a partire dal riconoscimento e dalla confessione del proprio peccato. Mentre ci prepariamo al Natale, è importante che rientriamo in noi stessi e facciamo una verifica sincera sulla nostra vita. Lasciamoci illuminare da un raggio della luce che proviene da Betlemme, la luce di Colui che è “il più Grande” e si è fatto piccolo, “il più Forte” e si è fatto debole.
Tutti e quattro gli Evangelisti descrivono la predicazione di Giovanni Battista facendo riferimento ad un passo del profeta Isaia: “Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio»” (Is 40,3). Marco inserisce anche una citazione di un altro profeta, Malachia, che dice: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua via” (Mc 1,2; cfr Mal 3,1). Questi richiami alle Scritture dell’Antico Testamento “parlano dell’intervento salvifico di Dio, che esce dalla sua imperscrutabilità per giudicare e salvare; a Lui bisogna aprire la porta, preparare la strada” (Gesù di Nazaret, I, p. 35).
Alla materna intercessione di Maria, Vergine dell’attesa, affidiamo il nostro cammino incontro al Signore che viene, mentre proseguiamo il nostro itinerario di Avvento per preparare nel nostro cuore e nella nostra vita la venuta dell’Emmanuele, il Dio-con-noi.
[Papa Benedetto, Angelus 4 dicembre 2011]
Patres Ecclesiae
1. Padri della Chiesa sono giustamente chiamati quei santi che, con la forza di fede, la profondità e la ricchezza dei loro insegnamenti, nel corso dei primi secoli l'hanno rigenerata e grandemente incrementata (cfr. Gal 4, 19; Vincentii Lirinensis «Commonitorium», I,3: PL 50, 641).
In verità «padri» della Chiesa, perché da loro, mediante il Vangelo, essa ha ricevuto la vita (cfr. 1 Cor 4, 15). E anche suoi costruttori, perché da loro - sul fondamento unico posto dagli apostoli, che è il Cristo (cfr. 1 Cor 3, 11) - la Chiesa di Dio è stata edificata nelle sue strutture portanti.
Della vita attinta dai suoi padri la Chiesa ancora oggi vive; e sulle strutture poste dai suoi primi costruttori ancora oggi viene edificata, nella gioia e nella pena del suo cammino e del suo travaglio quotidiano.
Padri dunque sono stati, e padri restano per sempre: essi stessi, infatti, sono una struttura stabile della Chiesa, e per la Chiesa di tutti i secoli adempiono a una funzione perenne. Cosicché ogni annuncio e magistero successivo, se vuole essere autentico, deve confrontarsi con il loro annuncio e il loro magistero; ogni carisma e ogni ministero deve attingere alla sorgente vitale della loro paternità; e ogni pietra nuova, aggiunta all'edificio santo che ogni giorno cresce e si amplifica (cfr. Ef 2, 21), deve collocarsi nelle strutture già da loro poste, e con esse saldarsi e connettersi.
Guidata da queste certezze, la Chiesa non si stanca di ritornare ai loro scritti - pieni di sapienza e incapaci di invecchiare - e di rinnovarne continuamente il ricordo. E' quindi con grande gioia che nel corso dell'anno liturgico sempre di nuovo incontriamo i nostri padri: e ogni volta ne siamo confermati nella fede e incoraggiati nella speranza.
E ancora più grande è la nostra gioia quando particolari circostanze invitano a incontrarli in modo più prolungato e profondo. Di tale natura è appunto la ricorrenza di questo anno, che segna il XVI centenario dal transito del nostro padre Basilio, Vescovo di Cesarea.
2. La vita e il ministero di san Basilio
Fra i padri greci chiamato «grande», nei testi liturgici bizantini Basilio è invocato come «luce della pietà» e «luminare della Chiesa». La illuminò, infatti, e tuttora la illumina: non meno per «la purezza della sua vita» che per l'eccellenza della sua dottrina. Poiché il primo e più grande insegnamento dei santi è pur sempre la loro vita.
Nato in una famiglia di santi, Basilio ebbe anche il privilegio di una educazione eletta, presso i più reputati maestri di Costantinopoli e di Atene.
Ma a lui parve che la sua vita cominciasse veramente solo quando, in modo più pieno e determinante, gli fu dato di conoscere il Cristo come suo Signore: quando, cioè, attirato irresistibilmente da lui, praticò quel distacco radicale che avrebbe poi tanto inculcato nel suo insegnamento (cfr. S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 8: PG 31, 933c-941a), e divenne suo discepolo.
Si mise allora alla sequela del Cristo, volendo conformarsi soltanto a lui: guardando a lui solo, ascoltando lui solo (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX,1: PG 31, 860bc), e in tutto e per tutto considerandolo suo unico «sovrano, re, medico, e maestro di verità» (S.Basilii «De Baptismo», I,1: PG 31, 1516b).
Senza esitare, quindi, abbandonò quegli studi che pure tanto aveva amato e dai quali aveva tratto immensi tesori di scienza (cfr. Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 525c-528c): avendo infatti deciso di servire a Dio solo, non volle più sapere nulla all'infuori del Cristo (cfr. 1 Cor 2, 2), e ritenne vanità ogni sapienza che non fosse quella della croce. Sono parole sue, con le quali, già verso il termine della vita, rievocava l'evento della sua conversione: «Io avevo sciupato molto tempo nella vanità, perdendo quasi tutta la mia giovinezza nel lavoro vano a cui mi applicavo per apprendere gli insegnamenti di quella sapienza che Dio ha resa stolta (cfr. 1 Cor 1, 20); finché un giorno, come svegliandomi da un sonno profondo, riguardai alla mirabile luce della verità del Vangelo, e considerai l'inutilità della sapienza dei prìncipi di questo mondo che sono ridotti all'impotenza (cfr. 1 Cor 2, 6). Allora piansi molto sulla mia miserabile vita» (cfr. S.Basilii «Epistula» 223: PG 32, 824a).
Pianse sulla sua vita, benché già prima - secondo la testimonianza di Gregorio Nazianzeno, suo compagno di studi - fosse umanamente esemplare (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36,521cd): gli sembrò nondimeno «miserabile», perché non era in modo totale ed esclusivo consacrata a Dio, che è l'unico Signore.
Con irrefrenabile impazienza, interruppe dunque gli studi intrapresi e, abbandonati i maestri della sapienza ellenica, «attraversò molte terre e molti mari» (S.Basilii «Epistula» 204: PG 32, 753a) in cerca di altri maestri: quegli «stolti» e quei poveri che nei deserti si esercitavano a ben diversa sapienza.
Cominciò così ad apprendere cose mai salite al cuore dell'uomo (cfr. 1 Cor 2, 9), verità che i retori e i filosofi non avrebbero mai potuto insegnargli (cfr. S.Basilii «Epistula» 223»: PG 32, 824bd). E in questa sapienza nuova crebbe poi di giorno in giorno, in un meraviglioso itinerario di grazia: mediante la preghiera, la mortificazione, l'esercizio della carità, il continuo commercio con le sante Scritture e gli insegnamenti dei Padri (cfr. praesertim S.Basilii «Epistula» 2 et 22).
Ben presto fu chiamato al ministero.
Ma anche nel servizio delle anime, con saggio equilibrio seppe comporre la predicazione infaticabile con spazi di solitudine e ampio respiro di preghiera. Riteneva infatti che ciò fosse di inderogabile necessità per la «purificazione dell'anima» (S.Basilii «Epistula» 2: PG 32, 228a; cfr. «Epistula» 210: PG 32, 769a), e quindi perché l'annuncio della parola potesse sempre essere confermato dall'«evidente esempio» della vita (S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 43: PG 31, 1028a-1029b; cfr. «Moralia», LXX, 10: PG 31, 824d-825b).
Così divenne pastore e fu insieme, nel senso più sostanziale del termine, monaco; anzi, fu certo fra i più grandi dei monaci-Pastori della Chiesa: figura singolarmente completa di Vescovo, e grande promotore e legislatore del monachesimo.
Forte, infatti, della propria personale esperienza, Basilio contribuì fortemente alla formazione di comunità di cristiani totalmente consacrati al «divino servizio» (S.Benedicti «Regula», Prologus), e si assunse l'impegno e la fatica di sostenerle con frequenti visite (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 536b): per sua e loro edificazione intrattenendosi con esse in mirabili colloqui, molti dei quali, per grazia di Dio, ci sono stati trasmessi per scritto (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», Proemium: PG 31, 1080ab). A questi scritti hanno attinto vari legislatori del monachesimo, non ultimo lo stesso san Benedetto, che considera Basilio come suo maestro (cfr. S.Benedicti «Regula», LXXIII,5); a questi scritti - direttamente o indirettamente conosciuti - si sono ispirati la più parte di coloro che, in oriente come in occidente, hanno abbracciato la vita monastica.
Per questo si ritiene da molti che quella struttura capitale della vita della Chiesa che è il monachesimo sia stata posta, per tutti i secoli, principalmente da san Basilio; o che, almeno, non sia stata definita nella sua natura più propria senza il suo decisivo contributo.
Basilio ebbe molto a soffrire per i mali in cui gemeva, in quell'ora difficile, il Popolo di Dio (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 653b). Li denunciò con franchezza, e, con lucidità e amore, ne individuò le cause, per accingersi coraggiosamente a una vasta opera di riforma. Cioè all'opera - da perseguire in ogni tempo, da rinnovare a ogni generazione - volta a riportare la Chiesa del Signore, «per la quale il Cristo è morto e sulla quale ha effuso abbondante il suo Spirito» (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31,653b), alla sua forma primitiva: a quella normativa immagine, bella e pura, che ce ne trasmettono la parola del Cristo e degli Atti degli Apostoli. Quante volte Basilio ricorda, con passione e costruttiva nostalgia, il tempo in cui «la moltitudine dei credenti era un cuore solo e un'anima sola»! (At 4, 32; cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 36, 660c; cfr. «Regulae fusius tractatae», 7: PG 31, 933c; cfr. «Homilia tempore famis»: PG 31, 325ab).
Il suo impegno di riforma si volse insieme, con armonia e compiutezza, praticamente a tutti gli aspetti e gli ambiti della vita cristiana.
Per la natura stessa del suo ministero, il Vescovo è innanzitutto pontefice del suo popolo- e il Popolo di Dio è prima di tutto popolo sacerdotale.
Non può quindi in alcun modo trascurare la liturgia - la sua forza e ricchezza, la sua bellezza, la sua «verità» - un Vescovo veramente sollecito del bene della Chiesa. Nell'opera pastorale, anzi, l'impegno pr la liturgia sta logicamente al vertice di tutto e concretamente in cima a ogni altra scelta: la liturgia, infatti - come ricorda il Concilio Vaticano II - è «il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa, e insieme la fonte da cui promana tutta la sua virtù» («Sacrosanctum Concilium», 10), cosicché «nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia» («Sacrosanctum Concilium», 7).
Di questo si mostrò perfettamente consapevole Basilio e il «legislatore di monaci» (cfr. S.Gregorii Nazianzenii «In laudem Basilii»: PG 36, 541c) seppe essere anche sapiente «riformatore liturgico» (cfr. S.Gregorii Nazianzenii «In laudem Basilii»: PG 36, 541c).
Della sua opera in questo ambito resta, eredità preziosissima per la Chiesa di tutti i tempi, l'anafora che legittimamente porta il suo nome: la grande preghiera eucaristica che, da lui rifusa e arricchita, è bellissima fra le più belle.
Non solo: lo stesso ordinamento fondamentale della preghiera salmodica ebbe in lui uno dei maggiori ispiratori e artefici (cfr. S.Basilii «Epistula» 2 et «Regula fusius tractatae», 37: PG 31, 1013b-1016c). Così, soprattutto per l'impulso dato da lui, la salmodia - «incenso spirituale», respiro e conforto del Popolo di Dio (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 212a-213c) - nella sua Chiesa fu amata moltissimo dai fedeli, e divenne nota ai piccoli e agli adulti, ai dotti e agli incolti (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 212a-213c). Come riferisce lo stesso Basilio: «Presso di noi il popolo si alza di notte per recarsi alla casa della preghiera,... e trascorre la notte alternando salmi e preghiere» (S.Basilii «Epistula» 207: PG 32, 764ab). I salmi, che nelle chiese rimbombavano come tuoni (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 561cd), si udivano risuonare anche nelle case e nelle piazze (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 212c).
Basilio amò di amore geloso la Chiesa (cfr. 2 Cor 11, 2): e sapendo che la sua verginità e la sua stessa fede, della purezza di questa fede fu custode vigilantissimo.
Per questo dovette e seppe combattere con coraggio: non contro uomini, ma contro ogni adulterazione della parola di Dio (cfr. 2 Cor 2 17), ogni falsificazione della verità, ogni manomissione del deposito santo (cfr. 1 Tm 6,20) trasmesso dai Padri. Il suo impeto perciò non aveva nulla di passionale: era forza di amore; e la sua chiarezza nulla di puntiglioso: era delicatezza di amore.
Così, dall'inizio al termine del suo ministero combatté per salvaguardare intatto il senso della formula di Nicea riguardo alla divinità del Cristo «consostanziale» al Padre (cfr. S.Basilii «Epistula» 9: PG 32, 72a; «Epistula» 52: PG 32, 392b-396a; «Adv. Eunomium», I: PG 29, 556c); e ugualmente combatté perché non fosse sminuita la gloria dello Spirito che, «facendo parte della Trinità ed essendo della divina e beata natura di essa» (S.Basilii «Epistula» 243: PG 32, 909a), deve essere con il Padre e il Figlio connumerato e conglorificato (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto»: PG 32, 117c).
Con fermezza, ed esponendosi personalmente a pericoli gravissimi, vigilò e combatté anche per la libertà della Chiesa: da vero Vescovo, non esitando a contrapporsi ai regnanti per difendere il diritto suo e del Popolo di Dio di professare la verità e di ubbidire al Vangelo (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 557c-561c). Il Nazianzeno, che riferisce un episodio saliente di questa lotta, fa ben comprendere che il segreto della sua forza non risiedeva che nella semplicità stessa del suo annuncio, nella chiarezza della sua testimonianza, e nell'inerme maestà della sua dignità sacerdotale (cfr. S.Gregorii Nazianzeni «In laudem Basilii»: PG 36, 561c-564b).
Non minore severità che contro eresie e tiranni, Basilio mostrò contro equivoci e abusi all'interno della Chiesa: particolarmente, contro la mondanizzazione e l'attaccamento ai beni.
A muoverlo era, ancora e sempre, il medesimo amore alla verità e al Vangelo; benché in modo diverso, era pur sempre il Vangelo, infatti, a essere negato e contraddetto: sia dall'errore degli eresiarchi, che dall'egoismo dei ricchi.
Al riguardo sono memorabili, e rimangono esemplari, i testi di alcuni suoi discorsi: «Vendi quello che hai e dallo ai poveri (Mt 19, 22);... perché, anche se non hai ucciso o commesso adulterio o rubato o detto falsa testimonianza, non ti serve a nulla se non fai anche il resto: solo in tale modo potrai entrare nel regno di Dio» (S.Basilii «Homilia in divites»: PG 31,280b-281a). Chi infatti, secondo il comandamento di Dio, vuole amare il prossimo come se stesso (cfr. Lv 19, 18; Mt 19, 19), «non deve possedere niente di più di quello che possiede il suo prossimo» (S.Basilii «Homilia in divites» PG 31, 281b).
E in modo ancora più appassionato, in tempo di carestia, esortava a «non mostrarsi più crudeli delle bestie,... col mettersi in seno ciò che è comune, e possedendo da soli ciò che è di tutti» (cfr. S.Basilii «Homilia tempore famis»: PG 31, 325a).
Un radicalismo sconcertante e bellissimo, e un forte appello alla Chiesa di tutti i tempi a confrontarsi seriamente con il Vangelo.
Al Vangelo, che comanda l'amore e il servizio dei poveri, oltre che con queste parole Basilio rese testimonianza con opere immense di carità; come la costruzione, alle porte di Cesarea, di un gigantesco ospizio per i bisognosi (cfr. S.Basilii «Epistula» 94: PG 32, 488bc): una vera città della misericordia che da lui prese il nome di Basiliade (cfr. Sozosemi «Historia Eccl.» VI, 34: PG 67, 1397a), anch'essa momento autentico dell'unico annuncio evangelico.
Fu lo stesso amore per il Cristo e il suo Vangelo, ciò che tanto lo fece soffrire delle divisioni della Chiesa e che con tanta perseveranza, sperando contra spem, gli fece ricercare con tutte le Chiese una comunione più efficace e manifesta (cfr. S.Basilii «Epistulae» 70 et 243).
E' la verità stessa del Vangelo, infatti, a essere oscurata dalla discordia dei cristiani, ed è il Cristo stesso a esserne lacerato (cfr. 1 Cor 1, 13). La divisione dei credenti contraddice la potenza dell'unico battesimo (cfr. Ef 4, 4), che nel Cristo ci fa una sola cosa, anzi un'unica mistica persona (cfr. Gal 3, 28); contraddice la sovranità del Cristo, unico re al quale tutti devono ugualmente essere soggetti; contraddice l'autorità e la forza unificante della parola di Dio, unica legge alla quale tutti i credenti devono concordemente ubbidire (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 653a-656c).
La divisione delle Chiese è quindi un fatto così nettamente e direttamente anti-cristologico e anti-biblico, che secondo Basilio la via per la ricomposizione dell'unità può essere soltanto la ri-conversione di tutti al Cristo e alla sua parola (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 660b-661a).
Nel multiforme esercizio del suo ministero Basilio si fece dunque, come prescriveva per tutti gli annunciatori della parola, «apostolo e ministro di Cristo, dispensatore dei misteri di Dio, araldo del regno, modello e regola di pietà, occhio del corpo della Chiesa, pastore delle pecore di Cristo, medico pietoso, padre e nutrice, cooperatore di Dio, agricoltore di Dio, costruttore del tempio di Dio» (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX,12-21: PG 31, 864b-868b).
E in tale opera e tale lotta - ardua, dolorosa, senza respiro - Basilio offrì la sua vita (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX,18: PG 31, 865c) e si consumò come olocausto.
Morì non ancora cinquantenne, consumato dalle fatiche e dall'ascesi.
3. Il magistero di san Basilio
Dopo avere così brevemente ricordato aspetti salienti della vita di Basilio e del suo impegno di cristiano e di Vescovo, sembra giusto che si tenti di attingere, dalla ricchissima eredità dei suoi scritti, almeno qualche indicazione suprema. Rimettersi alla sua scuola potrà dare luce per meglio affrontare i problemi e le difficoltà di questo stesso tempo, e quindi soccorrerci per il nostro presente e per il nostro futuro.
Non sembri astratto cominciare da ciò che egli ha insegnato riguardo alla santa Trinità: è certo, anzi, che non può esserci inizio migliore, almeno se ci si vuole adeguare al suo stesso pensiero.
D'altra parte, che cosa può imporsi maggiormente o essere più normativo per la vita, che il mistero della vita di Dio? Può esserci punto di riferimento più significativo e vitale di questo, per l'uomo?
Per l'uomo nuovo, che è conformato a questo mistero nella struttura intima del suo essere e del suo esistere; e per ogni uomo, lo sappia o no: poiché non c'è alcuno che non sia stato creato per il Cristo, il Verbo eterno, e non c'è alcuno che non sia chiamato, dallo Spirito e nello Spirito, a glorificare il Padre.
E' il mistero primordiale, la Trinità santa: poiché non è altro che il mistero stesso di Dio, dell'unico Dio vivo e vero.
Di questo mistero, Basilio proclama con fermezza la realtà: la triade dei nomi divini, dice, indica certo tre distinte ipostasi (cfr. S.Basilii «Adv. Eunomium», I: PG 29, 529a). Ma con non minore fermezza ne confessa l'assoluta inaccessibilità.
Com'era lucida in lui, teologo sommo, la coscienza dell'infermità e inadeguatezza di ogni teologare!
Nessuno, diceva, è capace di farlo in modo degno, e la grandezza del mistero vince ogni discorso, cosicché neppure le lingue degli angeli possono attingerlo (cfr. S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 464b-465a).
Realtà abissale e imperscrutabile, dunque, il Dio vivente! Ma nondimeno Basilio sa di «doverne» parlare, prima e più che di ogni altra cosa. E così, credendo, parla (cfr. 2 Cor 4, 13): per forza incoercibile di amore, per obbedienza al comando di Dio, e per l'edificazione della Chiesa, che «non si sazia mai di udire tali cose» (S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 464cd).
Ma forse è più esatto dire che Basilio, da vero «teologo», più che parlare di questo mistero, lo canta.
Canta il Padre: «Il principio di tutto, la causa dell'essere di ciò che esiste, la radice dei viventi» (S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 465c), e soprattutto «Padre del nostro Signore Gesù Cristo» («Anaphora S.Basilii»). E come il Padre è primariamente in rapporto al Figlio, così il Figlio - il Verbo che si è fatto carne nel seno di Maria - è primariamente in rapporto al Padre.
Così dunque lo contempla e lo canta Basilio: nella «luce inaccessibile», nella «potenza ineffabile», nella «grandezza infinita», nella «gloria sovrasplendente» del mistero trinitario, Dio presso Dio (S.Basilii «Homilia de fide»: PG 31, 465cd), «immagine della bontà del Padre e sigillo di forma a lui uguale» (cfr. «Anaphora S.Basilii»).
Solo in questo modo, confessando senza ambiguità il Cristo come «uno della santa Trinità» («Liturgia S.Ioannis Chrysostomi»), Basilio può poi vederlo con pieno realismo nell'annientamento della sua umanità. E come pochi altri sa far misurare l'infinito spazio da lui percorso alla nostra ricerca; come pochi sa far scrutare fin nell'abisso dell'umiiiazione di colui che «essendo nella forma di Dio, svuotò se stesso assumendo la forma di servo» (Fil 2, 6ss)
Nell'insegnamento di Basilio, la cristologia della gloria non attenua per nulla la cristologia dell'umiliazione: anzi, serve a proclamare con forza ancora più grande quel contenuto centrale del Vangelo che è la parola della croce (cfr. 1 Cor 1, 18) e lo scandalo della croce (cfr. Gal 5, 11).
Questo è, di fatto, uno schema abituale del suo discorso cristologico: è la luce della gloria, a rivelare il senso dell'abbassamento.
L'ubbidienza del Cristo è vero «Vangelo», cioè realizzazione paradossale dell'amore redentivo di Dio, proprio perché - e solo se - colui che ubbidisce è «il Figlio Unigenito di Dio, il Signore e Dio nostro, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte» (S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 660b); ed è così che essa può piegare la nostra ostinata disubbidienza. Le sofferenze del Cristo, agnello immacolato che non ha aperto la bocca contro chi lo percuoteva (cfr. Is 53, 7), hanno portata infinita e valore eterno e universale, proprio perché colui che così ha patito è «il creatore e sovrano del cielo e della terra, adorabile al di là di ogni creatura intellettuale e sensibile, colui che tutto sostiene con la parola della sua potenza» (cfr. Eb 1, 3; S.Basilii «Homilia de ira»: PG 31, 369b), ed è così che la passione del Cristo domina la nostra violenza e placa la nostra ira.
La croce, infine, è davvero la nostra «unica speranza» («Liturgia Horarum», "Hebdomada Sancta": Hymnus ad Vesperas) - non sconfitta, quindi, ma evento salvifico, «esaltazione» (cfr. Gv 8,32ss et alibi) e stupendo trionfo - solo perché colui che vi è stato inchiodato e vi è morto è «il Signore nostro e di tutti» (cfr. At 10, 36; S.Basilii «De Baptismo», II,12: PG 31, 1624b), «colui mediante il quale sono state fatte tutte le cose, le visibili e le invisibili, colui che possiede la vita come la possiede il Padre che gliel'ha data, colui che dal Padre ha ricevuto ogni potere» (S.Basilii «De Baptismo», II,13: PG 31, 1625c); ed è così che la morte del Cristo ci libera da quel «timore della morte» del quale tutti eravamo schiavi (cfr. Eb 2, 15).
«Da lui, il Cristo, rifulse lo Spirito Santo: lo Spirito della verità, il dono dell'adozione filiale, il pegno dell'eredità futura, la primizia dei beni eterni, la potenza vivificante, la sorgente della santificazione, da cui ogni creatura razionale e intellettuale riceve potenza di rendere culto al Padre e di elevare a lui la dossologia eterna» (cfr. «Anaphora S.Basilii»).
Questo inno dell'anafora di Basilio esprime bene, in sintesi, il ruolo dello Spirito nell'economia salvifica.
E' lo Spirito che, dato a ogni battezzato, in ciascuno opera carismi e a ciascuno ricorda gli insegnamenti del Signore (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1561a); è lo Spirito che anima tutta la Chiesa e la ordina e la vivifica con i suoi doni facendone tutte un corpo «spirituale» e carismatico (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto»: PG 32, 181ab; «De iudicio»: PG 31, 657c-660a).
Di qui, Basilio risaliva alla serena contemplazione della «gloria» dello Spirito, misteriosa e inaccessibile: confessandolo, al di sopra di ogni creatura (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto», 22), sovrano e signore poiché da lui siamo divinizzati (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto», 20 ss), e Santo per essenza poiché da lui siamo santificati (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto», 9 et 18). Avendo così contribuito alla formulazione della fede trinitaria della Chiesa, Basilio ancora oggi parla al suo cuore e la consola, particolarmente con la luminosa confessione del suo Consolatore.
La luce sfolgorante del mistero trinitario non mette certo in ombra la gloria dell'uomo: anzi, massimamente la esalta e la rivela.
L'uomo infatti, non è rivale di Dio, follemente opposto a lui; e non è senza Dio, abbandonato alla disperazione della propria solitudine. Ma è riflesso di Dio e sua immagine.
Perciò, quanto più Dio risplende, tanto più ne riverbera la luce dall'uomo; quanto più Dio è esaltato, tanto più è innalzata la dignità dell'uomo.
E in questo modo, difatti, Basilio ha celebrato la dignità dell'uomo: vedendola tutta in rapporto a Dio, cioè derivata da lui e finalizzata a lui.
Essenzialmente per conoscere Dio l'uomo ha ricevuto l'intelligenza, e per vivere conforme alla sua legge ha ricevuto la libertà. Ed è in quanto immagine, che l'uomo trascende tutto l'ordine della natura e appare «più glorioso del cielo, più del sole, più dei cori degli astri: quale cielo, infatti, è chiamato immagine di Dio altissimo?» (S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 449c).
Proprio per questo, la gloria dell'uomo è radicalmente condizionata al suo rapporto con Dio: l'uomo consegue in pienezza la sua dignità «regale» solo realizzandosi in quanto immagine, e diviene veramente se stesso solo conoscendo e amando colui per il quale ha la ragione e la libertà.
Già prima di Basilio, così si esprimeva mirabilmente sant'Ireneo: «La gloria di Dio è l'uomo vivente; ma la vita dell'uomo è la visione di Dio» (S.Irenaei «Adversus haereses», IV, 20, 7). L'uomo vivente è in se stesso glorificazione di Dio, in quanto raggio della sua bellezza, ma non ha «vita» se non attingendola da Dio, nel rapporto personale con lui. Fallire in questo compito, significherebbe per l'uomo tradire la propria vocazione essenziale, e pertanto negare e avvilire la propria dignità (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 449b-452a).
E che altro è il peccato se non questo? Il Cristo stesso, infatti, non è forse venuto per restaurare e restituire la sua gloria a questa immagine di Dio che è l'uomo, cioè all'immagine che l'uomo, con il peccato, aveva ottenebrata (S.Basilii «Homilia de malo»: PG 31, 333a), corrotta (S.Basilii «In Psalmum» 32: PG 29, 344b), infranta? (S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1537a).
Proprio per questo - afferma Basilio con le parole della Scrittura - «il Verbo si è fatto carne ed ha abitato fra noi (Gv 1, 14), e ha tanto umiliato se stesso da farsi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce» (cfr. Fil 2, 8; S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 452ab). Perciò, o uomo, «renditi conto della tua grandezza considerando il prezzo versato per te: guarda il prezzo del tuo riscatto, e comprendi la tua dignità!» (S.Basilii «In Psalmum» 48: PG 29, 452b).
La dignità dell'uomo, dunque, è insieme nel mistero di Dio, e nel mistero della croce: è questo l'«umanesimo» di Basilio, o - potremmo dire più semplicemente - l'umanesimo cristiano.
Il restauro dell'immagine può dunque compiersi soltanto in virtù della croce del Cristo: «Fu la sua ubbidienza fino alla morte a divenire per noi redenzione dei peccatori, libertà dalla morte che regnava per la colpa originale, riconciliazione con Dio, potenza di piacere a Dio, dono di giustizia, comunione dei santi nella vita eterna, eredità del regno dei cieli» (S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1556b).
Ma questo, per Basilio, equivale a dire che tutto ciò si compie in virtù del battesimo.
Che cos'è, infatti, il battesimo, se non l'evento salvifico della morte del Cristo, nel quale siamo inseriti mediante la celebrazione del mistero? Il mistero sacramentale, «imitazione» della sua morte, ci immerge nella realtà della sua morte; come scrive Paolo: «O ignorate che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte?» (Rm 6, 3).
Basandosi appunto sulla misteriosa identità del battesimo con l'evento pasquale del Cristo, al seguito di Paolo anche Basilio insegna che essere battezzati altro non è se non essere realmente crocifissi - cioé inchiodati con il Cristo alla sua unica croce - realmente morire la sua morte, con lui essere sepolti nel suo seppellimento, e conseguentemente con lui risorgere della sua risurrezione (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2).
Coerentemente, perciò, egli può riferire al battesimo gli stessi titoli di gloria con cui l'abbiamo udito inneggiare alla croce: anch'esso è «riscatto dei prigionieri, remissione dei debiti, morte del peccato, rigenerazione dell'anima, abito di luce, inviolabile sigillo, veicolo per il cielo, titolo per il regno, dono della filiazione» (S.Basilii «In sanctum Baptisma»: PG 31, 433ab). E' per esso, infatti, che si salda l'unione fra l'uomo e il Cristo, e che mediante il Cristo l'uomo è inserito nel cuore stesso della vita trinitaria: divenendo spirito perché nato dallo Spirito (cfr. S.Basilii «Moralia», XX,2: PG 31, 736d; «Moralia», LXXX,22: PG 31, 869a) e figlio perché rivestito del Figlio, in un rapporto altissimo con il Padre dell'Unigenito che è ormai divenuto anche, realmente, il Padre suo (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1564c-1565b).
Alla luce di una considerazione così vigorosa del mistero battesimale, si disvela a Basilio il senso stesso della vita cristiana. Del resto, come altrimenti comprendere questo mistero dell'uomo nuovo, se non fissando lo sguardo sul punto luminoso della sua nascita nuova, e sulla potenza divina che nel battesimo lo ha generato?
«Come si definisce il cristiano?», si chiede Basilio; e risponde: «Come colui che è generato da acqua e Spirito nel battesimo» (S.Basilii «Moralia», LXXX,22: PG 31, 868d).
Solo in ciò da cui siamo si rivela ciò che siamo, e ciò per cui siamo.
Creatura nuova, il cristiano, anche quando non ne è pienamente consapevole, vive una vita nuova; e nella sua realtà più profonda, anche se col suo agire lo rinnega, é trasferito in una patria nuova, sulla terra già reso celeste (cfr. S.Basilii «De Spiritu Sancto»: PG 32, 157c; «In sanctum Baptisma»: PG 31, 429b): perché l'operazione di Dio è infinitamente e infallibilmente efficace, e rimane sempre in qualche misura al di là di ogni smentita e contraddizione dell'uomo.
Resta, certo, il compito - ed è, in rapporto essenziale con il battesimo, il senso stesso della vita cristiana - di diventare quello che si è, adeguandosi alla nuova dimensione «spirituale» ed escatologica del proprio mistero personale. Come si esprime, con la consueta chiarezza, san Basilio: «Il significato e la potenza del battesimo è che il battezzato si trasformi nei pensieri, nelle parole e nelle opere, e che diventi - secondo la potenza che gli è stata elargita - quale è colui dal quale è stato generato» (S.Basilii «Moralia», XX, 2: PG 31, 736d).
L'eucaristia, compimento dell'iniziazione cristiana, è sempre considerata da Basilio in strettissimo rapporto con il battesimo.
Unico cibo adeguato al nuovo essere del battezzato e capace di sostenerne la vita nuova e di alimentarne le nuove energie (cfr. S.Basilii «De Baptismo» I, 3: PG 31, 1573b); culto in spirito e verità, esercizio del nuovo sacerdozio e sacrificio perfetto dell'Israele nuovo (cfr. S.Basilii «De Baptismo», II, 2 ss et 8: PG 31, 1601c; S.Basilii «Epistula» 93: PG 32, 485a), solo l'eucaristia attua in pienezza e perfeziona la nuova creazione battesimale.
Perciò, è mistero di immensa gioia - solo cantando vi si può partecipare (cfr. S.Basilii «Moralia»,XXI,4: PG 31, 741a) - e di infinita, tremenda santità. Come si potrebbe, essendo in stato di peccato, trattare il corpo del Signore? (cfr. S.Basilii «De Baptismo», II,3: PG 31, 1585ab). La Chiesa che comunica, dovrebbe davvero essere «senza macchia e ruga, santa e incontaminata» (Ef 5, 27; S.Basilii «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 869b): cioé dovrebbe sempre, con vigile coscienza del mistero che celebra, esaminare bene se stessa (cfr. 1Cor 11,28; S.Basilii «Morali», XXI, 2: PG 31, 740ab), per purificarsi sempre più «da ogni contaminazione e impurità» (S.Basilii «De Baptismo» II, 3: PG 31, 1585ab).
D'altra parte, astenersi dal comunicare non è possibile: all'eucaristia infatti, necessaria per la vita eterna (cfr. S.Basilii «Moralia», XXI, 1: PG 31, 737c), è ordinato lo stesso battesimo, e il popolo dei battezzati deve essere puro proprio per partecipare all'eucaristia (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 869b).
Solo l'eucaristia del resto, vero memoriale del mistero pasquale del Cristo, è capace di tenere desta in noi la memoria del suo amore. Essa è perciò il segreto della vigilanza della Chiesa: le sarebbe troppo facile, altrimenti, senza la divina efficacia di questo richiamo continuo e dolcissimo, senza la forza penetrante di questo sguardo del suo sposo fissato su di lei, cadere nell'oblio, nell'insensibilità, nell'infedeltà. A questo scopo è stata istituita, secondo le parole del Signore: «Fate questo in memoria di me» (1 Cor 11, 24 ss et par.); e a questo scopo, conseguentemente, deve essere celebrata.
Basilio non si stanca di ripeterlo: «Per ricordare (S.Basilii «Moralia», XXI,3: PG 31, 740b); anzi, per ricordare sempre, «per il ricordo indelebile» (S.Basilii «Moralia», XXI, 3: PG 31, 1576d), «per custodire incessantemente il ricordo di colui che è morto e risorto per noi» (S.Basilii «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 1869b).
Solo l'eucaristia dunque, per disegno e dono di Dio, può veramente custodire nel cuore «il sigillo» (cfr. S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 5: PG 31, 921b) di quel ricordo del Cristo che, stringendosi come in una morsa, ci impedisce di peccare. E' perciò particolarmente in rapporto all'eucaristia che Basilio riprende il testo di Paolo: «L'amore di Cristo ci stringe, al pensiero che uno è morto per tutti e quindi tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro» (2 Cor 5,14 ss).
Ma che cos'è poi questo vivere per il Cristo - o «vivere integralmente per Dio» - se non il contenuto stesso del patto battesimale? (cfr. S.Basilii «De Baptismo», II,1: PG 31, 1581a).
Anche per questo aspetto, dunque, l'eucaristia appare essere la pienezza del battesimo: essa sola, infatti consente di viverlo con fedeltà e continuamente lo attualizza nella sua potenza di grazia.
Perciò Basilio non esita a raccomandare la comunione frequente, o addirittura quotidiana: «Comunicare anche ogni giorno ricevendo il santo corpo e sangue del Cristo è cosa buona e utile; poiché egli stesso dice chiaramente: "Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna" (Gv 6, 54). Chi dunque dubiterà che comunicare continuamente alla vita non sia vivere in pienezza?» (S.Basilii «Epistula» 93: PG 32, 484b).
Vero «cibo di vita eterna» capace di nutrire la vita nuova del battezzato è, come l'eucaristia, anche «ogni parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4, 4; cfr. Dt 8, 3; S.Basilii «De Baptismo», I, 3: PG 31, 1573bc).
E' Basilio stesso a stabilire con forza questo nesso fondamentale fra la mensa della parola di Dio e quella del corpo del Cristo (cfr. «Dei Verbum», 21). Benché in modo diverso, infatti, anche la Scrittura, come l'eucaristia, è divina, santa, e necessaria.
Veramente divina, afferma Basilio con singolare energia: cioé «di Dio» nel senso più proprio. Dio stesso l'ha ispirata (cfr. S.Basilii «De iudicio»: PG 31, 664d; S.Basilii «De fide»: PG 31, 677a; ecc...), Dio l'ha convalidata (cfr. S.Basilii «De fide»: PG 31, 680b), Dio l'ha pronunciata mediante gli agiografi (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 13: PG 31, 1092a; «Adv. Eunomium», II: PG 29, 597c; ecc...) - Mosé, i profeti, gli evangelisti, gli apostoli (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 1: PG 31, 1524d) - e soprattutto mediante il suo Figlio (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1561c); lui, l'unico Signore: sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 47: PG 31, 1113a), certo con diversi gradi di intensità e diversa pienezza di rivelazione (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 276: PG 31,1276cd; «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1545b), ma pure senza ombra di contraddizione (cfr. S.Basilii «De fide»: PG 31, 692b).
Di sostanza divina benché fatta di parole umane, la Scrittura è perciò infinitamente autorevole: sorgente della fede, secondo la parola di Paolo (cfr. Rm 10, 17; S.Basilii «Moralia», LXXX,22: PG 31, 868c), è il fondamento di una certezza piena, indubbia, non vacillante (S.Basilii «Moralia», LXXX,22: PG 31,868c). Essendo tutta di Dio, è tutta, in ogni sua minima parte, infinitamente importante e degna di estrema attenzione (cfr. S.Basilii «In Hexaem.», VI: PG 29, 144c; «In Hexaem.», VIII: PG 29, 184c).
E per questo, anche, la Scrittura giustamente viene chiamata santa: poiché, come sarebbe terribile sacrilegio profanare l'eucaristia, sarebbe sacrilegio anche attentare all'integrità e alla purezza della parola di Dio.
Non la si può dunque intendere secondo categorie umane, ma alla luce dei suoi stessi insegnamenti, quasi «chiedendo al Signore stesso l'interpretazione delle cose da lui dette» (S.Basilii «De Baptismo», II, 4: PG 31, 1589b); e non si può «togliere né aggiungere nulla» a quei testi divini consegnati alla Chiesa per tutti i tempi, a quelle parole sante pronunciate da Dio una volta per tutte (cfr. S.Basilii «De fide»: PG 31, 680ab; «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 868c).
E' di necessità vitale, infatti, che il rapporto con la parola di Dio sia sempre adorante, fedele, e amante. Essenzialmente da essa la Chiesa deve attingere per il suo annuncio (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 115: PG 30, 105c 108a), lasciandosi guidare dalle parole stesse del suo Signore (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1533c), per non rischiare di «ridurre a parole umane le parole della religione» (S.Basilii «Epistula» 140: PG 32, 588b). E alla Scrittura deve riferirsi «sempre e dovunque» ogni cristiano per tutte le sue scelte (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 269: PG 31, 1268c), facendosi di fronte ad essa «come un bambino» (cfr. Mc 10, 15; S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 217: PG 31, 1225bc; S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1560ab), in essa cercando il più efficace rimedio contro tutte le sue diverse infermità (cfr. S.Basilii «In Psalmum» 1: PG 29, 209a), e non osando muovere un passo senza essere illuminato dai raggi divini di quelle parole (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 1: PG 31, 1081a).
Autenticamente cristiano, tutto il magistero di Basilio è, come si è visto, «vangelo», proclamazione gioiosa della salvezza.
Non è forse piena di gioia e sorgente di gioia la confessione della gloria di Dio che si irradia sull'uomo sua immagine?
Non è stupendo l'annuncio della vittoria della croce, nella quale, «per la grandezza della pietà e la moltitudine delle misericordie di Dio» (S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 10: PG 31, 1088c), i nostri peccati sono stati perdonati prima ancora che li commettessimo? (cfr. S.Basilii «Regulae bravius tractatae», 12: PG 31, 1089b). Quale annuncio più consolante che quello del battesimo che ci rigenera, dell'eucaristia che ci nutre, della Parola che ci illumina?
Ma proprio per questo, per non avere taciuto o sminuito la potenza salvifica e trasformante dell'opera di Dio e delle «energie del secolo futuro» (cfr. Eb 6,5), Basilio può chiedere a tutti, con molta fermezza, amore totale per Dio, dedizione senza riserve, perfezione di vita evangelica (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX, 22: PG 31, 869c).
Poiché, se il battesimo è grazia - e quale grazia! - quanti l'hanno conseguita hanno effettivamente ricevuto «il potere e la forza di piacere a Dio» (S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 10: PG 31, 1088c), e sono perciò «tutti ugualmente tenuti a conformarsi a tale grazia», cioé a «vivere conforme al Vangelo» (S.Basilii «De Baptismo», II,1: PG 31, 15980ac).
«Tutti ugualmente»: non ci sono cristiani di seconda categoria, semplicemente perché non ci sono battesimi diversi, e perché il senso della vita cristiana è tutto intrinsecamente contenuto nell'unico patto battesimale (S.Basilii «De Baptismo», II,1: PG 31, 1580ac).
«Vivere conforme al Vangelo»: che cosa significa questo, in concreto, secondo Basilio?
Significa tendere, con tutta la brama del proprio essere (cfr. S.Basilii «Regulae brevius tractatae», 157: PG 31, 1185a) e con tutte le nuove energie delle quali si dispone, a conseguire il «compiacimento di Dio» (cfr. S.Basilii «Moralia», I, 5: PG 31, 704a et passim)
Significa, per esempio, «non essere ricchi, ma poveri, secondo la parola del Signore» (cfr. S.Basilii «Moralia», XLVIII,3: PG 31, 769a), realizzando così una condizione fondamentale per poterlo seguire (cfr. S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 10: PG 31, 944d-945a) con libertà (cfr. S.Basilii «Regulaea fusius tractatae», 8: PG 31, 940bc; «Regulae fusius tractatae», 237: PG 31, 1241b), e manifestando, rispetto alla norma imperante del vivere mondano, la novità del Vangelo (cfr. S.Basilii «De Baptismo», I, 2: PG 31, 1544d). Significa sottomettersi totalmente alla parola di Dio, rinunciando alle «proprie volontà» (cfr. S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 6 et 41: PG 31, 925c et 1021a) e facendosi ubbidienti, a imitazione del Cristo, «fino alla morte» (cfr. Fil 2, 8; S.Basilii «Regulae fusius tractatae», 28: PG 31,989b; «Regulae brevius tractatae», 119: PG 31, 1161d et passim).
Davvero, Basilio non arrossiva del Vangelo: ma, sapendo che esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede (cfr. Rm 1, 16) lo annunciava con quella integrità (cfr. S.Basilii «Moralia», LXXX, 12: PG 31, 864b) che lo fa essere pienamente parola di grazia e sorgente di vita.
Ci piace infine rilevare che san Basilio, anche se più sobriamente del fratello san Gregorio di Nissa e dell'amico san Gregorio di Nazianzo, celebra la verginità di Maria (cfr. S.Basilii «In sanctam Christi generationem», 5: PG 31, 1468b): chiama Maria «profetessa» (cfr. S.Basilii «In Isaiam», 208: PG 30, 477b) e con felice espressione così motiva il fidanzamento di Maria con Giuseppe: «Ciò avvenne perché la verginità fosse onorata e non fosse disprezzato il matrimonio» (cfr. S.Basilii «In sanctam Christi generationem», 3: PG 31, 1464a).
L'anafora di san Basilio sopra ricordata contiene lodi eccelse alla «tutta santa, immacolata, ultrabenedetta e gloriosa Signora Madre-di-Dio e sempre-vergine Maria»; «Donna piena di grazia, esultanza di tutto il creato...»
4. Conclusione
Di questo grande santo e maestro tutti noi, nella Chiesa, ci gloriamo di essere discepoli e figli: riconsideriamo dunque il suo esempio, e riascoltiamo con venerazione i suoi insegnamenti, con intima disponibilità lasciandoci ammonire, confortare ed esortare.
Affidiamo questo nostro messaggio in modo particolare ai numerosi ordini religiosi - maschili e femminili - che si onorano del nome e della tutela di san Basilio e ne seguono la Regola, impegnandoli in questa felice ricorrenza a propositi di nuovo fervore in una vita di ascesi e contemplazione delle cose divine, che poi sovrabbondi in opere sante a gloria di Dio e a edificazione della santa Chiesa. Per il felice conseguimento di tali scopi, imploriamo anche l'aiuto materno della Vergine Maria, come auspicio di doni celesti e pegno della nostra benevolenza, con grande affetto vi impartiamo l'apostolica benedizione.
Dato a Roma, presso san Pietro, il 2 gennaio, nella memoria dei santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, Vescovi e Dottori della Chiesa, dell'anno 1980, secondo di Pontificato.
GIOVANNI PAOLO II
[Patres Ecclesiae; Lettera Apostolica per il XVI centenario della morte di s. Basilio]
Non troveremo un muro
Questo passo del Vangelo di Giovanni (cfr 12,44-50) ci fa vedere l’intimità che c’era tra Gesù e il Padre. Gesù faceva quello che il Padre gli diceva di fare. E per questo dice: «Chi crede in me non crede in me, ma in Colui che mi ha mandato» (v. 44). Poi precisa la sua missione: «Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre» (v. 46). Si presenta come luce. La missione di Gesù è illuminare: la luce. Lui stesso ha detto: «Io sono la luce del mondo» (Gv 8,12). Il profeta Isaia aveva profetizzato questa luce: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce» (9, 1). La promessa della luce che illuminerà il popolo. E anche la missione degli apostoli è portare la luce. Paolo lo disse al re Agrippa: “Sono stato eletto per illuminare, per portare questa luce – che non è mia, è di un altro – ma per portare la luce” (cfr At 26,18). È la missione di Gesù: portare la luce. E la missione degli apostoli è portare la luce di Gesù. Illuminare. Perché il mondo era nelle tenebre.
Ma il dramma della luce di Gesù è che è stata respinta. Già all’inizio del Vangelo, Giovanni lo dice chiaramente: “È venuto dai suoi e i suoi non lo accolsero. Amavano più le tenebre che la luce” (cfr Gv 1,9-11). Abituarsi alle tenebre, vivere nelle tenebre: non sanno accettare la luce, non possono; sono schiavi delle tenebre. E questa sarà la lotta di Gesù, continua: illuminare, portare la luce che fa vedere le cose come stanno, come sono; fa vedere la libertà, fa vedere la verità, fa vedere il cammino su cui andare, con la luce di Gesù.
Paolo ha avuto questa esperienza del passaggio dalle tenebre alla luce, quando il Signore lo incontrò sulla strada di Damasco. È rimasto accecato. Cieco. La luce del Signore lo accecò. E poi, passati alcuni giorni, con il battesimo, riebbe la luce (cfr At 9,1-19). Lui ha avuto questa esperienza del passaggio dalle tenebre, nelle quali era, alla luce. È anche il nostro passaggio, che sacramentalmente abbiamo ricevuto nel Battesimo: per questo il Battesimo si chiamava, nei primi secoli, la Illuminazione (cfr San Giustino, Apologia I, 61, 12), perché ti dava la luce, ti “faceva entrare”. Per questo nella cerimonia del Battesimo diamo un cero acceso, una candela accesa al papà e alla mamma, perché il bambino, la bambina è illuminato, è illuminata.
Gesù porta la luce. Ma il popolo, la gente, il suo popolo l’ha respinto. È tanto abituato alle tenebre che la luce lo abbaglia, non sa andare… (cfr Gv 1,10-11). E questo è il dramma del nostro peccato: il peccato ci acceca e non possiamo tollerare la luce. Abbiamo gli occhi ammalati. E Gesù lo dice chiaramente, nel Vangelo di Matteo: “Se il tuo occhio è ammalato, tutto il tuo corpo sarà ammalato. Se il tuo occhio vede soltanto le tenebre, quante tenebre ci saranno dentro di te?” (cfr Mt 6,22-23). Le tenebre… E la conversione è passare dalle tenebre alla luce.
Ma quali sono le cose che ammalano gli occhi, gli occhi della fede? I nostri occhi sono malati: quali sono le cose che “li tirano giù”, che li accecano? I vizi, lo spirito mondano, la superbia. I vizi che “ti tirano giù” e anche, queste tre cose – i vizi, la superbia, lo spirito mondano – ti portano a fare società con gli altri per rimanere sicuri nelle tenebre. Noi parliamo spesso delle mafie: è questo. Ma ci sono delle “mafie spirituali”, ci sono delle “mafie domestiche”, sempre, cercare qualcun altro per coprirsi e rimanere nelle tenebre. Non è facile vivere nella luce. La luce ci fa vedere tante cose brutte dentro di noi che noi non vogliamo vedere: i vizi, i peccati… Pensiamo ai nostri vizi, pensiamo alla nostra superbia, pensiamo al nostro spirito mondano: queste cose ci accecano, ci allontanano dalla luce di Gesù.
Ma se noi iniziamo a pensare queste cose, non troveremo un muro, no, troveremo un’uscita, perché Gesù stesso dice che Lui è la luce, e anche: “Sono venuto al mondo non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo” (cfr Gv 12,46-47). Gesù stesso, la luce, dice: “Abbi coraggio: lasciati illuminare, lasciati vedere per quello che hai dentro, perché sono io a portarti avanti, a salvarti. Io non ti condanno. Io ti salvo” (cfr v. 47). Il Signore ci salva dalle tenebre che noi abbiamo dentro, dalle tenebre della vita quotidiana, della vita sociale, della vita politica, della vita nazionale, internazionale… Tante tenebre ci sono, dentro. E il Signore ci salva. Ma ci chiede di vederle, prima; avere il coraggio di vedere le nostre tenebre perché la luce del Signore entri e ci salvi.
Non abbiamo paura del Signore: è molto buono, è mite, è vicino a noi. È venuto per salvarci. Non abbiamo paura della luce di Gesù.
[Papa Francesco, omelia s. Marta 6 maggio 2020]
Maria, l’Arte della Rinascita
(Nm 6,22-27; Lc 2,16-21)
Benedire il popolo era antica prerogativa del sovrano che agiva in nome di Dio e in un primo tempo aveva funzioni sacerdotali.
Ma in atteggiamento d’incontro che rende presente Dio ‘in mezzo’ alle folle - il popolo del suo Volto - quello del re antico diventa anche un atto di culto da ritrovare.
Abbiamo bisogno di sentire che siamo benedetti: per non spegnerci, per rigenerare la verità affettiva che ci abita e riporta alla vita, quindi contemplarla e così avviare qualsiasi avventura.
La maledizione non rafforza, indica un rifiuto; ci separa. Benedire è la via della condivisione e della Pace, ossia della raggiunta completezza.
In Israele la benedizione divina era (infine) attesa in guisa materiale. Ma la formula del sacerdozio aronnita attesta l’idea originaria che la vita umana non ha il suo segreto nella configurazione più ovvia.
Infatti, anche noi sappiamo che le situazioni parziali e di solo conforto, irenismo, benessere e sicurezza, si trasformano nel loro opposto - non fanno crescere l'integrità della vita [autentico senso biblico dello Shalôm].
Chi non segue intuizioni innate, un richiamo più radicale del sé, o annunci sbalorditivi (Lc 1,26-38. 2,8-15) non sviluppa il suo destino, non si muove, non rimette le cose a posto.
I proclami comuni finiscono per incenerire le personalità.
È vero che i pastori non trovano nulla di straordinario e prodigioso, se non una famiglia ridotta in una condizione ordinaria che conoscono.
Ma è quel semplice focolare a coinvolgerli nel nuovo progetto di Dio, e nell’annuncio della sua scandalosa Misericordia senza condizioni - che non li ha fulminati per impurità.
La religione li aveva bollati per sempre: esseri persi, spregevoli, senza rimedio.
Ora sono liberi dall’identificazione. Hanno un ‘altro occhio’ - come quello della “prima volta”: sguardo che li porterà al cento per cento.
Esodati che si trovano davanti un’immagine di Dio indifeso, essi non si preoccupano d’impegnarsi in una disciplina etica, che li avrebbe sgretolati.
Godono lo stupore d’una realtà semplicemente umana - in una misteriosa relazione di reciproco riconoscimento.
Strano che il modesto segno - un bimbo in una mangiatoia, luogo impuro dove si trastullavano le bestie - li convinca, faccia loro recuperare stima, li renda evangelizzatori [forse neanche assidui].
Al pari del Calvario cui rimanda, la Manifestazione risolutiva dell’Eterno è un paradosso.
Ma la geografia affettiva di questa Betlemme priva di circuiti conformisti resta intatta, perché spontaneamente radicata in noi.
C’è un senso d’immediatezza, senza particolari intrecci o cerimonie.
Il Bambino neppure viene adorato dagli sguardi ora “puri” dei piccoli, vilipesi cani della prateria e delle transumanze - come viceversa faranno i Magi (Mt 2,11).
Loro neanche sapevano cosa significasse, riflettere cerimoniali di corte orientali - come il bacio delle pantofole.
I miserabili della terra [i lontani dei greggi] sono coloro che ascoltano l’Annuncio, verificano prontamente, e fondano la nuova ‘stirpe’ divina.
Gente non tormentata dal giudizio statico, bensì ora «in mezzo» a tutti gli uomini e non più ad alta quota.
(Lc 2,16-21)
Maria ricercava il senso delle sorprese (v.19). Così rigenerava, per un nuovo modo di capire e stare insieme - per dare alla luce anche il mondo interno di tutto un diverso popolo della pienezza.
Ella ‘metteva insieme’ fatti e Parola, per scoprirne il filo conduttore, per rimanere ricettiva e non farsi condizionare dalle convinzioni inflessibili, che non le avrebbero dato scampo.
La Madre stessa, pur colta di sorpresa, si preparava all’eccentricità di Dio, senza allontanarsi dal tempo e dalla condizione reale.
La sua figura e quella dei pastori c’interpellano, chiedono il coraggio di una risposta - ma dopo aver lasciato fluire lo stesso genere di ‘presenze interiori’, visitatrici degne, cui è concesso esprimersi.
Anche Lei ha dovuto come noi passare dalle credenze dei padri alla Fede nel Padre. Dall’idea dell’amore come premio a quella del ‘dono’.
La Buona Novella proclama un capovolgimento: ciò che la religione d’altri tempi aveva considerato lontano dall’Altissimo, è vicinissimo a Lui; anzi, gli corrisponde appieno.
È spalancata l’avventura della Fede. E il nuovo Bimbo ha un Nome che ne esprime l’inaudita essenza di Salvatore, non di giustiziere.
Tutta la sua vicenda sarà appunto pienamente istruttiva anche sotto il profilo di come interiorizzare incertezze e disagi: questi momenti “no” e le precarietà c’insegnano a vivere.
Infatti, anche noi come Maria «andiamo riconoscendo» la presenza di Dio negli enigmi della Scrittura, nel Piccolo ‘avvolto in bende’ - persino nell’eco ancestrale dei nostri mondi interni.
E ci lasciamo andare - non sappiamo bene dove. Ma così è l’Infinito, nelle sue pieghe.
Il saggio Sogno che abita l’umano sa di humus antico, ma il suo eco rinasce ogni giorno, nella marea dell’essere che orienta a ‘guardare’ davvero, senza veli.
Un contegno conformista d’imbattersi e ‘vedere’ esteriormente le cose, non risolverebbe il problema.
Talora per non farsi condizionare bisogna riedificarsi nel silenzio, come la Vergine; costruirsi una sorta di isola ermeneutica che schiuda porte differenti, che introduca altre luci.
Entro il suo circuito sacro anche la Madre di Dio valorizzava le innate energie trasformative, proprio radicandole sugli interrogativi.
In tal guisa, tornando al suo essere primordiale e al senso del Neonato - immagine antica, cara a molte culture.
Entrava in un Altrove e non usciva dal campo del reale: dentro il suo Centro, senza fretta.
Ricercando il Sole annegato nel suo essere e che tornava, emergeva, risorgeva nell’intimo, la faceva esistere oltre.
Così non si lasciava assorbire energie da idee tradizionali o da situazioni esterne, che pure volevano rompere l’equilibrio.
Nella sua vereconda solitudine - colma di Grazia - quell’io superiore e celato nell’essenza veniva sempre più a Lei, si faceva nuova Alba e guida.
Non voleva vivere dentro pensieri, saperi e ragionamenti dintorno - nessuno capace di amplificare la vita - tutti in mano alle droghe delle convenzioni, disumanizzanti l’Incanto.
La magia felice di quel Frugolo di carne portava la sua Pace.
I Sogni sostenevano e veicolavano il suo Centro - facendo scorrere una vita nuova dal Nucleo della sua Persona, e la giovinezza del mondo.
[Maria Ss.ma Madre di Dio, 1 gennaio]
L'Incredibile dell'anno
All’inizio dell’anno nuovo, un ricco signore ebbe un’idea: solo la persona capace di fare la cosa più incredibile dell'anno doveva ereditare ogni suo bene.
Gli amici impegnarono tutta la loro fantasia.
Alcuni anziani - per voler rincorrere il proprio gusto - fecero indigestione e rischiarono di morire a forza di mangiare e bere.
Alcuni monelli si esercitarono invece a roteare capriole mortali.
Poi fu allestita un'intera mostra di trovate incredibili. Una persona recitava la parte dì Mosè sulla Montagna con le Tavole della Legge, ma gli risultò difficile riprodurre lampi e tuoni; la scenografia retrostante era statica e antiquata.
Un tizio travestito da cornacchia raccontava storie e antichi ricordi, vicino a una stufa spenta.
Qualcuno si vestì da impresario di pompe funebri, ma le persone non apprezzarono la sua aria troppo professorale né il suo loden.
Altri vollero mettere in scena le Beatitudini, dimenticando però quella dei perseguitati.
Un artista sfregiava i suoi stessi quadri; uno scultore martellava come un forsennato, però il frastuono della sua mola era ancora più insopportabile.
Un falegname lavorava molto bene ad uno scrigno, ma a giudizio di tutti sollevò troppa pula, lasciando a terra una quantità eccessiva di trucioli.
D'improvviso irruppe un buttafuori alto come un gorilla e forzuto come Maciste: «Sono io l'uomo della cosa più incredibile».
Coi pugni mise k.o. gli astanti e con un'ascia sferzò ogni cosa attorno, tutto riducendo in brandelli.
Qualsiasi oggetto venne distrutto e ciascuno rimaneva tramortito al tappeto. «Ecco quello di cui sono capace!» - disse l'uomo - «la mia azione ha battuto l'universo intero! Io ho fatto la cosa più incredibile, e non solo dell'anno!».
I giudici della contesa rimasero perplessi, ma a quel punto sembrava non potessero concedere la palma della vittoria a nessun altro...
Nell'atmosfera di annientamento generale, spuntò non si sa da dove l'ultimo della lista; un certo Cristoforo. Egli propose di andare a Levante passando da Ponente. Tutti risero a squarciagola, ma costui chiese tempo.
Così, al termine della sua vicenda fatta di calcoli sbagliati e venti - talora anche - favorevoli, dimostrò di poter approdare a una terra nuova, più ricca di ogni dove e prima impensata. (Spesso però passando attraverso notizie imprecise e forze in apparenza distruttive).
Tutto cambiò, per quel suo coraggio da visionario.
Da quel momento il continente da cui salparono le caravelle divenne nell’accezione comune "il vecchio mondo", che infatti - sazio e disperato, bloccato sulle sue posizioni - invecchiò anche demograficamente e in modo via via irreparabile; rovinandosi.
Quell'avventura assurda - metafora del viaggio di ciascuno che non impara a trattenere - proruppe allora come tipo d'una nuova proposta di vita, aperta e creativa, incline alla meraviglia.
La varietà delle esperienze e persino il ventaglio delle fantasticherie non furono più additate a oltraggio dei costumi, ma divennero valore aggiunto.
Tal modello di proposta (visioni che anticipavano bisogni) man mano emerse nella pedagogia comune.
Venne adottata anche dai pellegrini dello Spirito come icona positiva del Nuovo Patto fra Dio e l'uomo - ora capace di valorizzare l'intricato miscuglio di valori e criteri del nostro cuore; coi suoi interessi comuni e di terra, ma rapiti nei sogni più sublimi.
Per una vita cristiana non fatta di cosmetica, ma di esplorazione e sorpresa; programma di tutto l'anno.
Così Cristoforo cambiò la storia, veleggiando al contrario.
Dio domestico, e Visite che non ci aspetteremmo
Maria, l’Arte della Percezione che rompe gli schemi
(Lc 2,19) (Lc 1,26-38)
Per una vita dall’Io autentico al Culmine sconosciuto
«Ora, Maria conservava e custodiva tutte - proprio tutte - queste parole-evento, mettendole insieme e comparandole nel suo cuore» [senso del testo greco].
Cosa ne era di lei, del Figlio e di tutti gli altri?
Voleva capire le affinità essenziali - con l'anima e altrove: il senso degli strani e semplici accadimenti. Regola d’oro anche per noi.
Nel ritratto di Gesù che allattava, il suo silenzio non permaneva collocato - e non si lasciava demotivare: scavando.
Per questo conosceva ben più cose espressive di tante menti - sublimi eppure incapaci di uscire dagli automatismi, già allagate di dottrine e tradizioni ragguardevoli.
Siamo volentieri anche noi lì, con Maria; in una cultura che c’invade i sensi e inquina l'anima di opinioni rumorose, di modelli apparentemente eloquenti ma che mettono in ginocchio: stressanti e futili.
Tutte riproduzioni enfatiche, d’impatto - ma esterne.
Eppure debordano nell’intimo, e malgrado le apparenze scintillanti, chiudono la personalità in uno spazio ristretto, di abitudini malsane, solo da esibire.
Ci costringiamo infatti a correre da una parte all’altra, spesso a recitare prototipi. Appunto, intrigati a forza da piani, organigrammi e pensieri, anche devoti, i quali divengono però forme di banalizzazione personale e sociale.
Ci stiamo abituando alla paura del nostro lato discreto, riservato, non pettegolo, appartato, nascosto, tutto nostro e vicino alla Fonte: in una parola, custode della Chiamata per Nome - che vuol fare pausa per tornare all’Ascolto antico del nuovo.
Un lato che ancora non conosciamo: esso non ha mai lo stesso tono di sempre. È tutto nostro, ma allude agli incontri veri.
Affinando la visione interiore, cogliamo la nostra scaturigine e il senso della storia; e le sue pieghe - così possiamo partorire ancora il mondo prezioso dentro e fuori di noi.
Lo facciamo a partire dall’impalpabile che fa da perno dell’essenza. E custodisce il Fuoco dentro.
Per un tratto - sempre più breve - gli opinionisti ufficiali c’illudono di stare al centro del mondo.
Vogliono inocularci il falso senso di protagonismo e permanenza che rapidamente svanisce; in realtà, ci travolgono.
Sentiamo il bisogno di una riscoperta dell’essere e dell’essenza, non dissolti nel regno della notte e dell’illusione [avere potere apparire, trattenere salire dominare]. Senza fughe, né ritmi che non ci appartengono.
Cerchiamo un coinvolgimento, e una distanza.
Vogliamo ‘percepire’ come Maria e come i pastori - sconclusionati da opinioni religiose altrui - per divenire e rinascere, e divenire ancora. Recuperando le frenesie, le sorprese, le ferite; senza disperdere il Centro.
“Rifugiarsi” in uno spazio segreto non era per Lei un ritrovare la se stessa attesa da tutti, stereotipa e adeguata come sempre.
Esprimeva piuttosto il suo essere - in fuga dai modi convenzionali.
Per vivere intensamente non desiderava entrare nella nomenclatura - poi essere normale, e asservita - piuttosto allontanarsi, ma stando lì. Perciò non escludeva nulla.
Si è riconosciuta pure in quei vagabondi.
Mai si sarebbe immaginata protagonista (recitante) d’una tradizione che l’ha collocata su piedistalli, forme, attributi solenni, e costrizioni - proprio quelle che l’avrebbero resa dolcemente ma decisamente ribelle.
Non si rivisitava per crogiolarsi, bensì per verificare e riattivare il suo ‘modo’ - che non voleva perdere: poteva essere travolto da pareri esterni e seppellito da circostanze [impellenti ma senza orizzonte].
Non voleva smarrire il proprio Indirizzo dentro mete comuni, omologate, perdendo di vista ciò che era davvero, e la introduceva nel cielo del senza tempo - né bramava assomigliare alla maggioranza, o starle sopra.
Quella che le abbiamo costruito noi, non è casa sua.
Maria non si affacciava sulla realtà e oggi dentro di noi [per aiutarci a guardare il “nostro” Mistero] col viso conforme; edulcorato e artefatto, o intimista, paludoso.
La sua anima era sempre in viaggio. Per conoscere l’inconoscibile, mai si sarebbe fermata - anche senza sapere in anticipo dove andare.
Il suo carattere non voleva le certezze della sistemazione. Senza tentennare, anche in sé preferiva intuire e vivere la Passione d’amore.
Si lasciava guidare e salvare, ma a partire dal suo stesso centro sacro, santuario del Dio-Con. Colui che sblocca, c’incammina, e libera.
Non poteva consentire che la sua Vocazione venisse coperta da idoli, né da alcuna trama, che pur si stava svolgendo.
Nel ‘qui e ora’ ritrovava la sua affinità proprio dal suo stesso essere viandante, che avanzando poneva i disagi alle spalle.
Sviluppando l’occhio interiore, trasmutava anche il suo interno per ritrovare il passo dell’Annunciazione nascosta nei disadattati, che ancora la conduceva.
Solo questo le durava negli anni - non il lato funzionale.
Non sognava di fare una vita tranquilla, bensì di capire la personale missione.
Senza ingenuità s’interrogava sul significato delle chiamate intime, degli accadimenti, delle vie traverse, e dei suoi moti - estranea solo all’ansia di piacere a tutti.
Desiderava comprendere come inserirsi al meglio, procedendo verso la nuova terra promessa [cf. Lc 1,29: «Ma fu molto turbata per la Parola e si domandava che saluto fosse questo»; Lc 1,34: «Come sarà questo?»].
La quiete dentro non era uniforme, bensì colma delle vicissitudini e di ‘notizie’ imprevedibili.
Mai avrebbe voluto diventare modello: un documento d’identità scaduto - ingessato, dogmatico. Mai icona di privilegi, e sfarzosa - come una donna che spegne la sua consapevolezza, e si rende identificata, vuota, vetusta, disgiunta.
In mezzo agli altri - persino lazzaroni, poco delicati, indiscreti - Maria lasciava fare, percependo i suoni inudibili del silenzio dell’anima.
Note che producevano la sua figura e - ancor meglio - la sua evoluzione e Destinazione, senza disturbarla con ostinazioni separate.
Togliendo lo sguardo dall’intenzione conformista.
Per esistere davvero, intensamente, cambiava o faceva breccia; recuperava la storia ma ascoltava l’interno di sé.
Cogliendo i propri strati profondi, percependosi nelle voci più intime, prendeva coscienza del senso della sua vita, e della storia che si svolgeva.
Negl’intervalli di pensiero, riattivava l’energia dello ‘sguardo’.
E senza mortificazioni portava l’attenzione su un’altra dimensione, entrando gradualmente nel Vento che incessantemente la disinnestava.
In tal guisa, imparava a non aspettarsi qualcosa di allineato ai propositi e previsioni normali, né alla graduatoria sociale e culturale: doveva introdursi nelle vicende, e staccarsi (per contemplarne l’importanza e profondità).
Misteriosamente - così scrutando senza troppo fare - leggeva le ‘note’, sceglieva i registri giusti; interpretava lo spartito.
Epifania di Dio in una creatura del tutto priva di stile ieratico o cortese; piuttosto, delicato e gitano.
Non si è precipitata a mettere a posto le cose: intuiva «dentro» la vita sommaria, invece che condurla e organizzarla, o disporla.
Attendeva che il suo Sé eminente facesse da guida allo strano percorso non dirigista né volontarista che si stava dispiegando, davvero tutto eccentrico e poco esemplare.
Non si attivava per compiacere.
Impariamo in Lei anche noi: a vedere accadere il Dio domestico, le ‘visite’ che non aspetteremmo; l'intensità delle cromie differenti.
Esse che poi ci portano a un diverso sguardo anche nell’anima; coinvolta e distaccata.
Al pari della realtà circostante, Maria non era sempre uguale.
Non aveva in mente un campione da inseguire sino in fondo, per poi trovarsi cronicizzata nell’esemplarità altrui - sradicata, esteriore, dissipata e scarica.
Situazioni ed emozioni avevano valore, non solo né anzitutto sulla base del registro a paradigmi - ormai inutile - con cui venivano interpretate.
Nella speranza delle cose presenti e nel loro sensibile Ascolto, veniva acquisendo fluidità.
In tal guisa, passando senza forzature dalla religione dei padri alla Fede, al rischio d’amicizia nell’imprevedibile proposta dell’unico Padre.
Ritirata nella Dimora dello Spirito, dentro una Speranza che si svelava onda su onda, imparava a comprendere le relazioni e le energie interiori, non impacchettate.
Una volta ascoltate e assunte, esse potevano deviare, e prendere proprio la strada inattesa.
Passo dopo passo, l’occhio, l’orecchio e il cuore attenti introducono anche noi - come Maria - in un territorio di sospensione delle intenzioni chiuse. Dove abita l’amore e il destino della Novità di Dio.
Espandeva la Visione non a partire unicamente dattorno.
Dispiegando il suo perdersi nel Noi, non selettivo, ma solo dal proprio centro sacro, anche l’orizzonte dilatava nella sensazione d’infinito in azione.
Nella contemplazione degli eventi, rendeva più corposa e persino reinventava la figura del cuore che l’aveva guidata fin lì.
Reinterpretava ancora l’immagine espressiva della sua Vocazione. E cambiava il suo destino - non dando peso alle angolazioni unilaterali.
Niente obblighi e propositi cesellati - controcorrente ma naturale, senza la lacerazione degli sforzi titanici.
Così perfino i disagi l’avvicinavano alla sua Missione di Madre della nuova umanità, nel Figlio.
E ciascuno egualmente ritrova l’energia della suggestione primordiale che lo conduce, affinché nella Meditazione riabbracci il Richiamo della Chiamata che vuole ancora strapparlo dalla palude.
Eco dell’Appello primigenio che s’intesse agli accadimenti ed è già la Destinazione.
Testimonianza ogni istante da riscoprire nel “vuoto intimo e colmo” da fare dentro, per attendere qualcosa che non sappiamo prima cosa sia.
Maria si faceva tracciare nel tempo dall’Amore senza brevetto.
Tali i Sogni delle creature totalmente immerse nelle passioni vere, che colgono, anticipano e attualizzano il senza-tempo nel tempo.
Non rinunciava a chiedersi cosa - dai molteplici aspetti - la stava abitando e silenziosamente guidava.
La immaginiamo ancora (v.19) ‘come ad occhi chiusi’: situazione che la nostra cultura spesso ignora.
Non pensava le cause efficienti: era per riscoprire altrimenti il suo aprire la porta ai visitatori, e a ogni novità da stupore.
Stava già allattando, non solo il Figlio; al contempo alimentava se stessa.
Non per vano intimismo riscopriva il Mistero sottile annidato nel diverso - e nel cangiante e crudo - imprevedibile dentro e fuori.
Senza rendersi conto, già nutriva il mondo, custodendosi.
Vera, giunge sino a noi e in noi, accudendo il nido dell’essenza e della storia... senz’apparenza alcuna di stendardi e vetrine - rispettando solo ciò che capita.
Similmente la sua intera Famiglia diventa la vera signora feconda di una Festa dell’Annuncio impossibile attorno - che non si capisce da dove sia nata (Lc 1,20).
Sicuramente da nulla di esteriore. Perciò decisivo.
Totalmente aderente alle circostanze e presente in sé, diveniva completamente - nei moti nitidi e spontanei, anche altrui.
Certo non aveva attorno gente che potesse vantare paraventi. Solo strani individui, ma che incessantemente lasciavano emergere l’istinto vitale.
Anche loro non si dicevano prima dove bisognasse andare. Per questo si ritrovavano in un’incessante gravidanza.
Avevano in serbo solo l’esperienza delle distanze; spesso gelo e rifiuto.
Mai conosciuta una figura che li aiutasse a riconoscersi completamente, e a guardare le cose dal punto di vista della soavità intramontabile scoperta.
Persino capaci di tendere al globale più largo e comprensivo [noi diremmo, all’eternità servizievole della condizione angelica].
Eccoli invece incendiati dalla Fiamma perenne - quella del mondo intero (passato, presente e futuro) che sa recuperare e stare nascostamente, a parte ma nel cosmo - come aurora e giorno del Signore.
Nella cultura del tempo, condizione degli spiriti del servizio al trono celeste, che glorificavano e lodavano Dio (v.20) «per tutto quello che avevano udito e avevano visto».
Di fronte alla Famiglia Chiesa domestica, in Maria e Gesù i pastori fanno un’esperienza decisiva.
Non più di carenza e giudizio unilaterali, ma di rinascita nella stima; di un altro mondo, disponibile e inclusivo - d’un altro regno, unisono senza uniformità.
La Madre di Dio è una possibilità di tendere all’eterno presente, non più esclusivo: ma come una danza, dove il tutto che cambia mette perfettamente a proprio agio - senza già le tracce da ricalcare.
Gli stravaganti della società, pellegrini e cani della prateria raccogliticci, abili solo nelle transumanze, forse mai avevano avuto la capacità di riconoscere l’estasi dello stare bene e intensamente nel sommario.
Forse mai avevano avuto l’esperienza di riconoscere in una creatura accurata il loro stesso lato sensibile, tenero e femminile.
Aspetto che nella Donna Chiesa autentica si fa custode e diversamente banditore [nei malfermi] dello scrigno della Vita.
Dal tepore di Maria e della Culla, fra i loro labirinti, ormai portavano nel proprio luogo appartato una benedizione entusiasmante, e il lato intimo indistruttibile; anche altrove.
Per mettere in discussione anche noi.
Cerchiamo un’anima silenziosa, per un’arte della rinascita.
Ecco Maria: ella aveva notato, mentre meditava, che di riflesso anche gli altri lo facevano.
Quando si ritagliava energie preparatorie, anche attorno ci si disponeva in modo più equilibrato, pieno all’Annuncio.
Camminava nella vita per custodire e alimentare nuovi padri e madri di umanizzazione.
Non per commentare, ma per intuire e sciogliere; per non spegnere il lato sognante con la parte “all’altezza”, vecchia.
Il suo regno della verecondia che cura l’io e il Tu era il cielo e la terra delle nuove potenze.
Virtù affidabili perché scaturite dal Silenzio della Via che la stava rinnovando completamente - amando le contraddizioni.
Perché tutto ora può accadere, rigenerare; e ogni giorno recare la sua marea (dell’inedito) nella presenza di Spirito, senza routine.
Un’anima genuina, priva di finzioni... lo può fare.
Per un’avventura che spinge via la continuità, ricolma di Eros fondante; per un’esplorazione diretta al Culmine sconosciuto.
Maria: Rallentando un po’, si Nasce
Chi non segue intuizioni innate, un richiamo più radicale del sé, o annunci sbalorditivi [Lc 1,26-38. 2,8-15] non sviluppa il suo destino, non si muove; non rimette le cose a posto.
I proclami comuni finiscono per incenerire le personalità.
È vero che i pastori non trovano nulla di straordinario e prodigioso, se non una famiglia ridotta in una condizione ordinaria, che conoscono.
Ma è quel semplice focolare a coinvolgerli nel nuovo Progetto, e nell’annuncio della sua scandalosa Misericordia senza condizioni - che non li ha fulminati per impurità.
La religione arcaica li aveva bollati per sempre: esseri persi, spregevoli, senza rimedio. Ora sono liberi dall’identificazione.
Hanno un altro occhio - come quello della prima volta. Sguardo che li porterà al cento per cento.
Esodati che si trovano davanti un’immagine di Dio indifeso, essi non si preoccupano d’impegnarsi in una disciplina etica: li avrebbe sgretolati.
Piuttosto, godono lo stupore d’una realtà semplicemente umana - in una misteriosa relazione di reciproco riconoscimento.
Un bimbo in una mangiatoia, luogo impuro dove si trastullavano le bestie.
Strano che il modesto segno li convinca, che faccia loro recuperare la stima, e li renda evangelizzatori - forse neanche assidui.
Al pari del Calvario (cui rimanda), la Manifestazione risolutiva dell’Eterno è un paradosso.
Ma la geografia affettiva di questa Betlemme priva di circuiti conformisti resta intatta, perché spontaneamente radicata in noi.
C’è un senso d’immediatezza, senza particolari intrecci o cerimonie.
Il Bambino neppure viene adorato dagli sguardi ora “puri” dei piccoli, vilipesi cani della prateria e delle transumanze - come viceversa faranno i Magi (Mt 2,11).
Loro neanche sapevano cosa significasse, riflettere cerimoniali di corte orientali - come il bacio delle pantofole rosse.
[Per questo motivo Papa Francesco le ha rifiutate, insieme all’ermellino - dopo che Paolo VI aveva avuto il coraggio di deporre il segno pluridirigista delle tiare, con le sue tre corone sovrapposte; un pochino più intricata è stata la vicenda dell’anacronistica sedia gestatoria].
I miserabili della terra e i lontani dei greggi sono coloro che ascoltano l’Annuncio, verificano prontamente, e fondano la nuova stirpe divina.
Gente non tormentata dal giudizio statico - uomini in mezzo a tutti; non più ad alta quota.
Intanto Maria ricercava il senso delle sorprese e così rigenerava, per un nuovo modo di capire e ‘stare’ insieme - per dare alla luce anche il mondo interno di tutto un diverso popolo della pienezza.
Ella metteva insieme fatti e Parola, per scoprirne il filo conduttore.
E rimanere ricettiva; non farsi condizionare dalle convinzioni dei recinti devoti - targati e inflessibili, che non le avrebbero dato scampo.
La Madre stessa, pur colta di sorpresa, si preparava all’eccentricità di Dio, senza allontanarsi dal tempo e dalla sua condizione reale.
La sua figura e quella dei pastori c’interpellano, chiedono il coraggio di una risposta - ma dopo aver lasciato fluire lo stesso genere di Presenze interiori: visitatrici degne, cui è concesso esprimersi.
Anche Lei ha dovuto come noi passare dalle credenze dei padri alla Fede nel Padre.
Dall’idea dell’amore come premio a quella del ‘dono’.
Dalla pratica dei culti e delle chiusure che non rendono affatto intimi all’Eterno, all’apertura della mente e degli usci.
Non lo ha realizzato senza fatica, bensì sopportando le resistenze del suo ambiente arido.
Gesù è stato infatti circonciso - inutile rito che secondo l’abitudine pretendeva mutare il Figlio di Dio in figlio di Abramo.
La Buona Novella proclama un capovolgimento: ciò che la religione aveva considerato lontano dall’Altissimo... è vicinissimo a Lui; anzi, gli corrisponde appieno.
Mai accaduto prima, immaginarselo.
Nelle Annunciazioni dei Vangeli è spalancata l’avventura della Fede.
E il nuovo Bimbo ha un Nome ch’esprime l’inaudita essenza di Salvatore, non giustiziere.
Tutta la sua vicenda sarà appunto pienamente istruttiva anche sotto il profilo di come interiorizzare incertezze e disagi: questi “momenti no” e le precarietà che c’insegnano a vivere.
Infatti, anche noi come Maria «andiamo riconoscendo» la presenza di Dio negli enigmi della Scrittura, nel Piccolo ‘avvolto in bende’ - persino nell’eco ancestrale dei nostri mondi interni.
E ci lasciamo andare - non sappiamo bene dove. Ma così è l’Infinito, l’immenso Segreto, l’inesplicabile Respiro, nelle sue pieghe.
Il saggio Sogno che abita l’umano sa di humus antico, ma il suo eco rinasce ogni giorno, nella marea dell’essere che orienta a ‘guardare’ davvero, senza veli.
Un contegno conformista di “vedere le cose” non risolverebbe il problema.
Talora, per non farsi condizionare bisogna riedificarsi nel silenzio, come la Vergine; costruirsi una sorta di isola ermeneutica che schiuda porte differenti, che introduca altre luci.
Entro il suo circuito sacro anche la Madre di Dio valorizzava le innate energie trasformative, proprio radicandole sugli interrogativi…
Così tornando al suo essere primordiale e al senso del Neonato - immagine intrisa di senso primigenio e onda vitale, cara a molte culture.
Maria entrava in un Altrove e non usciva dal campo del reale.
Era ‘dentro’ il suo Centro, senza fretta - ricercando il Sole annegato nel suo essere e che tornava, emergeva, risorgeva; dall’intimo, la faceva esistere oltre.
Così non si lasciava assorbire energie dalle idee conformiste altrui o da situazioni [esterne] che pure volevano rompere l’equilibrio.
Nella sua vereconda solitudine - colma di Grazia - quell’io superiore e celato nell’essenza veniva sempre più a Lei. Si faceva nuova Alba e guida.
Non voleva vivere dentro pensieri, saperi e ragionamenti dintorno - nessuno capace di amplificare la vita - tutti in mano alle droghe delle procedure, disumanizzanti l’Incanto.
La magia felice di quel Frugolo di carne portava la sua Pace.
I Sogni sostenevano e veicolavano il suo nido e intimo fulcro - facendo scorrere una vita nuova dal nucleo della sua Persona, e la giovinezza del mondo.
«Ora Maria conservava tutte Parole-evento confrontandole nel suo cuore»
Il posto per noi
(Lc 2,16-21)
Nelle gabbie della nostra devozione, forse non c’è ancora posto per Gesù che si offre. Egli continua a nascere bambino come gli altri, lontano e povero, rifiutato.
Solo i marginali della società sembrano capaci di attesa, apertura al mistero, e ricerca: vegliare di notte (v.8), passare e vedere (v.15), venire affrettandosi (v.16), lodare (v.20).
La Madre sta facendo già il suo cammino per passare dalla religiosità dei padri alla Fede nel Padre: Contemplativa che ascolta, incontra i suoi stati profondi e cerca di non perdere nulla.
Chi non è nessuno ma sente ansia di ricerca e cuore orante può cantare un canto nuovo.
In tal guisa, sarà in grado di decifrare i segni della Presenza divina iscritti nelle vicende, e accogliere Cristo nella propria dimora interna (v.7) [cf. commento al Prologo di Gv].
Nella semplicità del Figlio - nella Libertà dei figli - il Dio Eterno indica alle moltitudini misere e abbandonate una Via nuova, in grado di valorizzare i limiti e perfino le eccentricità di ciascuno.
Lungo tutto il primo secolo, sia in Palestina che in Asia Minore [chiese giovannee e lucane] le diverse scuole teologiche e di servitori di Dio - del giudaismo tradizionale, di Gesù, del Battista - si confrontavano in modo alternativo.
Dove c’erano comunità di giudei, non mancavano polemiche tra cristiani e vari osservanti (più o meno radicali) della religione dei padri - nonché persone che erano state battezzate da Giovanni, o almeno a contatto con i suoi allievi. Anche il Maestro e i primi apostoli lo erano stati.
Più che confusione, tra il gruppo dei discepoli di Cristo e quelli del Battezzatore, si notavano vere e proprie competizioni.
Ciò, sebbene entrambe proclamassero la venuta del Regno di Dio, e proponessero giustizia sociale, nonché il perdono dei peccati nella vita pratica - invece che mediante riti e gesti sacrificali al Tempio di Gerusalemme.
Eppure, grazie al Figlio, gli apostoli coglievano la profondità del cuore del Padre, che mai somiglia a un giustizialista, bensì opera esclusivamente per il bene e la promozione della vita.
Quindi nella Fede essi stessi ottenevano recuperi inspiegabili - proprio integrando gratuitamente i lati deboli delle persone - senza opere di mortificazione della donna e dell’uomo insicuri, né pretendere perfezioni preventive impossibili.
Ancora oggi, proprio a partire dai versanti oscuri della nostra personalità, il Padre crea nello Spirito delle Beatitudini la ‘sua’ Novità, che ribalta le carte in tavola.
Mutamento del tutto inatteso, impossibile da immaginare e proporsi; almeno sulla base di pregiudizi o idee già consolidate - tutte concorrenziali con la stima di sé e la gioia di vivere.
Il Dio dall’amore senza condizioni e che scaccia i sensi di colpa era appunto appannaggio esclusivo delle nuove persone di Fede in Cristo, le quali avevano superato le cappe accusatorie, moralistiche e pignole, della consuetudine affermata.
Anche allora le diversità mettevano in gioco la questione delle purificazioni richieste dai “credo” accettati dal paradigma culturale, e dai riti identitari.
Gesù sembrava del tutto estraneo alla mentalità delle abluzioni cultuali della tradizione.
Era la consuetudine di vita con Lui che rigenerava anime a tutto tondo, anche a partire dalle eccentricità di ciascuno.
Unicità preziose, interpretate come segno di eccezionalità vocazionali.
Insegnava ai miseri e ai condannati dalla religione a rimettersi in piedi facendo leva sulla possibilità d’incontrare i diversi volti annidati nell’anima di ciascuno: assumerli e investirli invece che rinnegarli.
Personalità tutte... non sterilizzate in via preventiva; anime anche dalle espressioni stravaganti, o dai lati inconsapevoli, malfermi, inespressi - nei quali Gesù insegnava a scoprire i tratti della Chiamata missionaria personale.
E proprio ‘da’ qui - sembra incredibile - anche noi inviati all’Annuncio.
Tutto ciò resta fondamentale ogni giorno.
Infatti, le proposte [pie o d’avanguardia] possono presentarsi in forme pur dignitosissime - ma esse restano solo battistrada del nuovo salto di qualità.
Quest’ultimo, capace di stupore e tutto umanizzante: senza la tara di sentirsi segnati a vita dalle opinioni esterne.
Ovviamente, queste forme di scioltezza e immediatezza famigliare nei confronti del Dio Eterno suscitavano l’invidia dei veterani ancora ingabbiati nei vecchi timori della retribuzione, nel mucchio delle opere di legge, di efficienze personali inconsapevoli della Grazia aperta, del Dono personale.
In nessun adempimento, bensì solo in Cristo, i suoi amici e fratelli riconoscevano la Voce del Dio amabile.
Egli non distingue a priori le “superiorità”: fra puri e impuri, capaci e incapaci, amici e nemici; reduci, eletti, predestinati, e non.
Insomma, nella nostra vita reale non attendiamo un Messia fenomeno che turbi e opprima di continuo, riempiendoci di paure e deviazioni da correggere [che fiaccano tutte le energie].
Badiamo solo a un Amico che consenta di esprimersi in modo inedito e avere una speranza lunga - anche immeritata.
Facciamo come i pastori: nessuno ha mai capito cosa li abbia convinti, se non lo stupore della gratuità imprevedibile (vv.15-18.20).
Paradossalmente pronti a fondare un nuovo popolo - senza troppi regolamenti e luoghi comuni - a partire da come e dove ciascuno si trovasse.
Ormai anche a noi non serve più l’imprimatur dei settarismi ideologici, senza apertura alla sorpresa dell’Incarnazione sorprendente, che fa trasalire di gioia gli ‘inadeguati’..
Le nostre più infantili stranezze [cf. commento al Prologo di Gv] possono avvicinare la condizione umana a quella divina.
Quindi hanno l’approvazione del Signore di tutti i cosmi.
Il riscatto dalla Legge dei figli incerti.
E Maria: la Domanda ch’è la Risposta
(Gal 4,4-7; Lc 2,16-21)
Ci chiediamo: in questo tempo, cosa può renderci intimi al Signore?
[Un certo Cristoforo cambiò la storia, veleggiando al contrario…].
I pastori sperimentano la predilezione d’un vero e proprio Amore eccessivo, per benedizione dell’eccentrico - e Meraviglia.
Preferenza che non viene concessa dietro scambio coi meriti, ma a motivo dei bisogni.
Lc vuol sottolineare che - lodando e glorificando Dio (v.20) proprio come fanno gli Angeli - gl’imperfetti e inadempienti si ritrovano paradossalmente più vicini al trono divino rispetto alla posizione sempre arrembante dei piissimi sterilizzati, o dei più “performanti”.
Sbalordiamo anche noi di conoscere un Padre che invece di incenerirci a motivo delle nostre oscillazioni, non solo avvolge di ‘luce’ (v.9), ma proprio su quelle stesse insicurezze costruisce la sua Novità.
Pensavamo tutti di essere nati per fare i figli devoti e obbedienti, o i grandi “fenomeni” [narcisi].
Invece di metterci sotto stress, il Padre vuole che ritroviamo il piacere e lo stupore della gratuità e dello stare insieme. Senza prima i modelli - e badare a obblighi, modi, orari, luoghi, doveri, riverenze, prostrazioni e baciamani di nessun genere!
Dio sa che siamo circondati da ambiti, stimoli, spostamenti, faccende, che ci portano via. Ma neanche pretende un minimo sindacale tutto suo, perché non fa come il ragazzino capriccioso che vuole la fetta grande di torta a merenda [corrispondente al suo rango].
La relazione con Lui non è un impegno continuo, cui star dietro con fatica. È un alleggerimento, e addirittura si fortifica nei contrappesi.
In Avvento abbiamo già sottolineato: quello del Signore che Viene è un Raggio che non s’introduce nell’orizzonte delle aspettative normali, adattandosi ai nostri sogni esterni - quelli che vivono di traguardi attesi, e poi diventano un tormento.
Nell’arco della vita l’incontro con tale Luce sapiente che squarcia le tenebre della notte è nelle difficoltà che costringono a spostare lo sguardo, nell’insuccesso che obbliga a rigenerare la creatività, nello smarrimento che ci fa contattare nuovi modi di essere.
La vita di Fede non sopporta il demone della ‘perfezione’ immaginata dalle religioni arcaiche.
Esse volentieri sostituiscono ogni Gratis con il senso del dovere adultoide - che inevitabilmente partorisce strategie snervanti e addirittura compensatorie [grazie a Dio, oggi sempre meno occulte].
Secondo il pensiero cinese, per acquistare smalto e fuggire un servilismo inquinato e logoro, i Santi «si fanno insegnare dalle bestie l’arte di evitare gli effetti nocivi della domesticazione, che la vita in società impone».
Infatti: «Gli animali domestici muoiono prematuramente. E così gli uomini, cui le convenzioni sociali vietano di obbedire spontaneamente al ritmo della vita universale».
«Queste convenzioni impongono un’attività continua, interessata, estenuante [mentre è opportuno] alternare i periodi di vita rallentata e di tripudio».
«Il Santo non si sottomette al ritiro o al digiuno se non al fine di giungere, grazie all’estasi, a evadere per lunghi viaggi. Questa liberazione è preparata da giochi vivificanti, che la natura insegna».
«Ci si allena alla vita paradisiaca imitando i sollazzi degli animali. Per santificarsi, bisogna prima abbrutirsi – si intenda: imparare dai bambini, dalle bestie, dalle piante, l’arte semplice e gioiosa di non vivere che in vista della vita».
[M. Granet, Il Pensiero Cinese, Adelphi 2019, kindle pp. 6904-6909].
I ‘pastori’ pongono immediatamente sullo sfondo della propria esistenza reale sia i sensi di colpa che il tempo obbligato degli adempimenti, conservando carica ed entusiasmo.
In tal guisa, anche per noi nulla della vita sembra più un muro invalicabile - a parte il pregiudizio dei ‘giusti’ [quelli dei “condizionali”: i “se”, i “ma”, i “però”].
Anche la routine non toglie energie e voglia di fare - come mai? Perché le anime spontanee non hanno bisogno di occuparsi del look esterno, di piacere all’opinione altrui; così via.
Senza neppure rendersi conto, non avendo da tenere in piedi paraventi artificiosi, i genuini possono affrontare la vita guardandola in faccia, e partire col piede giusto.
Così, attirare grandi opportunità di cambiamento.
Forse non vanno troppo in profondità, ma ascoltano i bisogni.
E allargano i loro spazi senza chiedere l’autorizzazione a coloro che mai la concederanno; intuiscono l’essenziale che sgorga dalla libertà di mente e di codice.
Il loro “dover essere” non ha aspettative artefatte: è semplice sintonia con la natura e con se stessi.
Posizione risolutiva, perché su tale raggio riescono a guardare il lato debole come un contenitore di grande forza, che attiva capacità in grado di costruire tutto un altro destino.
Non si pongono il problema di dover sembrare all’altezza, o di non essere quel che sono. Poi di non potersi concedere tempo in abbondanza, e di farsi vedere ordinati e buonisti, senza malesseri; in armonia con tutti.
Seguono la loro storia, e senza troppe aspettative o propositi, imparano ad affidarsi al flusso degli eventi, anche intimi.
Sanno accogliere quali ospiti degni tutti i propri stati interiori, senza sentirsi in colpa.
Nei propri moventi, sono ‘chiari’. Quindi non cadono nelle nevrosi.
L’incontro con l’Autenticità serena li ha riqualificati.
Luce che ha espugnato l’autostima.
Si sentono legittimati, invece che bersagli. E la riconquistata fiducia li renderà aperti e accoglienti verso gli altri.
Hanno capito di doversi affidare a un sapere più profondo di quello inoculato dai pregiudizi dei capi decisionisti.
Dio è l’esatto contrario del catechismo dei veterani: è solo l’Incontro con Lui che purifica - non il viceversa apparente.
Anche noi desideriamo aprirci al nuovo Mistero. Esperienza che in questo tempo ci sta preparando il grembo dell’anima.
Siamo in una transumanza piena di scoperte e avventure: possiamo apprendere come stare con ciò che Viene e reinterpretarlo, imparando a camminare sulle nostre gambe e mettendo in campo le attitudini.
Accanto ai pastori, che incessantemente rimettono in circolo le energie - la nostra vita può rivelarsi assai più ricca della vicenda dei precisi e inappuntabili.
Vogliamo trasformare la routine in un’avventura che scorge il Sacro autentico nel piccolo Seme che ci abita.
Lo faremo senza troppe efficienze: forse anche noi costruiremo un rifugio d’altura rigenerante, per allenare l’intuizione - e da lì ricreare la Visione, e il mondo.
Nessuno quest’anno deve sentirsi inadeguato, escluso dall’azione dell’Amore di Dio e dalla capacità d’irradiarlo.
Come nel Vangelo della mattina di Pasqua, possiamo scrutare nel buio e intuire anche fra segni di morte le grandi energie della Vita.
Il mondo delle ombre non è più nel medesimo assetto di prima.
Fra gli umiliati, anche Maria è stupita, ma cerca di capire e fa il suo percorso. Anzi, comprende che la Risposta è già nella Domanda.
Confrontando dentro sé Parola e vicende attorno al Figlio, intuisce che nel “problema” (che la sorprendeva) c’era già l’energia della ‘soluzione’.
Chi è Gesù?
Il contrasto fra la straordinaria figura del Messia atteso e frainteso, e l’ottusità del giudizio elusivo delle dottrine popolari, finiva per lasciare le cose come stavano.
Anzi, peggio: racchiudeva il Mistero - quello più normale del mondo [ma che rimane per sempre]: l'umanità di Dio.
E smarriva il suo ‘dove’.
Non poteva comprendere la Persona del Cristo a partire dalle cose che conosceva o cercando d’inquadrarlo nei criteri famigliari del Primo Testamento; nel sentire comune, coi modelli magici del tempo.
Il Maestro suo allievo non si poteva accontentare d’un miglioramento della situazione.
Doveva sostituirla, annunciando la Verità del Padre; della donna e dell’uomo autentici.
Proponendo un germe di mondo alternativo alla società spietata e piramidale; quella che istituisce cosa pensare e dire, come bisogna essere e comportarsi.
Dio intende far emergere e valorizzare l’intuizione delle coscienze più che imporre doveri o smanie di analizzare i comportamenti.
Questo l’incredibile.
Ogni gruppo religioso chiudeva il Messia nel suo modello interpretativo, consono a un ambiente venato di speranze antiche: difesa dei beni e delle consuetudini, benessere a scapito altrui, espansione, prodigi.
La rivoluzione dei figli pone una tematica che cerca la sua Via Altrove - in fondo dietro l’angolo, ma non relegata “dentro” un angolo.
Perché interrogarsi sulla Persona del Cristo significa già iniziare a superare le piccine interpretazioni abitudinarie, e abbracciare l’irruzione di Dio.
Il Signore sempre fanciullo rovescerà le sorti, il destino del regno dell’uomo, e le sue rivendicazioni che ingabbiano l'anima, immobilizzando la vita.
La conoscenza della sua vicenda, l’adesione alla sua Persona, e l’Azione dello Spirito, non lasceranno perdurare nella mente di Maria i pensieri fissi, gli attaccamenti, i luoghi comuni, le vetrine che poi impregnano tutta l’anima privandola di ebbrezza e fecondità.
È nel Figlio ch’ella diviene Madre, Presenza del tutto personale, nuovo Fiuto.
Maternità la sua, d’innata Sapienza, che apre gli orizzonti: nella Chiesa autentica ci sta conducendo a differenti Sogni dell’essere.
Donna che vuole esprimersi umanizzando.
Familiarity at the human level makes it difficult to go beyond this in order to be open to the divine dimension. That this son of a carpenter was the Son of God was hard for them to believe. Jesus actually takes as an example the experience of the prophets of Israel, who in their own homeland were an object of contempt, and identifies himself with them (Pope Benedict)
La familiarità sul piano umano rende difficile andare al di là e aprirsi alla dimensione divina. Che questo Figlio di un falegname sia Figlio di Dio è difficile crederlo per loro. Gesù stesso porta come esempio l’esperienza dei profeti d’Israele, che proprio nella loro patria erano stati oggetto di disprezzo, e si identifica con essi (Papa Benedetto)
These two episodes — a healing and a resurrection — share one core: faith. The message is clear, and it can be summed up in one question: do we believe that Jesus can heal us and can raise us from the dead? The entire Gospel is written in the light of this faith: Jesus is risen, He has conquered death, and by his victory we too will rise again. This faith, which for the first Christians was sure, can tarnish and become uncertain… (Pope Francis)
These two episodes — a healing and a resurrection — share one core: faith. The message is clear, and it can be summed up in one question: do we believe that Jesus can heal us and can raise us from the dead? The entire Gospel is written in the light of this faith: Jesus is risen, He has conquered death, and by his victory we too will rise again. This faith, which for the first Christians was sure, can tarnish and become uncertain… (Pope Francis)
The ability to be amazed at things around us promotes religious experience and makes the encounter with the Lord more fruitful. On the contrary, the inability to marvel makes us indifferent and widens the gap between the journey of faith and daily life (Pope Francis)
La capacità di stupirsi delle cose che ci circondano favorisce l’esperienza religiosa e rende fecondo l’incontro con il Signore. Al contrario, l’incapacità di stupirci rende indifferenti e allarga le distanze tra il cammino di fede e la vita di ogni giorno (Papa Francesco)
An ancient hermit says: “The Beatitudes are gifts of God and we must say a great ‘thank you’ to him for them and for the rewards that derive from them, namely the Kingdom of God in the century to come and consolation here; the fullness of every good and mercy on God’s part … once we have become images of Christ on earth” (Peter of Damascus) [Pope Benedict]
Afferma un antico eremita: «Le Beatitudini sono doni di Dio, e dobbiamo rendergli grandi grazie per esse e per le ricompense che ne derivano, cioè il Regno dei Cieli nel secolo futuro, la consolazione qui, la pienezza di ogni bene e misericordia da parte di Dio … una volta che si sia divenuti immagine del Cristo sulla terra» (Pietro di Damasco) [Papa Benedetto]
And quite often we too, beaten by the trials of life, have cried out to the Lord: “Why do you remain silent and do nothing for me?”. Especially when it seems we are sinking, because love or the project in which we had laid great hopes disappears (Pope Francis)
E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce (Papa Francesco)
The Kingdom of God grows here on earth, in the history of humanity, by virtue of an initial sowing, that is, of a foundation, which comes from God, and of a mysterious work of God himself (John Paul II)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.