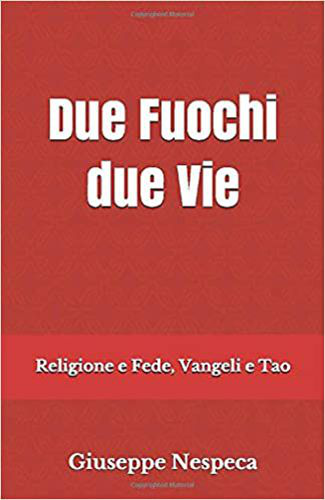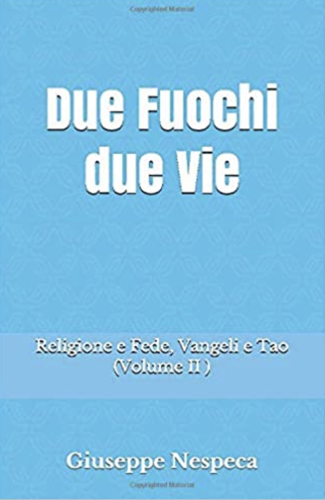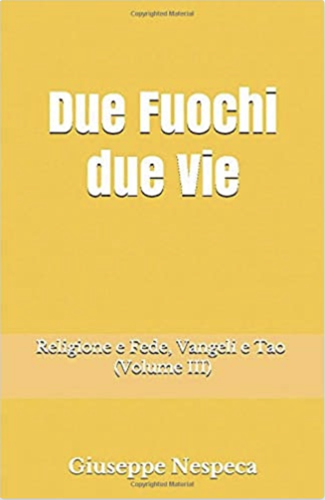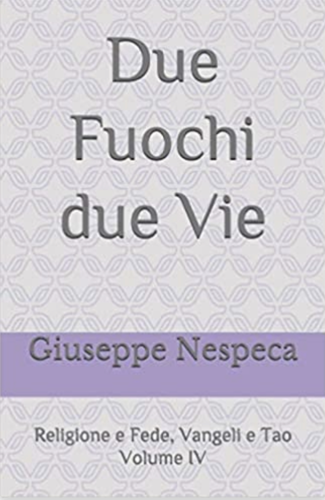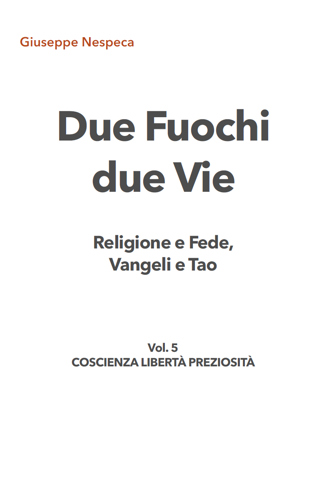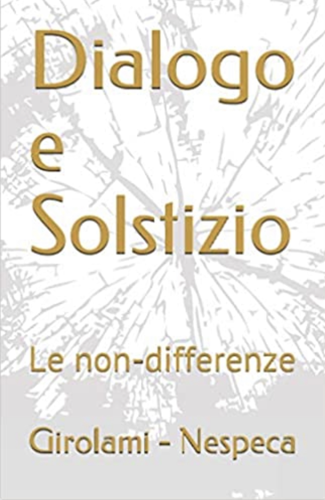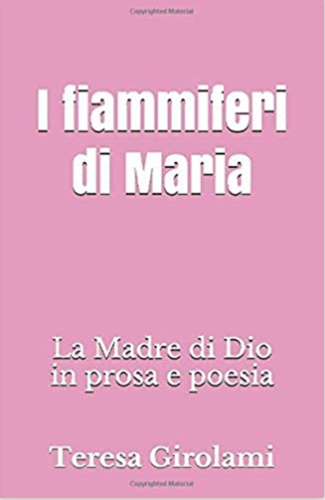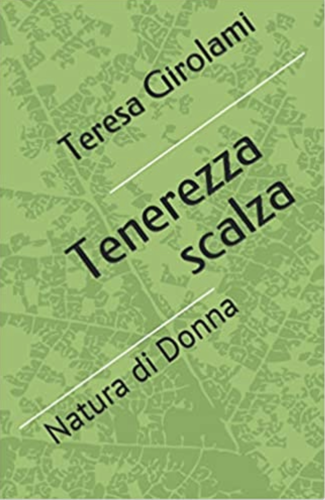(Mt 18,21-19,1)
In tutto il medio Oriente antico la rappresaglia non sproporzionata uno a uno [non crudele] era legge sacra.
Perdonare era un atteggiamento umiliante e assurdo, principio incomprensibile per chiunque vivesse una qualsiasi ingiustizia.
Viceversa, nella dinamica della Fede, perdonare diventa un potere, che non solo rende l’aria respirabile, ma attiva il nostro destino personale.
Pietro invece vuole sapere i limiti del perdono (v.21).
Storicamente, al termine del primo secolo si riaffaccia nei credenti lo stile schizzinoso, severo, della sinagoga e dell’Impero [«divide et impera»].
Nasce la domanda: bisognerà fermarsi nell’accogliere?
In aggiunta, nelle stesse chiese si ricomincia a pensare che qualcuno abbia peccato di lesa maestà verso chi - ormai duro e senza cuore - è abituato a farsi riverire.
Veterani che ne combinano più di altri e poi fanno i puntigliosi su minuzie altrui (i fratelli deboli, considerati sottoposti e destinati al rigore fiscale dei moralismi, nonché delle penitenze).
Mentre la pratica religiosa esaspera i difetti minuti, l’esperienza stessa della sproporzione tra il perdono ricevuto dal Padre e quello che siamo in grado di offrire ai fratelli, fa capire la necessità della tolleranza.
La Chiesa dovrebbe essere questo spazio dell’esperienza di Dio che restituisce vita, luogo alternativo di fraternità.
La società imperiale era dura e senza compassione, priva di spazio per i piccoli e malfermi, i quali senza troppe pretese cercavano un qualsiasi rifugio per il cuore - ma nessuna Religione dava loro risposta.
Anche le sinagoghe identificavano benedizioni materiali e spirituali. Ammantate di esigenze, norme di purità e adempimenti, non offrivano il tepore d’un luogo accogliente per i deboli.
Il guaio era che nelle stesse prime comunità cristiane alcuni puntavano i piedi sul rigore delle norme, consuetudini e gerarchie, pretendendo convivenze improntate secondo il modello giudaizzante.
Inoltre, come testimonia la lettera di Giacomo, verso la fine del primo secolo già iniziavano a manifestarsi nelle chiese di Cristo le identiche divisioni della società, tra indigenti e benestanti!
Lo spazio di accoglienza delle comunità che nello Spirito avevano avuto il compito dal Signore d’illuminare il mondo con il loro germe di vita quali ‘case di tutti’ e di relazioni alternative, correva il rischio di ridiventare luogo di conflitti, giudizio, castigo, condanna.
«Così anche il Padre mio celeste farà a voi, se non condonerete ciascuno al proprio fratello dal vostro cuore» (v.35).
Il Perdono divino diventa efficace e palese solo nella testimonianza della Chiesa dove sorelle e fratelli - invece che mostrarsi pignoli, si colgono sospinti e si lasciano guidare da una Visione di nuovi cieli e nuova terra.
Per questo - senza sforzo alcuno, anzi benedicendo le necessità altrui come territori di energie preparatorie - essi vivono la comunione delle risorse e condonano i debiti anche materiali, che poi sono una miseria.
In caso contrario, dovremmo sempre vivere nell’incombenza di un Dio indulgente forse, ma a tempo, che ritratta il fare misericordia.
Sarebbe una vita senza sviluppi da stupore, tutta appesantita nella palude dei pochi spiccioli.
È invece l’energia attiva della Fede quella che non ci condanna ad arrancare.
La magnanimità che esce dagli automatismi sposta il nostro sguardo e ci porta un’Onda ineffabile e crescente, molto più avanti di quanto possiamo immaginare.
I nostri cedimenti stanno preparando nuovi sviluppi - quelli che contano, senza limitazioni.
L’alternativa “vittoria-o-sconfitta” è falsa: bisogna uscirne.
[Giovedì 19.a sett. T.O. 14 agosto 2025]