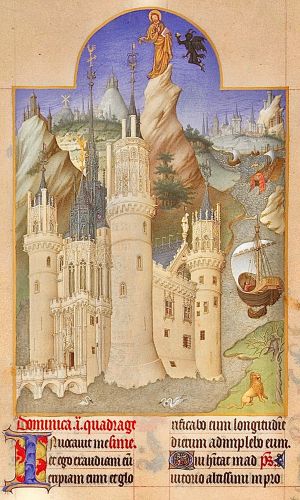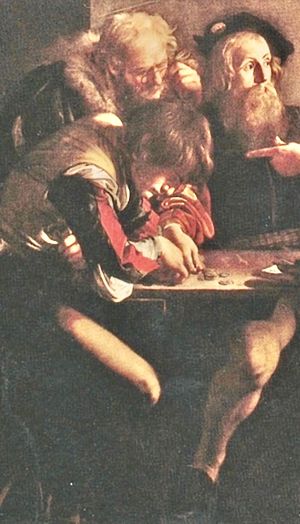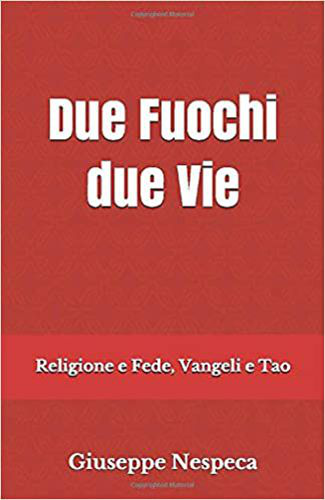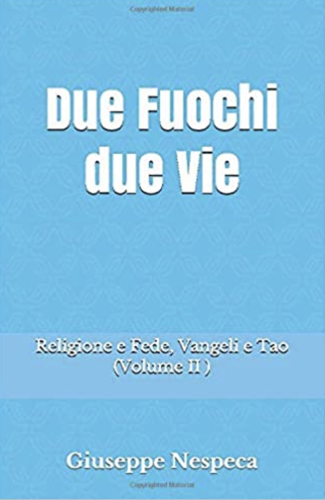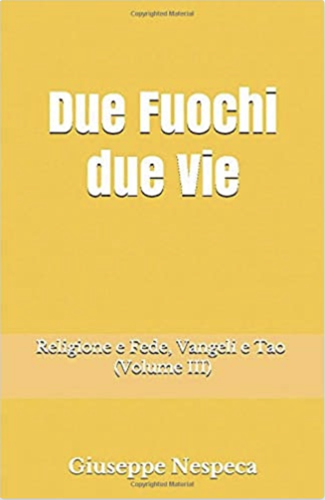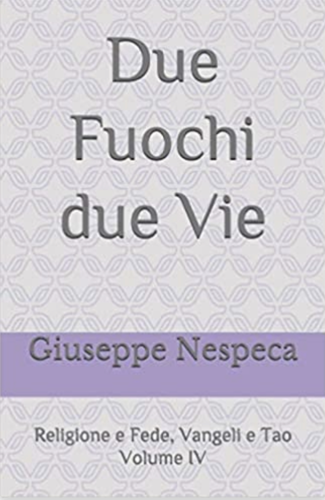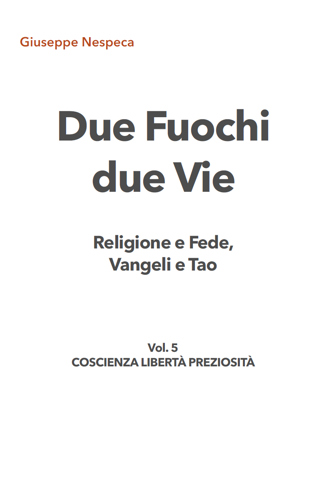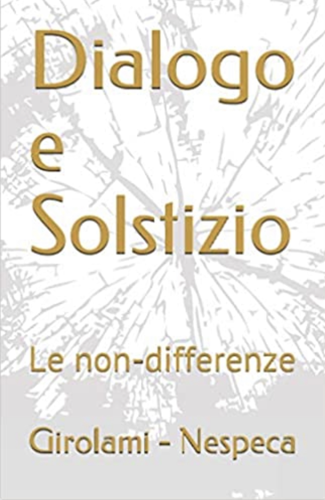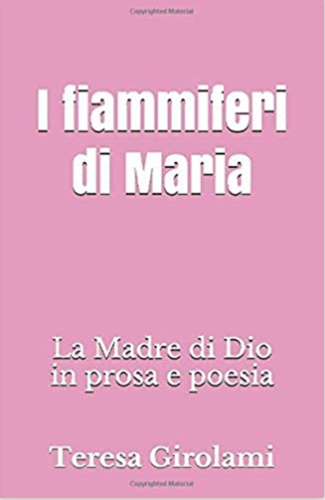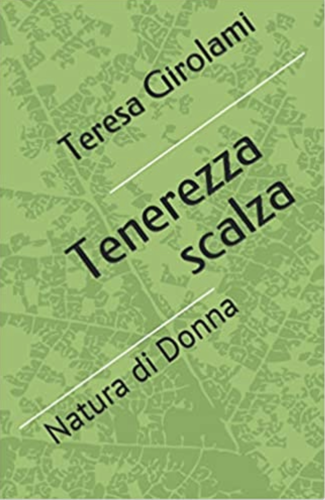don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Ha segnato la cultura cristiana
Il Vangelo odierno insiste proprio sulla regalità universale di Cristo giudice, con la stupenda parabola del giudizio finale, che san Matteo ha collocato immediatamente prima del racconto della Passione (25,31-46). Le immagini sono semplici, il linguaggio è popolare, ma il messaggio è estremamente importante: è la verità sul nostro destino ultimo e sul criterio con cui saremo valutati. "Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto" (Mt 25,35) e così via. Chi non conosce questa pagina? Fa parte della nostra civiltà. Ha segnato la storia dei popoli di cultura cristiana: la gerarchia di valori, le istituzioni, le molteplici opere benefiche e sociali. In effetti, il regno di Cristo non è di questo mondo, ma porta a compimento tutto il bene che, grazie a Dio, esiste nell’uomo e nella storia. Se mettiamo in pratica l’amore per il nostro prossimo, secondo il messaggio evangelico, allora facciamo spazio alla signoria di Dio, e il suo regno si realizza in mezzo a noi. Se invece ciascuno pensa solo ai propri interessi, il mondo non può che andare in rovina.
Cari amici, il regno di Dio non è una questione di onori e di apparenze, ma, come scrive san Paolo, è "giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo" (Rm 14,17). Al Signore sta a cuore il nostro bene, cioè che ogni uomo abbia la vita, e che specialmente i suoi figli più "piccoli" possano accedere al banchetto che lui ha preparato per tutti. Perciò, non sa che farsene di quelle forme ipocrite di chi dice "Signore, Signore" e poi trascura i suoi comandamenti (cfr Mt 7,21). Nel suo regno eterno, Dio accoglie quanti si sforzano giorno per giorno di mettere in pratica la sua parola. Per questo la Vergine Maria, la più umile di tutte le creature, è la più grande ai suoi occhi e siede Regina alla destra di Cristo Re. Alla sua celeste intercessione vogliamo affidarci ancora una volta con fiducia filiale, per poter realizzare la nostra missione cristiana nel mondo.
[Papa Benedetto, Angelus 23 novembre 2008]
L’idea del Cielo in rapporto al Mistero pasquale del Cristo
Il “cielo” come pienezza di intimità con Dio
Lettura: 1 Gv 3, 2-3
1. Quando sarà passata la figura di questo mondo, coloro che hanno accolto Dio nella loro vita e si sono sinceramente aperti al suo amore almeno al momento della morte, potranno godere di quella pienezza di comunione con Dio, che costituisce il traguardo dell’esistenza umana.
Come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica, “questa vita perfetta, questa comunione di vita e di amore con la Santissima Trinità, con la Vergine Maria, gli angeli e tutti i beati è chiamata 'il cielo'. Il cielo è il fine ultimo dell’uomo e la realizzazione delle sue aspirazioni più profonde, lo stato di felicità suprema e definitiva” (n. 1024).
Vogliamo oggi cercare di cogliere il senso biblico del “cielo”, per poter comprendere meglio la realtà cui questa espressione rimanda.
2. Nel linguaggio biblico il “cielo” quando è unito alla “terra”, indica una parte dell’universo. A proposito della creazione, la Scrittura dice: “In principio Dio creò il cielo e la terra” (Gn 1, 1).
Sul piano metaforico il cielo è inteso come abitazione di Dio, che in questo si distingue dagli uomini (cfr Sal 104, 2s.; 115,16; Is 66, 1). Egli dall’alto dei cieli vede e giudica (cfr Sal 113, 4-9), e discende quando lo si invoca (cfr Sal 18,7.10; 144,5). Tuttavia la metafora biblica fa bene intendere che Dio né si identifica con il cielo né può essere racchiuso nel cielo (cfr 1 Re 8, 27); e ciò è vero, nonostante che in alcuni passi del primo libro dei Maccabei “il Cielo” sia semplicemente un nome di Dio (1 Mac 3, 18.19.50.60; 4, 24.55).
Alla raffigurazione del cielo, quale dimora trascendente del Dio vivo, si aggiunge quella di luogo a cui anche i credenti possono per grazia ascendere, come nell'Antico Testamento emerge dalle vicenda di Enoc (cfr Gn 5, 24) e di Elia (cfr 2 Re 2, 11). Il cielo diventa così figura della vita in Dio. In questo senso, Gesù parla di “ricompensa nei cieli” (Mt 5, 12) ed esorta ad “accumulare tesori nel cielo” (ivi 6, 20; cfr 19, 21).
3. Il Nuovo Testamento approfondisce l'idea del cielo anche in rapporto al mistero di Cristo. Per indicare che il sacrificio del Redentore assume valore perfetto e definitivo, la Lettera agli Ebrei afferma che Gesù “ha attraversato i cieli” (Eb 4, 14) e “non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso” (Ivi 9, 24). I credenti, poi, in quanto amati in modo speciale da parte del Padre, vengono risuscitati con Cristo e sono resi cittadini del cielo. Vale la pena di ascoltare quanto in proposito l’apostolo Paolo ci comunica in un testo di grande intensità: “Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù” (Ef 2, 4-7). La paternità di Dio, ricco di misericordia, viene sperimentata dalle creature attraverso l’amore del Figlio di Dio crocifisso e risorto, il quale come Signore siede nei cieli alla destra del Padre.
4. La partecipazione alla completa intimità con il Padre, dopo il percorso della nostra vita terrena, passa dunque attraverso l’inserimento nel mistero pasquale del Cristo. San Paolo sottolinea con vivida immagine spaziale questo nostro andare verso Cristo nei cieli alla fine dei tempi: “Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro [i morti risuscitati] tra le nubi, per andare incontro al Signore nell’aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole” (1 Ts 4, 17-18).
Nel quadro della Rivelazione sappiamo che il “cielo” o la “beatitudine” nella quale ci troveremo non è un’astrazione, neppure un luogo fisico tra le nubi, ma un rapporto vivo e personale con la Trinità Santa. È l’incontro con il Padre che si realizza in Cristo Risorto grazie alla comunione dello Spirito Santo.
Occorre mantenere sempre una certa sobrietà nel descrivere queste ‘realtà ultime’, giacché la loro rappresentazione rimane sempre inadeguata. Oggi il linguaggio personalistico riesce a dire meno impropriamente la situazione di felicità e di pace in cui ci stabilirà la comunione definitiva con Dio.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica sintetizza l’insegnamento ecclesiale circa questa verità affermando che “con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha ‘aperto’ il cielo. La vita dei beati consiste nel pieno possesso dei frutti della Redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui” (n. 1026).
5. Questa situazione finale può essere tuttavia anticipata in qualche modo oggi, sia nella vita sacramentale, di cui l’Eucaristia è il centro, sia nel dono di sé mediante la carità fraterna. Se sapremo godere ordinatamente dei beni che il Signore ci elargisce ogni giorno, sperimenteremo già quella gioia e quella pace di cui un giorno godremo pienamente. Sappiamo che in questa fase terrena tutto è sotto il segno del limite, tuttavia il pensiero delle realtà ‘ultime’ ci aiuta a vivere bene le realtà ‘penultime’. Siamo consapevoli che mentre camminiamo in questo mondo siamo chiamati a cercare “le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio” (Col 3, 1), per essere con lui nel compimento escatologico, quando nello Spirito egli riconcilierà totalmente con il Padre “le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli” (Col 1, 20).
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 21 luglio 1999]
Il paradosso cristiano, che viene a noi ogni giorno
Ma il paradosso cristiano è che il Giudice non riveste una regalità temibile, ma è un pastore pieno di mitezza e di misericordia.
Gesù, infatti, in questa parabola del giudizio finale, si serve dell’immagine del pastore. Prende le immagini dal profeta Ezechiele, che aveva parlato dell’intervento di Dio in favore del popolo, contro i cattivi pastori d’Israele (cfr 34,1-10). Questi erano stati crudeli, sfruttatori, preferendo pascere sé stessi piuttosto che il gregge; pertanto Dio stesso promette di prendersi cura personalmente del suo gregge, difendendolo dalle ingiustizie e dai soprusi. Questa promessa di Dio per il suo popolo si è realizzata pienamente in Gesù Cristo, il Pastore: proprio Lui è il Buon Pastore. Anche Lui stesso dice di sé: «Io sono il buon pastore» (Gv 10,11.14).
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi. E indica così il criterio del giudizio: esso sarà preso in base all’amore concreto dato o negato a queste persone, perché Lui stesso, il giudice, è presente in ciascuna di esse. Lui è giudice, Lui è Dio-uomo, ma Lui è anche il povero, Lui è nascosto, è presente nella persona dei poveri che Lui menziona proprio lì. Dice Gesù: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto (o non avete fatto) a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete (o non l’avete) fatto a me» (vv. 40.45). Saremo giudicati sull’amore. Il giudizio sarà sull’amore. Non sul sentimento, no: saremo giudicati sulle opere, sulla compassione che si fa vicinanza e aiuto premuroso.
Io mi avvicino a Gesù presente nella persona dei malati, dei poveri, dei sofferenti, dei carcerati, di coloro che hanno fame e sete di giustizia? Mi avvicino a Gesù presente lì? Questa è la domanda di oggi.
Dunque, il Signore, alla fine del mondo, passerà in rassegna il suo gregge, e lo farà non solo dalla parte del pastore, ma anche dalla parte delle pecore, con le quali Lui si è identificato. E ci chiederà: “Sei stato un po’ pastore come me?”. “Sei stato pastore di me che ero presente in questa gente che era nel bisogno, o sei stato indifferente?”. Fratelli e sorelle, guardiamoci dalla logica dell’indifferenza, di quello che ci viene in mente subito: guardare da un’altra parte quando vediamo un problema. Ricordiamo la parabola del Buon Samaritano. Quel povero uomo, ferito dai briganti, buttato per terra, fra la vita e la morte, era lì solo. Passò un sacerdote, vide, e se ne andò, guardò da un’altra parte. Passò un levita, vide e guardò da un’altra parte. Io, davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente come questo sacerdote, come questo levita, e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su come mi sono avvicinato, di come ho guardato Gesù presente nei bisognosi. Questa è la logica, e non lo dico io, lo dice Gesù: “Quello che avete fatto a questo, a questo, a questo, lo avete fatto a me. E quello che non avete fatto a questo, a questo, a questo, non lo avete fatto a me, perché io ero lì”. Che Gesù ci insegni questa logica, questa logica della prossimità, dell’avvicinarsi a Lui, con amore, nella persona dei più sofferenti.
Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci a regnare nel servire. La Madonna, assunta in Cielo, ha ricevuto dal suo Figlio la corona regale, perché lo ha seguito fedelmente – è la prima discepola - nella via dell’Amore. Impariamo da lei a entrare fin da ora nel Regno di Dio, attraverso la porta del servizio umile e generoso. E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me”.
[Papa Francesco, Angelus 22 novembre 2020]
Ma viene a noi ogni giorno
La pagina evangelica si apre con una visione grandiosa. Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, dice: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria» (Mt 25,31). Si tratta dell’introduzione solenne del racconto del giudizio universale. Dopo aver vissuto l’esistenza terrena in umiltà e povertà, Gesù si presenta ora nella gloria divina che gli appartiene, circondato dalle schiere angeliche. L’umanità intera è convocata davanti a Lui ed Egli esercita la sua autorità separando gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre.
A quelli che ha posto alla sua destra dice: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (vv. 34-36). I giusti rimangono sorpresi, perché non ricordano di aver mai incontrato Gesù, e tanto meno di averlo aiutato in quel modo; ma Egli dichiara: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (v. 40). Questa parola non finisce mai di colpirci, perché ci rivela fino a che punto arriva l’amore di Dio: fino al punto di immedesimarsi con noi, ma non quando stiamo bene, quando siamo sani e felici, no, ma quando siamo nel bisogno. E in questo modo nascosto Lui si lascia incontrare, ci tende la mano come mendicante. Così Gesù rivela il criterio decisivo del suo giudizio, cioè l’amore concreto per il prossimo in difficoltà. E così si rivela il potere dell’amore, la regalità di Dio: solidale con chi soffre per suscitare dappertutto atteggiamenti e opere di misericordia.
La parabola del giudizio prosegue presentando il re che allontana da sé quelli che durante la loro vita non si sono preoccupati delle necessità dei fratelli. Anche in questo caso costoro rimangono sorpresi e chiedono: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?» (v. 44). Sottinteso: “Se ti avessimo visto, sicuramente ti avremmo aiutato!”. Ma il re risponderà: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me» (v. 45). Alla fine della nostra vita saremo giudicati sull’amore, cioè sul nostro concreto impegno di amare e servire Gesù nei nostri fratelli più piccoli e bisognosi. Quel mendicante, quel bisognoso che tende la mano è Gesù; quell’ammalato che devo visitare è Gesù; quel carcerato è Gesù; quell’affamato è Gesù. Pensiamo a questo.
Gesù verrà alla fine dei tempi per giudicare tutte le nazioni, ma viene a noi ogni giorno, in tanti modi, e ci chiede di accoglierlo. La Vergine Maria ci aiuti a incontrarlo e riceverlo nella sua Parola e nell’Eucaristia, e nello stesso tempo nei fratelli e nelle sorelle che soffrono la fame, la malattia, l’oppressione, l’ingiustizia. Possano i nostri cuori accoglierlo nell’oggi della nostra vita, perché siamo da Lui accolti nell’eternità del suo Regno di luce e di pace.
[Papa Francesco, Angelus 26 novembre 2017]
Spiritualità Quaresimale, e il nemico che sembra amico
Fede, Tentazioni: la nostra riuscita
(Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Lc 4,1-13)
Solo l’uomo di Dio è tentato.
Nella Bibbia la tentazione non è una sorta di pericolo o seduzione per la morte, ma un’opportunità per la vita. Anche più: un rilancio dai soliti lacci.
Quando l’esistenza fila via senza scossoni, ecco invece il ‘terremoto della lusinga’... cimento che ricolloca in bilico.
Spiritualità Quaresimale.
Nel disegno di Dio, la prova di Fede non viene per distruggere menti e vita, ma per disturbare la paludosa realtà degli obblighi contratti nella quiete del galateo conformista.
Infatti, nelle etichette non siamo noi stessi, ma un ruolo: qui è impossibile conformarci sul serio a Cristo.
Ogni periglio giunge per un salutare scossone anche d’immagine, e per smuoverci.
L’esodo stimola a fare un balzo in avanti; a non affossare l’esistenza nell’antologia dei meccanismi acritici sotto condizione.
Il passaggio è stretto e si fa pure obbligato; ferisce. Ma sperona affinché incontriamo di nuovo noi stessi, i fratelli e il mondo.
La Provvidenza incalza: ci sta educando a guardare in faccia sia ogni dettaglio che l’opzione fondamentale.
Per uscire da pericoli, ‘seduzioni’ o disturbi, siamo obbligati a guardare dentro e tirar fuori tutte le risorse, persino quelle ignote (o cui non abbiamo concesso credito).
La difficoltà e la crisi costringono a trovare soluzioni, dare spazio ai lati trascurati e in ombra; vedere bene, chiedere aiuto; informarsi, entrare in relazione qualitativa e confrontarci.
Di necessità, virtù: dopo l’attrazione e l’adescamento o la prova, il punto di vista rinnovato, ribadito da una nuova valutazione, interroga l’anima sul calibro delle scelte e sulle nostre stesse infermità.
Le situazioni malferme hanno qualcosa da dirci: vengono dagli strati profondi dell’essere, che dobbiamo incontrare - e si configurano come energie plasmabili, da investire.
Le chiamate a rivoluzionare le opinioni di sé e delle cose - le vocazioni a una ‘nuova nascita’ - non sono incitamenti al peggio, né umiliazioni spirituali.
Le “croci” e persino gli abbagli sono un territorio di doglie che guida al contatto intimo con la nostra Sorgente, che volta a volta ci ri-suscita.
L’uomo che sta sempre in ascolto del proprio Centro e permane fedele alla singolare dignità e unicità di Missione, deve però sostenere le pressioni di un genere di male che istiga solo morte.
Mt e Lc descrivono tali allettamenti (‘apparentemente amicali’, per il successo) in tre quadri simbolici:
il rapporto con le cose [pietre in pane]; con gli altri [tentazione dei regni]; con Dio [Fiducia nell’Azione del Padre].
Nelle Sacre Scritture emerge un dato curioso: le persone spiritualmente fiacche non sono mai tentate! E vale anche il viceversa.
È il modo di vivere e interiorizzare il fulmine o il tempo della Tentazione ciò che distingue la Fede dalla banalità della devozione qualsiasi.
[1.a Domenica di Quaresima, 22 febbraio 2026]
Spiritualità Quaresimale, e il nemico che sembra amico
Fede, Tentazioni: la nostra riuscita
(Mt 4,1-11; Mc 1,12-15; Lc 4,1-13)
Solo l’uomo di Dio è tentato.
Nella Bibbia la tentazione non è una sorta di pericolo o seduzione per la morte, ma un’opportunità per la vita. Anche più: un rilancio dai soliti lacci.
Ottica di Spiritualità Quaresimale:
Ogni giorno verifichiamo che un’insidia rilevante per l’esperienza della Fede sembra proprio “la fortuna”. Essa ci lega al buon fine immediato delle situazioni individuali.
Il viceversa invece fa routine: ecco il benessere, lo scampare da fallimenti e vicende infelici, la stasi dell’uguale-a-prima.
Una persona devota può perfino utilizzare la religione per sacralizzare il proprio mondo coartato, legato d’abitudini (considerate stabili).
Quindi - secondo circostanza - inserirsi anche volentieri nella pratica dei Sacramenti, purché restino parentesi che non significhino granché.
Quando l’esistenza fila via senza scossoni, ecco invece il terremoto della lusinga... cimento che ricolloca in bilico.
Nel disegno di Dio, la prova di Fede non viene per distruggere menti ed esistenza, ma per disturbare la paludosa realtà degli obblighi contratti nella quiete del galateo conformista.
Infatti, nelle etichette non siamo noi stessi, ma un ruolo: qui è impossibile conformarci sul serio a Cristo.
Ogni periglio giunge per un salutare scossone anche d’immagine, e per smuoverci.
L’Esodo stimola a fare un balzo in avanti - a non affossare l’esistenza nell’antologia dei meccanismi acritici sotto condizione, e sottoporsi ad influsso di cordate riconosciute; “utili”, ma che ci deviano la naturalezza.
Il passaggio è stretto e si fa pure obbligato; ferisce. Ma sperona affinché incontriamo di nuovo noi stessi, i fratelli, e il mondo.
La Provvidenza incalza: ci sta educando a guardare in faccia sia ogni dettaglio che l’opzione fondamentale.
Non cresciamo né maturiamo assestando l’anima sulle opinioni di tutti e mettendoci seduti in situazioni maggioritarie, abitudinarie, “perbene”, supposte veraci. Eppure poco spontanee, prive di trasparenza e di reciprocità col nostro Eros fondante.
Neppure diventiamo adulti abbracciando atletismi ascetici, o più facili scorciatoie di massa, di ceto, di cricche, o branco - che rendono esterni.
Per uscire da pericoli, seduzioni, disturbi, siamo obbligati a guardare dentro e tirar fuori tutte le risorse, persino quelle ignote o cui non abbiamo concesso credito.
La difficoltà e la crisi costringono a trovare soluzioni, dare spazio ai lati trascurati, in ombra; vedere bene e chiedere aiuto; informarsi, entrare in relazione qualitativa, e confrontarci a partire da dentro.
Di necessità, virtù: dopo l’attrazione e l’adescamento o la prova, il punto di vista rinnovato e ribadito da una nuova valutazione interroga l’anima sul calibro delle scelte - sulle nostre stesse infermità.
Esse stesse hanno qualcosa da dirci: vengono dagli strati profondi dell’essere, che dobbiamo incontrare - per non rimanere dissociati. E si configurano come energie plasmabili, poi da investire.
Le chiamate a rivoluzionare le opinioni di sé e delle cose - le vocazioni a una nuova nascita - non sono incitamenti ad annientare il proprio mondo di rapporti, o stimoli al peggio, né umiliazioni spirituali.
Le “croci” e persino gli abbagli sono un territorio di doglie che guida al contatto intimo con la nostra Sorgente - che volta a volta ci ri-suscita con nuove genesi, con differenti nascite.
L’uomo che sta sempre in ascolto del proprio centro e permane fedele alla singolare dignità e unicità di Missione, deve però sostenere le pressioni di una fattispecie di male che istiga solo morte.
Mt e Lc descrivono tali allettamenti apparentemente amicali, ovvero per il successo, in tre quadri simbolici:
Ecco il rapporto con le cose [pietre in pane]; con gli altri [tentazione dei regni]; con Dio [sulla Fiducia nell’Azione del Padre].
Le pietre in pane: la vita del Signore stesso ci dice che è meglio venire sconfitti che star bene per averla sfangata.
È sotto accusa il modo elusivo - anche pio, inerte, senza presa diretta - di porsi in relazione con le realtà materiali.
La persona anche religiosa ma vuota, si limita a dare o recepire indicazioni, o allettare con effetti speciali.
Fa uso del prestigio e delle proprie qualità e titoli, quasi per sfuggire le difficoltà che possono infastidirlo, coinvolgerlo in radice.
La persona di Fede è invece non solo empatica e solidale nella forma, bensì fraterna e autentica.
Non si mantiene a sicura distanza dai problemi, né da ciò che non sa; fa Esodo sul serio. Pagandolo.
Sente l'impulso a percorrere il duro cammino fianco a fianco di se stesso (in verità profonda) e con gli altri, senza calcolo o privilegi.
Né mette in campo risorse unicamente in proprio favore - staccandosi e ripiegandosi, o arrangiandosi; barcamenandosi, adeguandosi al club dei conformisti da zona relax e finte sicurezze.
Tentazione dei regni. La [nostra] controparte non sta esagerando (Mt 4,9; Lc 4,6): la logica che governa il regno idolatrico non ha nulla a che vedere con Dio.
Prendere, salire, comandare; arraffare, apparire, soggiogare: sono i modi peggiori di rapportarsi con gli altri, che sembra stiano lì solo per utilità, e fare da sgabelli, o seccarci.
La brama del potere è così irrefrenabile, tanto capace di sedurre, da sembrare attributo specifico della condizione divina: stare in alto.
Sebbene potesse fare carriera, Gesù non ha voluto confonderci dirigendo, ma accorciando le distanze.
Nella storia, purtroppo, diversi ecclesiastici non hanno avuto idee chiare. Scambiando volentieri il grembiule del servizio e l’asciugatoio dei nostri piedi con la poltrona strappata e una carica agognata.
Idoli fantoccio cui non bisognava rendere culto.
La tentazione finale - l’apice della “garanzia di protezione” del Tempio - sembra come le altre un banale consiglio a nostro favore. Anche per la “riuscita” nella relazione con Dio - dopo quella con le cose e la gente.
Ma qui è in gioco la piena Fiducia nell’Azione del Padre. Egli trasmette vita, senza posa rafforza e dilata il nostro essere.
Anche nelle opportunità che paiono meno appetibili, il Creatore incessantemente genera occasioni di completezza e realizzazione più genuina, che rielaborate senza isterismi accentuano l’onda vitale.
Egli preme in modo crescente, affinché i canoni vengano valicati. E l’essere creaturale traspaia. Lì c’è un segreto, un Mistero, una destinazione che si annidano.
La Sua è una spinta ben altro che piantata sullo spettacolo-miracolo, o sull’assicurazione sacrale [che poi scantona da approfondimenti sgraditi e rischi azzardati].
Nelle Sacre Scritture emerge un dato curioso: le persone spiritualmente fiacche non sono mai tentate! E vale anche il viceversa.
È il modo di vivere e interiorizzare il fulmine o il tempo della Tentazione ciò che distingue la Fede dalla banalità della devozione qualsiasi.
Itinerario spirituale: perché?
Cari fratelli e sorelle!
Questa è la Prima Domenica di Quaresima, il Tempo liturgico di quaranta giorni che costituisce nella Chiesa un itinerario spirituale di preparazione alla Pasqua. Si tratta in sostanza di seguire Gesù che si dirige decisamente verso la Croce, culmine della sua missione di salvezza. Se ci domandiamo: perché la Quaresima? perché la Croce?, la risposta, in termini radicali, è questa: perché esiste il male, anzi, il peccato, che secondo le Scritture è la causa profonda di ogni male. Ma questa affermazione non è affatto scontata, e la stessa parola “peccato” da molti non è accettata, perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell’uomo. In effetti è vero: se si elimina Dio dall’orizzonte del mondo, non si può parlare di peccato. Come quando si nasconde il sole, spariscono le ombre; l’ombra appare solo se c’è il sole; così l’eclissi di Dio comporta necessariamente l’eclissi del peccato. Perciò il senso del peccato – che è cosa diversa dal “senso di colpa” come lo intende la psicologia – si acquista riscoprendo il senso di Dio. Lo esprime il Salmo Miserere, attribuito al re Davide in occasione del suo duplice peccato di adulterio e di omicidio: “Contro di te – dice Davide rivolgendosi a Dio – contro te solo ho peccato” (Sal 51,6).
Di fronte al male morale, l’atteggiamento di Dio è quello di opporsi al peccato e salvare il peccatore. Dio non tollera il male, perché è Amore, Giustizia, Fedeltà; e proprio per questo non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Per salvare l’umanità, Dio interviene: lo vediamo in tutta la storia del popolo ebraico, a partire dalla liberazione dall’Egitto. Dio è determinato a liberare i suoi figli dalla schiavitù per condurli alla libertà. E la schiavitù più grave e più profonda è proprio quella del peccato. Per questo Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo: per liberare gli uomini dal dominio di Satana, “origine e causa di ogni peccato”. Lo ha mandato nella nostra carne mortale perché diventasse vittima di espiazione, morendo per noi sulla croce. Contro questo piano di salvezza definitivo e universale, il Diavolo si è opposto con tutte le forze, come dimostra in particolare il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto, che viene proclamato ogni anno nella Prima Domenica della Quaresima. Infatti, entrare in questo Tempo liturgico significa ogni volta schierarsi con Cristo contro il peccato, affrontare – sia come singoli, sia come Chiesa – il combattimento spirituale contro lo spirito del male (Mercoledì delle Ceneri, Orazione Colletta).
Invochiamo perciò il materno aiuto di Maria Santissima per il cammino quaresimale da poco iniziato, perché sia ricco di frutti di conversione.
[Papa Benedetto, Angelus 13 marzo 2011]
Possa il Millennio
Io sarò con voi fino alla fine dei tempi (cfr Mt 28,20)
Fratelli e Sorelle!
1. La celebrazione della Quaresima, tempo di conversione e di riconciliazione, assume in questo anno un carattere del tutto particolare, perché si iscrive nel Grande Giubileo del 2000. Il tempo quaresimale rappresenta infatti il punto culminante di quel cammino di conversione e di riconciliazione che il Giubileo, anno di grazia del Signore, propone a tutti i credenti per rinnovare la propria adesione a Cristo ed annunciare con rinnovato ardore il suo mistero di salvezza nel nuovo millennio. La Quaresima aiuta i cristiani a penetrare più profondamente questo "mistero nascosto da secoli" (Ef 3, 9): li porta a confrontarsi con la Parola del Dio vivente e chiede loro di rinunciare al proprio egoismo per accogliere l'azione salvifica dello Spirito Santo.
2. Eravamo morti per il peccato (cfr Ef 2, 5): così san Paolo descrive la situazione dell'uomo senza Cristo. Ecco perché il Figlio di Dio ha voluto unirsi alla natura umana riscattandola dalla schiavitù del peccato e della morte.
E’ una schiavitù che l’uomo sperimenta quotidianamente, avvertendone le radici profonde nel suo stesso cuore (cfr Mt 7,11). Talora essa si manifesta in forme drammatiche ed inusitate, come è avvenuto nel corso delle grandi tragedie del secolo XX, che hanno profondamente inciso nella vita di tante comunità e persone, vittime di crudele violenza. Deportazioni forzate, eliminazione sistematica di popoli, disprezzo dei diritti fondamentali della persona sono le tragedie che ancora oggi purtroppo umiliano l'umanità. Anche nella vita quotidiana, si manifestano svariate forme di prevaricazione, di odio, di annichilamento dell'altro, di menzogna di cui l'uomo è vittima ed autore. L'umanità è segnata dal peccato. La sua drammatica condizione richiama alla mente il grido allarmato dell’Apostolo delle genti: "Non c'è nessun giusto, nemmeno uno" (Rm 3, 10; cfr Sal 13,3).
3. Di fronte all'oscurità del peccato ed all'impossibilità per l'uomo di liberarsi da solo, appare in tutto il suo splendore l'opera salvifica di Cristo: "Dio lo ha prestabilito a servire come strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine di manifestare la sua giustizia" (Rm 3, 25). Cristo è l'Agnello che ha preso su di sé il peccato del mondo (cfr Gv 1, 29). Egli ha condiviso l'umana esistenza "fino alla morte e alla morte di croce" (Fil 2,8), per riscattare l'uomo dalla schiavitù del male e reintegrarlo nella sua originaria dignità di figlio di Dio. Ecco il mistero pasquale nel quale siamo rinati! Qui, come ricorda la Sequenza pasquale, "Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello". I Padri della Chiesa affermano che, in Gesù Cristo, il demonio attacca tutta l'umanità e la insidia con la morte, dalla quale però essa viene liberata grazie alla forza vittoriosa della risurrezione. Nel Signore risorto si spezza il potere della morte e all'uomo è offerta la possibilità, mediante la fede, di accedere alla comunione con Dio. A chi crede viene data la vita stessa di Dio, mediante l’azione dello Spirito Santo, "primo dono ai credenti" (Preghiera Eucaristica IV). La redenzione realizzata sulla croce rinnova così l'universo ed attua la riconciliazione tra Dio e l'uomo e degli uomini tra loro.
4. Il Giubileo è il tempo di grazia in cui siamo invitati ad aprirci in maniera particolare alla misericordia del Padre, che nel Figlio si è chinato sull'uomo, ed alla riconciliazione, grande dono di Cristo. Quest’anno, pertanto, deve diventare per i cristiani, ma anche per ogni uomo di buona volontà, un momento prezioso per sperimentare la forza rinnovatrice dell'amore di Dio che perdona e riconcilia. Dio offre la sua misericordia a chiunque la voglia accogliere, anche se lontano e dubbioso. All'uomo di oggi, stanco di mediocrità e di false illusioni, è offerta così la possibilità di intraprendere la via di una vita in pienezza. In tale contesto, la Quaresima dell'Anno Santo 2000 costituisce per eccellenza "il momento favorevole, il giorno della salvezza" (2 Cor 6, 2), l'occasione particolarmente propizia per "lasciarsi riconciliare con Dio" (2 Cor 5, 20).
Durante l'Anno Santo la Chiesa offre varie opportunità di riconciliazione personale e comunitaria. Ogni Diocesi ha indicato dei luoghi speciali, ove i credenti possono recarsi per sperimentare una particolare presenza di Dio riconoscendo alla sua luce il proprio peccato e per intraprendere, grazie al sacramento della Riconciliazione, un nuovo cammino di vita. Un significato particolare riveste il pellegrinaggio in Terra Santa e a Roma, luoghi privilegiati dell'incontro con Dio, per il loro singolare ruolo nella storia della salvezza. Come non incamminarsi, almeno spiritualmente, verso la Terra che, duemila anni or sono, ha visto il passaggio del Signore? Là "il Verbo si è fatto carne" (Gv 1, 14) ed è "cresciuto" in "sapienza, età e grazia" (Lc 2, 52); là "percorreva tutte le città e i villaggi,… predicando il vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità" (Mt 9, 35); là ha portato a compimento la missione affidatagli dal Padre (cfr Gv 19,30) ed ha effuso lo Spirito Santo sulla Chiesa nascente (cfr Gv 20, 22).
Anch'io mi riprometto, proprio nella Quaresima del 2000, di farmi pellegrino nella terra del Signore, alle sorgenti della nostra fede, per celebrarvi il Giubileo bimillenario dell’Incarnazione. Invito ogni cristiano ad accompagnarmi con la preghiera mentre, nelle varie tappe del pellegrinaggio, invocherò il perdono e la riconciliazione per i figli della Chiesa e per l'umanità intera.
5. L'itinerario della conversione conduce a riconciliarsi con Dio e a vivere in pienezza la vita nuova in Cristo. Vita di fede, di speranza e di carità. Queste tre virtù, dette "teologali" perché si riferiscono direttamente a Dio nel suo mistero, sono state oggetto di speciale approfondimento nel triennio di preparazione al Grande Giubileo. La celebrazione dell’Anno Santo richiede ora ad ogni cristiano di vivere e di testimoniare tali virtù in maniera più piena e consapevole.
La grazia del Giubileo spinge innanzitutto a rinnovare la fede personale. Essa consiste nell'adesione all'annuncio del mistero pasquale, attraverso cui il credente riconosce che in Cristo morto e risorto gli è data la salvezza; rimette a lui quotidianamente la propria vita; accoglie quanto il Signore dispone per lui, nella certezza che Dio lo ama. La fede è il "sì" dell'uomo a Dio, il suo "Amen".
Figura esemplare del credente per Ebrei, Cristiani e Musulmani è Abramo: fiducioso nella promessa, egli segue la voce di Dio che lo chiama per sentieri sconosciuti. La fede aiuta a scoprire i segni della presenza amorosa di Dio nella creazione, nelle persone, negli eventi della storia e, soprattutto, nell'opera e nel messaggio di Cristo, spingendo l'uomo a guardare oltre se stesso, oltre le apparenze verso quella trascendenza dove si dischiude il mistero dell'amore di Dio per ogni creatura.
Con la grazia del Giubileo il Signore ci invita, altresì, a ridestare la nostra speranza. In Cristo, infatti, il tempo stesso è redento e si apre ad una prospettiva di gioia senza fine e di comunione piena con Dio. Il tempo del cristiano è segnato dall'attesa delle nozze eterne, anticipate quotidianamente nel banchetto eucaristico. Con lo sguardo rivolto ad esse, "lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!" (Ap 22, 17), alimentando la speranza che sottrae il tempo alla pura ripetitività e gli conferisce il suo senso autentico. Con la virtù della speranza, il cristiano testimonia che, al di là di ogni male e di ogni limite, la storia reca in sé un germe di bene che il Signore farà germogliare in pienezza. Egli guarda, pertanto, al nuovo millennio senza paura, ma affronta le sfide e le attese del futuro con la fiduciosa certezza che nasce dalla fede nella promessa del Signore.
Con il Giubileo il Signore ci chiede, infine, di riaccendere la nostra carità. Il Regno, che Cristo manifesterà nel suo pieno splendore alla fine dei tempi, è già presente là dove gli uomini vivono secondo la volontà di Dio. La Chiesa è chiamata a testimoniare la comunione, la pace e la carità che lo contraddistinguono. In questa missione, la comunità cristiana sa che la fede senza le opere è morta (cfr Gc 2, 17). Così, mediante la carità, il cristiano rende visibile l'amore di Dio per gli uomini rivelato in Cristo e rende manifesta la sua presenza nel mondo "fino alla fine dei tempi". La carità per il cristiano non è soltanto un gesto, o un ideale, ma è, per così dire, il prolungamento della presenza di Cristo che dona se stesso.
In occasione della Quaresima, tutti - ricchi o poveri - sono invitati a rendere presente l'amore di Cristo con generose opere di carità. In quest'anno giubilare la nostra carità è chiamata, in modo particolare, a manifestare l'amore di Cristo ai fratelli che mancano del necessario per vivere, a quanti sono vittime della fame, della violenza e dell'ingiustizia. E' questo il modo per attualizzare le istanze di liberazione e di fraternità già presenti nella Sacra Scrittura, che la celebrazione dell'Anno Santo ripropone. L'antico giubileo ebraico, infatti, esigeva di liberare gli schiavi, di rimettere i debiti, di soccorrere i poveri. Oggi nuove schiavitù e più drammatiche povertà colpiscono moltitudini di persone, specie in Paesi del cosiddetto Terzo Mondo. E' un grido di dolore e di disperazione che deve trovare attenti e disponibili quanti intraprendono il cammino giubilare. Come possiamo chiedere la grazia del Giubileo se siamo insensibili alle necessità dei poveri, se non ci impegniamo a garantire a tutti i mezzi necessari per vivere dignitosamente?
Possa il millennio che inizia essere un'epoca nella quale finalmente l’appello di tanti uomini, nostri fratelli, che non possiedono il minimo per vivere, trovi ascolto e fraterna accoglienza. Auspico che i cristiani, ai diversi livelli, si facciano promotori di iniziative concrete per assicurare un’equa distribuzione dei beni e la promozione umana integrale per ciascun individuo.
6. "Io sarò con voi fino alla fine dei tempi". Queste parole di Gesù ci assicurano che nell'annunciare e vivere il vangelo della carità non siamo soli. Anche in questa Quaresima dell'Anno 2000 Egli ci invita a tornare al Padre, che ci aspetta con le braccia aperte, per trasformarci in segni viventi ed efficaci del suo amore misericordioso.
A Maria, Madre di ogni sofferente e Madre della divina Misericordia, affidiamo le nostre intenzioni ed i nostri propositi. Sia Lei la stella luminosa del nostro cammino nel nuovo millennio.
Con tali auspici, invoco su tutti la benedizione di Dio, Uno e Trino, principio e fine di tutte le cose, al quale "fino alla fine dei tempi" si eleva l'inno di benedizione e di lode: "Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen".
Da Castel Gandolfo, 21 settembre 1999.
[Papa Giovanni Paolo II, Messaggio per la Quaresima 2000]
Gesù entra in “quaresima”
In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo (cfr Mt 4,1-11) racconta che Gesù, dopo il battesimo nel fiume del Giordano, «fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo» (v. 1). Egli si prepara a cominciare la sua missione di annunciatore del Regno dei cieli e, come già Mosè ed Elia (cfr Es 24,18; 1 Re 19,8), nell’Antico Testamento, lo fa con un digiuno di quaranta giorni. Entra in “quaresima”.
Al termine di questo periodo di digiuno, irrompe il tentatore, il diavolo, che cerca per tre volte di mettere in difficoltà Gesù. La prima tentazione prende spunto dal fatto che Gesù ha fame; il diavolo gli suggerisce: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane» (v. 3). Una sfida. Ma la risposta di Gesù è netta: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”» (4,4). Egli si richiama a Mosè, quando ricorda al popolo il lungo cammino compiuto nel deserto, in cui ha imparato che la sua vita dipende dalla Parola di Dio (cfr Dt 8,3).
Poi il diavolo fa un secondo tentativo, (cfr vv. 5-6) si fa più astuto, citando anch’egli la Sacra Scrittura. La strategia è chiara: se tu hai tanta fiducia nella potenza di Dio, allora sperimentala, infatti la Scrittura stessa afferma che sarai soccorso dagli angeli (cfr v. 6). Ma anche in questo caso Gesù non si lascia confondere, perché chi crede sa che Dio non lo si mette alla prova, ma ci si affida alla sua bontà. Perciò alle parole della Bibbia, strumentalmente interpretate da satana, Gesù risponde con un’altra citazione: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”» (v. 7).
Infine, il terzo tentativo (cfr vv. 8-9) rivela il vero pensiero del diavolo: poiché la venuta del Regno dei cieli segna l’inizio della sua sconfitta, il maligno vorrebbe distogliere Gesù dal portare a compimento la sua missione, offrendogli una prospettiva di messianismo politico. Ma Gesù respinge l’idolatria del potere e della gloria umana e, alla fine, scaccia il tentatore dicendogli: «Vattene, Satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”» (v. 10). E a questo punto, presso Gesù, fedele alla consegna del Padre, si avvicinarono degli angeli per servirlo (cfr v. 11).
Questo ci insegna una cosa: Gesù non dialoga con il diavolo. Gesù risponde al diavolo con la Parola di Dio, non con la sua parola. Nella tentazione tante volte noi incominciamo a dialogare con la tentazione, a dialogare con il diavolo: “Sì, ma io posso fare questo…, poi mi confesso, poi questo, quell’altro…”. Mai dialogare con il diavolo. Gesù fa due cose con il diavolo: lo scaccia via o, come in questo caso, risponde con la Parola di Dio. State attenti: mai dialogare con la tentazione, mai dialogare con il diavolo.
Anche oggi Satana irrompe nella vita delle persone per tentarle con le sue proposte allettanti; mescola la sua alle tante voci che cercano di addomesticare la coscienza. Da più parti arrivano messaggi che invitano a “lasciarsi tentare” per sperimentare l’ebbrezza della trasgressione. L’esperienza di Gesù ci insegna che la tentazione è il tentativo di percorrere vie alternative a quelle di Dio: “Ma, fai questo, non c’è problema, poi Dio perdona! Ma un giorno di gioia prenditelo…” – “Ma è peccato!” – “No, non è niente”. Vie alternative, vie che ci danno la sensazione dell’autosufficienza, del godimento della vita fine a sé stesso. Ma tutto ciò è illusorio: ben presto ci si rende conto che più ci allontaniamo da Dio, più ci sentiamo indifesi e inermi di fronte ai grandi problemi dell’esistenza.
La Vergine Maria, la Madre di Colui che ha schiacciato il capo al serpente, ci aiuti in questo tempo di Quaresima ad essere vigilanti di fronte alle tentazioni, a non sottometterci ad alcun idolo di questo mondo, a seguire Gesù nella lotta contro il male; e riusciremo anche noi vincitori come Gesù.
[Papa Francesco, Angelus 1 marzo 2020]
Ma può partecipare al rito?
La Conversione, le cose proibite e il Medico degli opposti
(Lc 5,27-32)
Nell’epoca in cui Lc redige il suo Vangelo (subito dopo metà anni 80) la comunità di pagani convertiti a Cristo di Efeso era pervasa da vive tentazioni e segnata da defezioni.
In aggiunta, nel dibattito interno di chiesa sorge un interrogativo sul genere di partecipazione ammissibile alle riunioni, e lo Spezzare il Pane.
L’evangelista narra l’episodio di «Levi», evitando di chiamarlo semplicemente Matteo - quasi ad accentuare la sua derivazione, semitica e paradossalmente cultuale.
Così Lc vuole descrivere come Gesù stesso aveva affrontato il medesimo conflitto: senz’alcuna attenzione rituale o sacrale, se non all’uomo.
Insomma, secondo il Maestro, nel cammino di Fede il rapporto coi lontani, diversi, e i nostri stessi disagi o abissi reconditi, hanno qualcosa da dirci.
Il Padre è Presenza amica. La sua iniziativa di vita salvata è per tutti, anche per chi non sa far altro che badare ai suoi registri.
Ciò sminuisce e supera l’ossessione di peccato che le religioni ritenevano barriera insuperabile per la comunione con Dio - marchiando la vita.
La Lieta Notizia è che l’Eucaristia (v.29) non è un premio per i meriti (v.30).
Mangiare insieme era segno di condivisione preziosa, anche sul piano religioso. Nei conviti, gli osservanti evitavano il contatto con i membri peccatori del loro stesso popolo.
Tutti invece sono chiamati e ciascuno può rinascere, addirittura superando i puri.
Quindi mettersi fra i peccatori non è una disfatta, bensì verità. E il peccato stesso non è più solo una deviazione da correggere.
Per questo la figura del nuovo Maestro toccava il cuore della gente: portava il segno della Grazia; la comunione ai perduti e colpevoli.
Ma con tali gesti il Figlio sembrava si mettesse al posto di Dio (v.30).
Infatti il Padre ci coglie senza steccati, nel punto in cui siamo: non bada alla condizione sociale e alla provenienza.
Fra i discepoli è probabile che ci fossero non pochi membri della resistenza palestinese [guerriglieri che lottavano contro gli occupanti romani].
Per contro, qui Gesù chiama un collaborazionista che si lasciava guidare dal vantaggio.
Come dire: la Comunità nuova dei figli e fratelli non coltiva privilegi, separazioni, oppressioni, odi.
Il Maestro si è sempre tenuto al di sopra degli urti politici, delle distinzioni ideologiche e delle dispute corrive del suo tempo.
Nella sua Chiesa c’è un segno forte di discontinuità.
Egli non invita alla sequela i migliori o i peggiori, ma gli opposti - anche della nostra personalità. Vuole disporci «a conversione» (v.32): farci cambiare punto di vista, mentalità, princìpi, modo di essere.
In tale avventura non siamo chiamati a forme di dissociazione: si parte da se stessi.
In tal guisa Gesù inaugura un nuovo tipo di relazioni, anche dentro di noi. Un’Alleanza Nuova, di feconde divergenze.
E Crea tutto la sola Parola «Segui Me» (v.27) [non altri].
Pertanto, in questa Quaresima possiamo mettere fra parentesi l’idea di appartenenza; per contare solo su Dio, rompere le barriere, e fare Festa.
Non è la ‘perfezione’ che ci fa amare l’Esodo.
[Sabato dopo le Ceneri, 21 febbraio 2026]
La Conversione, le cose proibite e il Medico degli opposti
Ma può partecipare al rito?
(Lc 5,27-32)
«Gesù non esclude nessuno dalla propria amicizia. Il buon annuncio del Vangelo consiste proprio in questo: nell’offerta della grazia di Dio al peccatore! Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello di accoglienza della misericordia di Dio e lasciarne intravedere i meravigliosi effetti nella propria esistenza».
[Papa Benedetto, Udienza Generale 30 agosto 2006]
Nell’epoca in cui Lc redige il suo Vangelo (subito dopo metà anni 80) la comunità di pagani convertiti a Cristo di Efeso era pervasa da vive tentazioni e segnata da defezioni.
In aggiunta, nel dibattito interno di chiesa sorge un interrogativo sul genere di partecipazione ammissibile alle riunioni, e lo Spezzare il Pane.
L’evangelista narra l’episodio di «Levi», evitando di chiamarlo semplicemente Matteo - quasi ad accentuare la sua derivazione, semitica e paradossalmente cultuale.
Così Lc vuole descrivere come Gesù stesso aveva affrontato il medesimo conflitto: senz’alcuna attenzione rituale o sacrale, se non all’uomo.
Insomma, secondo il Maestro, nel cammino di Fede il rapporto coi lontani e diversi, e i nostri stessi disagi o abissi reconditi, hanno qualcosa da dirci.
Il Padre è Presenza amica. La sua iniziativa di vita salvata è per tutti, anche per chi non sa far altro che badare ai suoi registri.
Ciò sminuisce e supera l’ossessione di peccato che le religioni ritenevano barriera insuperabile per la comunione con Dio - marchiando la vita.
La Lieta Notizia di tale pericope è che la Comunione non è gratificazione, né un riconoscimento.
L’Eucaristia (v.29) non è un premio per i meriti (v.30), né un discrimine a favore di emarginazioni sacrali o adultoidi.
Mangiare insieme era segno di condivisione preziosa, anche sul piano religioso. Così, nei conviti gli osservanti evitavano il contatto con i membri ritenuti peccatori.
Tutti invece sono chiamati e ciascuno può rinascere, addirittura superando i puri.
Quindi mettersi fra i peccatori non è una disfatta, bensì verità. E il peccato stesso non è più solo una deviazione da correggere.
Per questo la figura del nuovo Maestro toccava il cuore della gente: portava il segno della Grazia; la comunione ai perduti e colpevoli.
Ma con tali gesti il Figlio sembrava si mettesse al posto di Dio (v.30).
Insomma, il Padre ci coglie senza steccati, nel punto in cui siamo: non bada alla condizione sociale e alla provenienza.
Fra i discepoli è probabile che ci fossero non pochi membri della resistenza palestinese, che avversavano gli occupanti romani.
Per contro, qui Gesù chiama un collaborazionista, e che si lasciava guidare dal vantaggio.
Come dire: la Comunità nuova dei figli e fratelli non coltiva privilegi, separazioni, oppressioni, odi.
Il Maestro si è sempre tenuto al di sopra degli urti politici, delle distinzioni ideologiche e delle dispute corrive del suo tempo.
Nella sua Chiesa c’è un segno forte di discontinuità con le religioni: la proibizione dev’essere sostituita dall’amicizia.
Gli stessi apostoli non furono chiamati alla medesima e rigorosa prassi di segregazione e divisione tipica delle credenze etnico-puriste, che vigeva attorno a loro [e si credeva rispecchiasse l’ordine stabilito da Dio sulla terra].
Ancora oggi il Signore non invita alla sequela i migliori o i peggiori, ma gli opposti. Principio che vale anche per la vita intima.
Il recupero di lati contrapposti anche della nostra personalità, ci dispone «a conversione» (v.32): non a riassestare il mondo del Tempio, ma a farci cambiare punto di vista, mentalità, princìpi, modo di essere.
Non è la perfezione religiosa che fa amare l’esodo.
Insomma, la proibizione dev’essere sostituita dall’amicizia. L’intransigenza va soppiantata dall’indulgenza; la durezza dalla condiscendenza.
In tale avventura non siamo chiamati a forme di dissociazione: si parte da se stessi.
Così giungiamo senza isterismi alle microrelazioni - e senza cariche ideologiche, alla mentalità corrente anche devota.
Mai più mète fasulle, obbiettivi superficiali, ossessioni e ragionamenti inutili, né abitudini meccaniche, antiche o altrui, mai rielaborate in sé.
Con a monte tale esperienza di scavo e immedesimazione interiore, donne e uomini di Fede devono condividere la vita con chiunque - persino coi noti trasgressori come il pubblicano, rivedendosi in loro.
E deponendo gli artifici: senza prima pretendere patente alcuna, né lunghe discipline dell’arcano o pie pratiche che celebrino distacchi [come le abluzioni che precedevano il pasto].
Nel testo parallelo di Mt 9,9-13 l’esattore è chiamato esplicitamente per nome: Matteo, a sottolineare i medesimi contenuti e l’identico richiamo verso le assemblee di credenti.
Matathiah significa «uomo di Dio», «dato da Dio»; precisamente «Dono di Dio» (Matath-Yah) [malgrado la rabbia delle autorità ufficiali].
Secondo l’insegnamento diretto dello stesso Gesù - persino nei confronti di uno degli apostoli - l’unica impurità è quella di non dare spazio a chi lo chiede perché non ne ha.
Il Signore vuole comunione integrale coi peccatori, e che li si tratti da fratelli - membri a pieno titolo della stessa Famiglia di Dio - non a motivo d’una banalità buonista: è l’invito a riconoscersi.
Non per sottometterci a qualche paternalismo umiliante, ma perché lasciarsi trasformare da poveri o ricchi in signori, è una risorsa.
«E Levi fece un gran banchetto per lui nella sua casa; e c’era molta folla di pubblicani e di altri che erano adagiati [a mensa] con loro» (Lc 5,29 testo greco).
«Erano adagiati»: secondo il modo di celebrare i banchetti solenni, da parte degli uomini liberi - ormai tutti liberi.
Che meraviglia, un ostensorio del genere! Un Corpo vivo di Cristo che profuma di concreta Unione, convivialità delle differenze - non di respingimenti artificiosi, per trasgressione!
È questa tutta empatica e regale la bella consapevolezza che spiana e rende credibile il contenuto dell’Annuncio (v.31) - sebbene urti la suscettibilità dei maestri ufficiali.
D’ora in poi, la ripartizione fra credenti o meno sarà assai più umanizzante che fra “rinati” e non, o puri e impuri.
Tutta un’altra caratura - principio di una vita da salvati che si dispiega e straripa oltre i vari club [all’antica o patinati che siano].
Cristo chiama, accoglie e redime anche il Levi in noi, ossia il lato più rubricista - o logoro - della nostra personalità.
Anche il nostro carattere insopportabile o giustamente odiato: quello rigido e quello - altrettanto nostro - da gabelliere.
Reintegrando i versanti opposti, li farà addirittura fiorire: diverranno aspetti inclusivi, irrinunciabili, alleati e intimamente vincenti della futura testimonianza, potenziata d’amore genuino.
Essere considerati forti, capaci di comandare, osservanti, eccellenti, incontaminati, magnifici, performanti, straordinari, gloriosi, indefettibili… danneggia le persone.
Ci mette una maschera, rende unilaterali; toglie la comprensione.
Fa galleggiare il personaggio in cui siamo seduti, al di sopra della realtà.
Per la crescita e fioritura di ciascuno, più importante di vincere sempre è imparare ad accogliere, cedere fino a capitolare; farsi considerare manchevoli, inadeguati.
Dice il Tao Tê Ching [XLV]: «La grande dirittura è come sinuosità, la grande abilità è come inettitudine, la grande eloquenza è come balbettio».
La norma artificiosa (purtroppo, talora anche la guida poco accorta) ci fa vivere in funzione del successo e della gloria esterna, ottenuta attraverso compartimenti.
Gesù inaugura un nuovo tipo di relazioni, e “patti” di feconde divergenze - un’Alleanza Nuova, anche dentro noi.
Qui Crea tutto la sola Parola «Segui Me» (v.14) [non “altri”].
Pertanto, in questa Quaresima possiamo mettere fra parentesi l’idea scontata di purità, e le appartenenze.
Tutto ciò per contare solo su Dio, rompere le barriere, metterci al banchetto degli emarginati (dall’ordine “adeguato” stabilito sulla terra).
E fare festa.
La Sapienza del Maestro e l’arte poliedrica della Natura [appena esemplificata nella saggezza cristallina del Tao] conducono tutti a essere incisivi e umani.
Non è la perfezione che ci fa amare l’esodo.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Qual è il tuo punto di forza spirituale e umana? Come si è generato?
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.